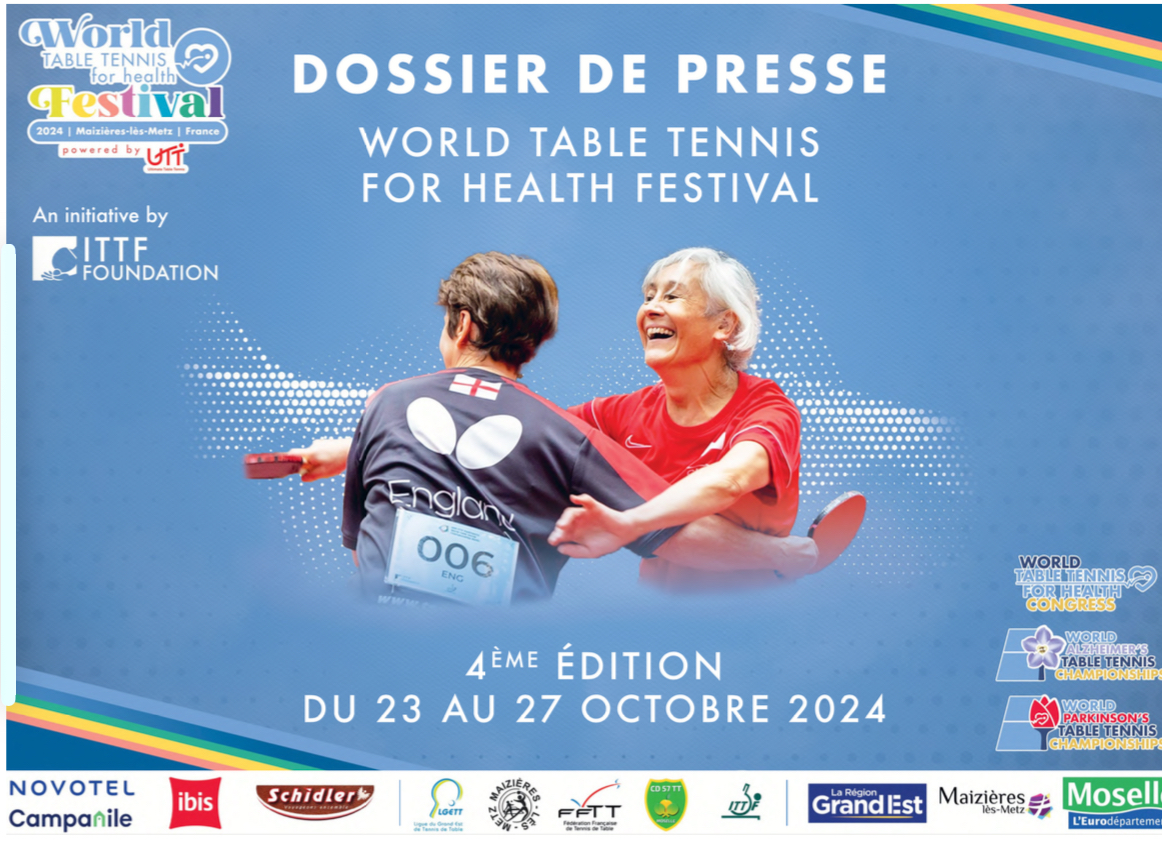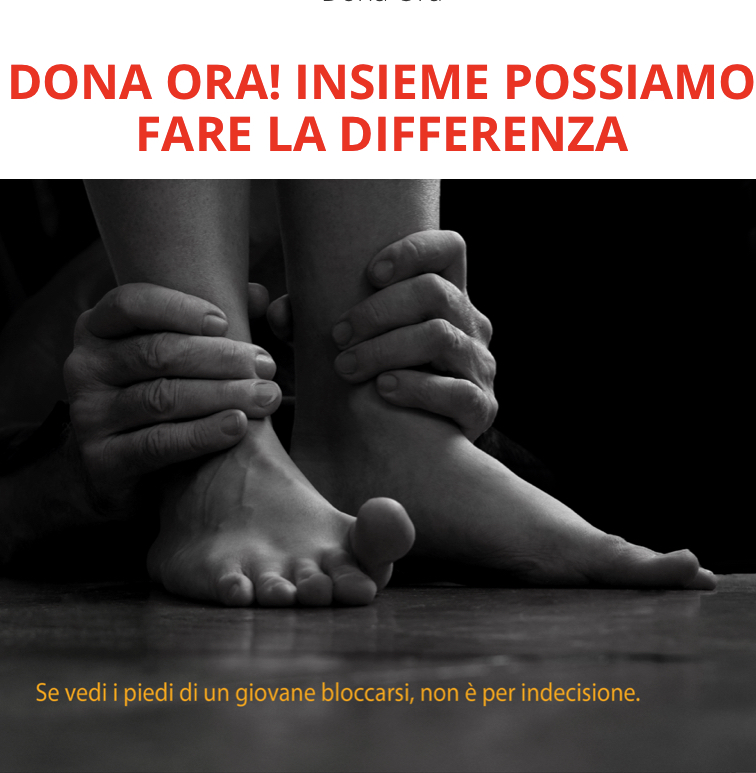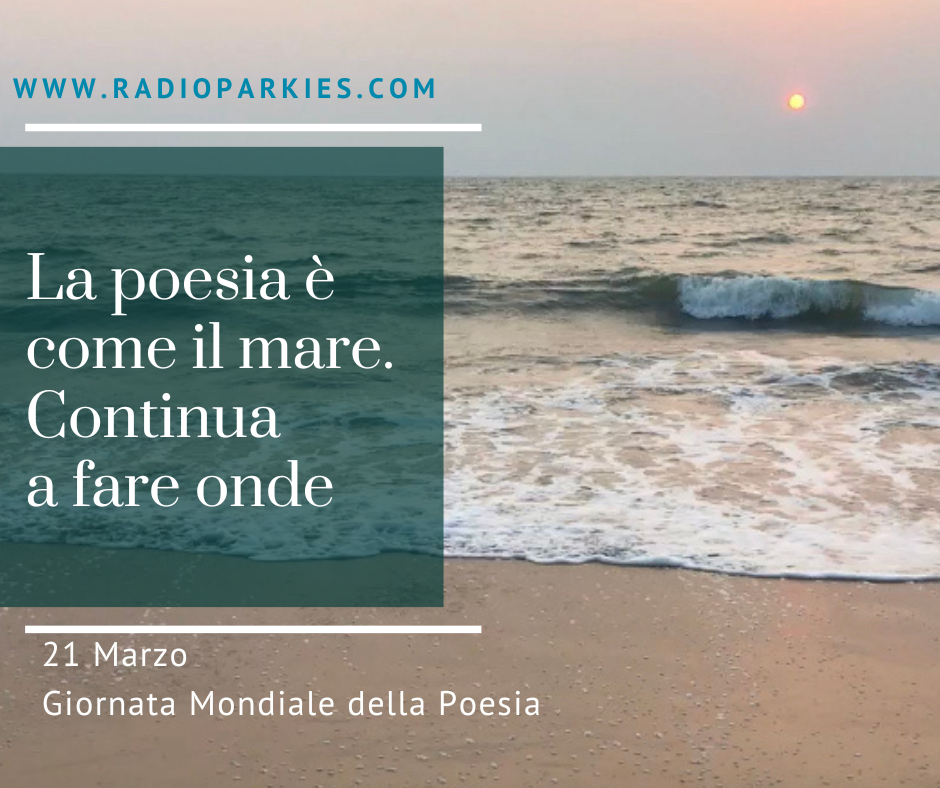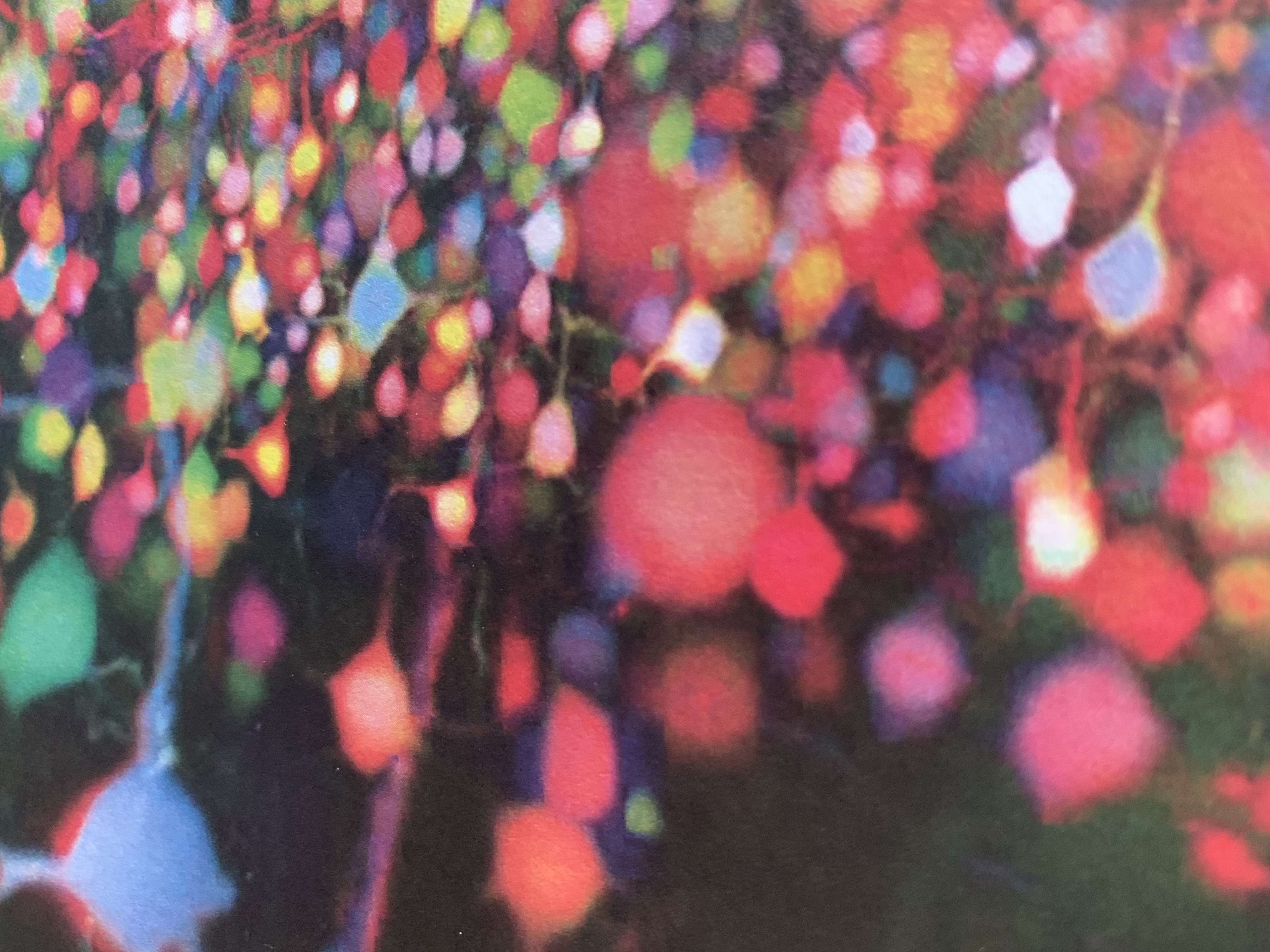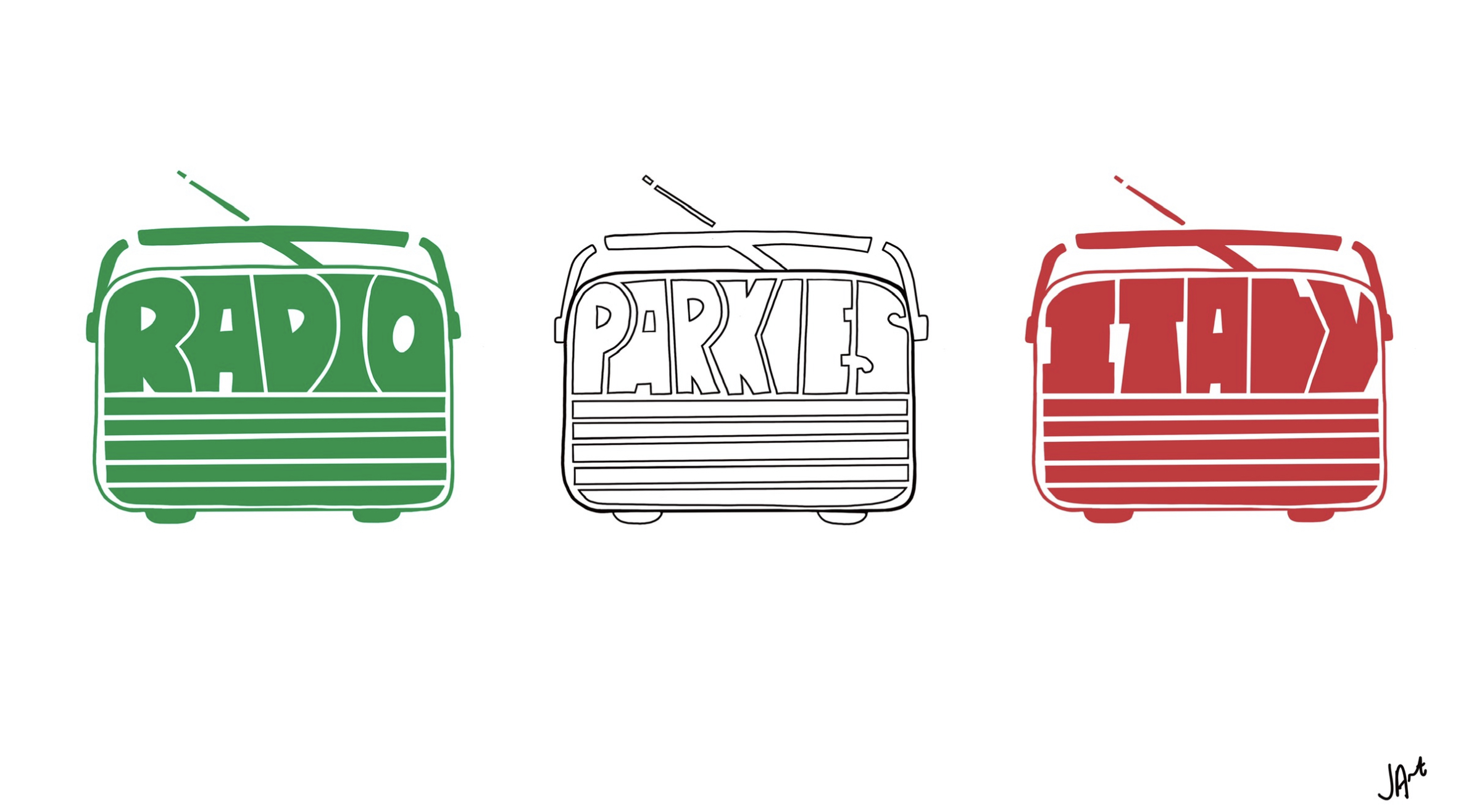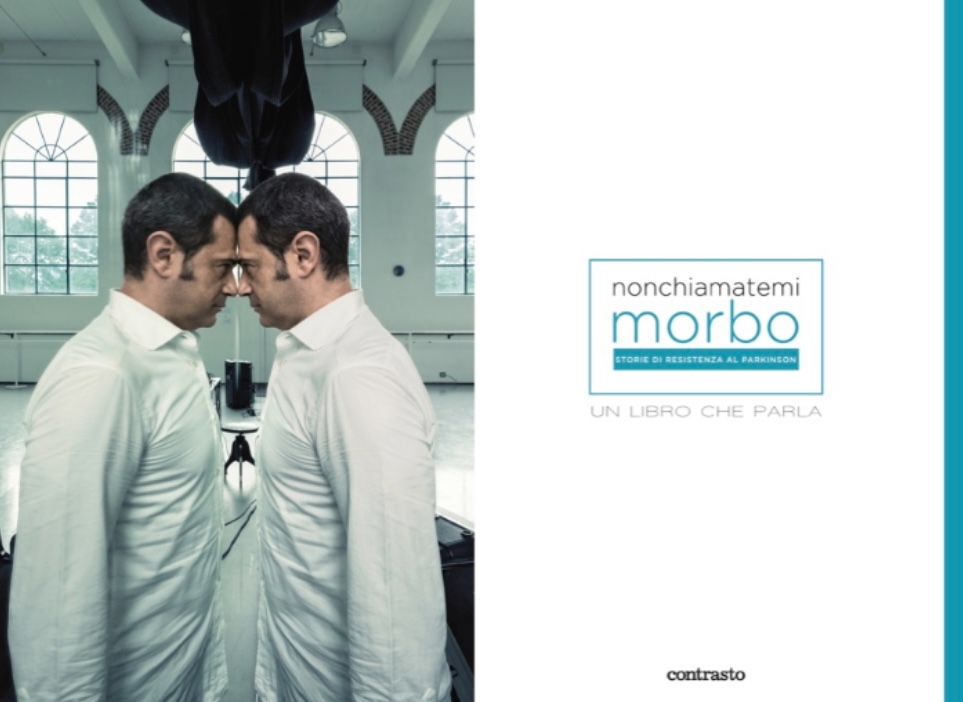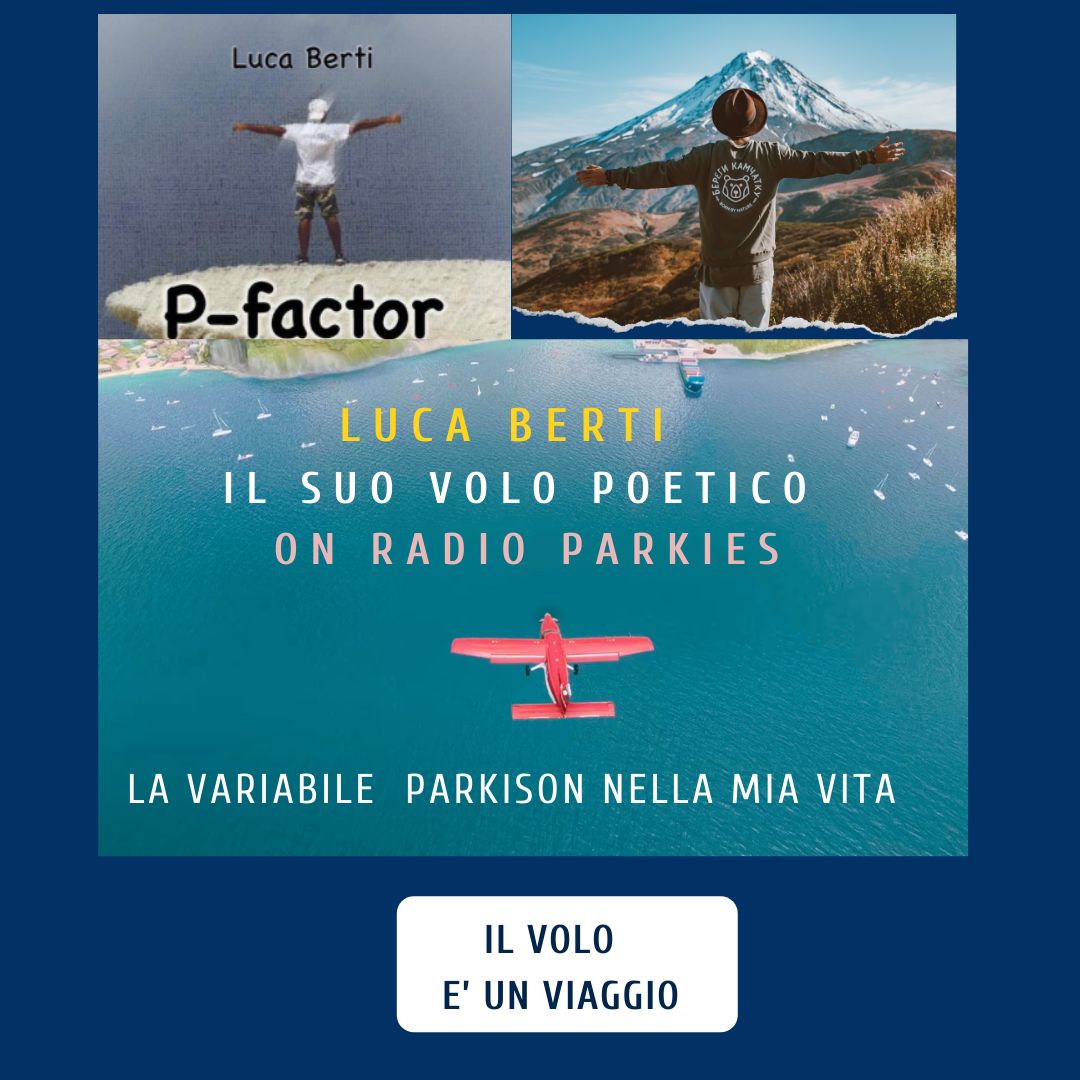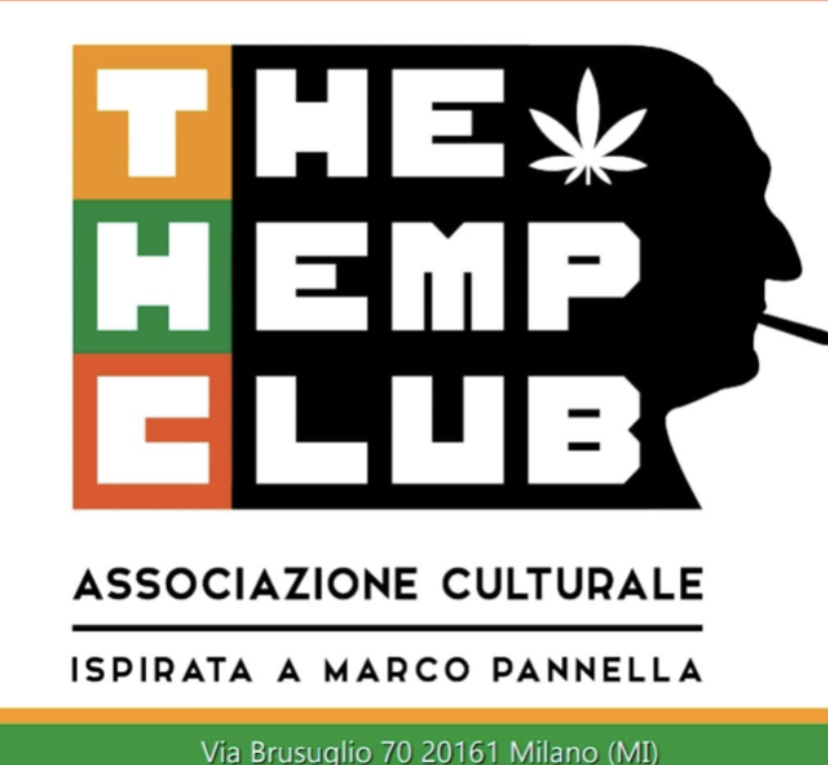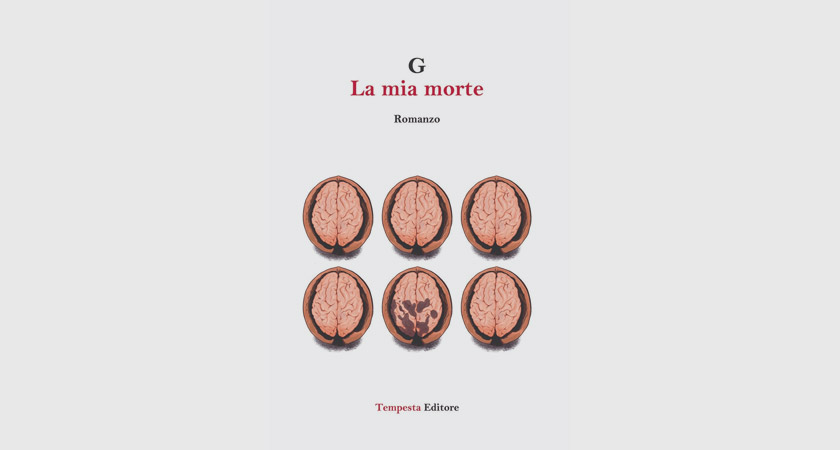Informare
Xadago®, terapia in fase di valutazione nel trattamento dei pazienti con Malattia di Parkinson, in fase iniziale e/o medio-avanzato.
- PDUFA date by [December 29, 2015] -
Milan, Italy, 2 Marzo 2015
Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron"), azienda che si dedica alla ricerca e sviluppo di terapie innovative nell’ambito del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del dolore, e il suo partner Zambon S.p.A., azienda internazionale fortemente impegnata nell’area terapeutica del SNC, annunciano oggi che la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (New Drug Application, NDA) di Xadago® (Safinamide) negli Stati Uniti è stata accettata da parte della Food and Drug Administration (FDA).
In conformità al Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), l’FDA ha indicato come data per il completamento della valutazione del dossier di Safinamide il 29 Dicembre, 2015 L’NDA riguarda l’uso di Xadago® (safinamide) come terapia aggiuntiva in pazienti con Malattia di Parkinson, sia in fase iniziale sia in stadio medio-avanzato, che non sono ade-guatamente controllati dal trattamento attuale.
"L’accettazione dell’NDA è basata su informazioni importanti ricevute dall’FDA negli ultimi mesi. Questa decisione indica che il processo di valutazione della completa efficacia e sicurezza di Xadago® può proseguire rapidamente, consentendo così al prodotto di essere disponibile sul mercato americano per i pazienti con questa patologia.” commenta Ravi Anannd, CEO di Newron.
"Se Xadago® verrà approvato dall’FDA, sarà un’opzione terapeutica di add-on, innovativa e di nuova generazione, per tutti i pazienti nei diversi stadi della MP". "Siamo nella fase finale di negoziazione con potenziali partner americani interessati a Xadago®", commenta Maurizio Castorina, Amministratore Delegato Zambon SpA. "e conseguentemente all’approvazione da parte dell’FDA, Zambon commercializzerà questa New Chemical Entity con il partner nel primo trimestre del 2016".
L’accettazione dell’NDA da parte dell’ente regolatorio americano arriva a seguito dell’approvazione della Commissione Europea di Xadago® del 24 febbraio 2015.
Leggi il Comunicato Stampa completo
Fonte: Zambon
Indirizzo internet: http://www.zambongroup.com/it/zc-zcomunicat/zc-zcnews/entry/0/221/125/news.html
La terapia DBS è indicata per tutti i pazienti?
Normalmente i neurologi prendono in considerazione la terapia DBS per pazienti che, malgrado il trattamento farmacologico ottimizzato, cominciano a vivere
situazioni di disabilità significativa, quando sintomi come le fluttuazioni motorie (i cosiddetti periodi “off”) e la discinesia interferiscono con le normali attività
quotidiane (ad es. tenere in mano un bicchiere o camminare). Oppure si orientano verso la stimolazione cerebrale profonda quando i farmaci cominciano ad essere associati a effetti collaterali intollerabili. Non tutte le persone affette dalla malattia di Parkinson possiedono però i requisiti per essere sottoposti alla terapia DBS.
Forme atipiche di malattia di Parkinson, alcune malattie psichiatriche, l’assenza di risposta alla levodopa, ecc. possono essere fattori di controindicazione a questa terapia.
Soltanto un gruppo multidisciplinare composto da neurologi, neurochirurghi, neuropsicologi e assistenti sanitari può stabilire se un paziente possiede tutti i
requisiti per la procedura d’impianto.
Si tratta di un nuovo tipo di trattamento della malattia di Parkinson?
No. 60 anni fa, negli anni cinquanta del secolo scorso, è stato inventato il primo pacemaker. Applicando la tecnologia dei pacemaker ai disturbi neurologici, è
stata poi sviluppata in Francia la tecnologia di stimolazione cerebrale profonda.
La terapia DBS è stata applicata per la prima volta in Europa nel 1987 per il trattamento del tremore essenziale ed è stata approvata per la malattia di Parkinson in fase avanzata nel 1998. Da allora, la tecnica chirurgica è notevolmente migliorata e oggi è disponibile una nuova generazione di dispositivi.. In tutto il mondo più di 75.000 pazienti hanno scelto di ricorrere alla terapia DBS per la malattia di
Parkinson, il tremore essenziale e la distonia.
Qual è la percentuale di successo della terapia DBS?
Il miglioramento medio dei sintomi motori varia tra il 50% ed il 70% con fino a 5,1 ore aggiuntive di priodi “on” al giono rispetto alla sola terapia farmacologica, con periodi prolungati durante il giorno in cui i sintomi motori della malattia di Parkinson non si manifestano. Questo miglioramento consente a molti pazienti di riacquistare la capacità di svolgere normali attività quotidiane, aumentando anche
significativamente la qualità della vita.
In che modo è possibile sapere se si possiedono tutti i requisiti per potere essere sottoposti alla terapia DBS?
Quando prende in esame i possibili trattamenti, il paziente deve in primo luogo rivolgersi al neurologo per conoscere tutte le alternative terapeutiche disponibili, in modo da essere certo di scegliere la soluzione più indicata per il proprio caso. Se il neurologo decide di orientarsi verso la terapia DBS, deve semplicemente scorrere una check list, che indica se è possibile prescrivere il trattamento al paziente. Il paziente, in collaborazione con il neurologo, può decidere se la terapia DBS è la soluzione giusta in quel momento.
Un paziente che soffre di (gravi) problemi psicologici dovuti a ragioni diverse può sottoporsi alla terapia DBS?
Sì, può ancora essere un potenziale candidato alla terapia DBS. Tuttavia, dal momento che è importante che i problemi psicologici siano trattati prima di iniziare la terapia, dovrà esaminare la questione a fondo con il neurologo.
L’intervento è doloroso?
Il cervello in sé non è sensibile al dolore, quindi l’intervento non è doloroso.
L’operazione si svolge in due fasi: la prima parte della procedura, vale a dire il posizionamento degli elettrocateteri nel cervello, può essere eseguita in anestesia generale o applicando un anestetico locale sulla zona del cuoio capelluto in cui saranno inseriti gli elettrocateteri. Questa parte dell’intervento si svolge con l’ausilio di tecnologia estremamente all’avanguardia, in grado di posizionare gli elettrocateteri in determinate zone cerebrali, individuate con estrema precisione.
La seconda fase prevede l’impianto del neurostimolatore nell’area del torace o dell’addome e il collegamento degli elettrocateteri a un sottile filo di prolunga
posizionato sotto la cute, rendendo invisibile l’intero sistema. Questa fase viene eseguita in anestesia generale. Successivamente il paziente dovrà restare in ospedale per un breve periodo (1-4 giorni) per riprendersi dall’intervento. A seconda dell’ospedale, il neurostimolatore sarà
programmato immediatamente o dopo un paio di settimane. In ogni caso, la programmazione sarà sempre personalizzata, in base alle esigenze
cliniche del paziente, nell’arco di alcune settimane dall’intervento.
La terapia DBS potrebbe causare danni al tessuto cerebrale?
Uno dei principali vantaggi della terapia DBS rispetto alle prime procedure chirurgiche è che i tessuti nervosi cerebrali non vengono danneggiati
dallo stimolo elettrico. Al contrario, lo stimolo interrompe o riduce i segnali elettrici prodotti dal cervello, che causano i sintomi della malattia di
Parkinson. Il processo è inoltre reversibile in qualsiasi momento.
Viene percepita la stimolazione?
Molte persone con un sistema DBS non avvertono per nulla la stimolazione, altre possono percepire una breve sensazione di formicolio all’accensione
del dispositivo.
I sintomi miglioreranno subito dopo l’intervento?
Di solito il sistema DBS non viene attivato prima di alcune settimane dall’intervento. A quel punto i sintomi dovrebbero ridursi. Normalmente si
ottengono risultati ottimali soltanto dopo varie sessioni di programmazione tra il paziente e il medico incaricato di programmare il dispositivo. Questo
processo può richiedere settimane e, a volte, anche mesi.
Qual è la durata del neurostimolatore?
A seconda del modello utilizzato e della quantità di stimolazione elettrica necessaria per il controllo dei sintomi specifici del paziente, la batteria
che alimenta il neurostimolatore può durare da 3 a 9 anni. Quando si deve sostituire la batteria, si riapre l’incisione praticata sullo stimolatore
in anestesia locale e si rimuove il dispositivo. Viene sostituita soltanto la batteria, semplicemente collegando la nuova batteria ai fili già
presenti.
La terapia DBS è permanente?
La terapia DBS è regolabile e la stimolazione può quindi essere modificata nel corso del tempo per mantenere il controllo sui sintomi specifici del
paziente. È anche possibile disattivare o rimuovere il sistema, qualora lo si ritenesse necessario.
Diario di bordo: primo giorno.
Sveglia ore 4:30
Doccia e duello all'ultimo sangue con lenti a contatto, le quali si rifiutavano di entrare nell'occhio.
La motivazione era valida: i tuoi occhi sono due fessure fisicamente non c'è spazio per entrare!
Alla fine troviamo l'accordo e piazzo le lenti.
Ultimi ritocchi al bagaglio. Ho deciso di viaggiare leggero. ... cavolo al trolley scoppiano le ruote da quanto è
peso!
Colazione leggera. ... come il trolley:cappuccino, brioche alla crema, bombolone alla crema. Ingerito il kit per il colpo di sonno mi metto alla guida.
Le fedeli guardie svizzere mi piantonano anche in macchina.
Viaggio tranquillo e rilassante, la fedele Renault sfreccia rispettosa dei limiti tra una selva di tir, bilici, bisarche e cisterne! La guardia svizzera seduta sul sedile anteriore esulta e si lascia andare a danze tradizionali svizzere, per festeggiare l'arrivo a destinazione ... ho come la vaga sensazione che non sia
proprio rilassata quando alla guida c'è il figlio!
Giunti al villaggio vacanze faccio il check in dove mi consegnano il bracciale .... ancora non ho trovato dove striscarlo ma credo serva per pagare essendo un allinclusive!
Uno strano animatore in camice bianco mi pone un'infinità di domande e poi mi fa fare una serie di esercizi ginnici di scarso valore tecnico. Il punteggio sarà basso. .. il coefficiente di difficoltà era pari allo zero!
Mi viene assegnata la stanza e per ambientarmi meglio penso bene di testare la resistenza della mensola porta TV con una sonora e fragorosa testata. Appena la stanza ed il mobilio si fermano, grazie al soccorso delle fedeli guardie svizzere, che continuano a piantonarmi con espressione gaudiosa e giuliva, dispongo nel capiente armadio a sei ante i 4 straccetti che ho portato: svuoto il trolley dispongo tutto nell'armadio,
prendo l'armadio e lo infilo nel trolley......
Un'avvenente animatrice, anche lei vestita di bianco mi consegna con fare premuroso e gentile il ricco
pranzo. Difendo il pasto dall'assalto delle guardie svizzere che con la scusa di controllare se è avvelenato si lanciano sul mio pasto travolti ed inebriati dal vortice di profumi che si elevano dalle innumerevoli portate disposte con arte e con gusto.
Sdegnate per l'affronto le G.S. se ne vanno con amplificate sul volto espressioni di gioia e letizia!
Trascorro il pomeriggio a conoscere tutti i segreti della mia nuova enorme magione, guardando con deferente rispetto la suddetta mensola che troneggia ancora salda ed impavida nonostante il sonoro colpo da me inflittole.
Un'altra avvenente animatrice mi consegna la cena. ..... sinceramente mi manca un po ' la lotta con le G.S. mangio fino a sazietà. .....
Adesso interrompono il racconto quello che succede da adesso in poi è sottoposto a censura!
A domani.
Diario di bordo: secondo giorno.
Beh per non perdere le buone e sane abitudini conquistate negli ultimi mesi e per godere appieno delle innumerevoli ed mirabolanrti attrazioni di cui è dotata la struttura, alle 5:30 sveglio … occhi sbarrati da fare invidia ad un gufo reale!
OK nello spirito di ottimizzazione e per combattere la crisi, sprecare anche il tempo mi sembra irrispettoso, mi alzo. Sfrutto l'abbondante vantaggio che ho nei confronti dei compagni di crociera e ne approfitto per radermi la barba.
OK sfilo l'armadio dal trolley, recupero il necessario per radermi e mi accingo ad operare. Mi posiziono davanti allo specchio ed ho la netta sensazione che ci sia qualcosa che non va! Se mi devo radere la barba, che notoriamente si trova sulla faccia.... perché mi vedo il petto riflesso nello specchio?
OK eseguo due calcoli trigonometrici per valutare il giusto coefficiente di rifrazione per far si che sullo specchio appaia la mia faccia ed arrivo alla conclusione che devo abbassarmi. Assumo la posizione da lottatore di Sumo, ma per aumentare lo spettacolo e dovendomi radere, non tengo neanche le mani sulle
ginocchia.
Un lieve fastidio ai quadricipiti dovrebbe farmi da monito....decido di ignorarlo.
Apro lo scintillante nuovo tubo di schiuma da barba, agito, esercito una lieve pressione sull'erogatore … niente. Aumento la forza e ripeto ... niente … Aumento la forza e ripeto ... niente ... Aumento la forza e ripeto. Un getto di schiuma fuoriesce impetuoso sfiora la mano deputata ad accoglierlo e si schianta al suolo ... senza fare rumore ... ma imbrattando in maniera inversamente proporzionale al rumore fatto!
Cerco di uscire dalla posizione del lottatore di Sumo e qui un tarlo mi si insinua nel cervello.... ho il sentore che la posizione non è delle più comode …
Raccolgo con maestria l'abbondante nevicata, a questo punto l'intero pavimento del lussuoso bagno è ricoperto di un sottile strato vagamente bianco ma decisamente appiccicoso.
Decido di affrontare un avversario alla volta: adesso mi rado.
Assumo nuovamente la posizione del lottatore di sumo con variante. Miro con occhio da cecchino e sparo un nuovo getto di schiuma, Centro! Stendo la schiuma da barba sul volto ed avverto delle sonore fitte alle gambe! Vista la mia manualità e flessibilità opto per un progetto semplice e minimalista: basette lunghe, curve e sfilate; pizzetto sottile svuotato ed interrotto! Eseguo nel men che non si dica tutte le postazioni necessarie per una corretta e duratura rasatura. Fatto! In preda agli spasmi di dolore controllo l'orologio: 6:40!
OK per proseguire nelle mirabolanti avventure decido di fare anche la doccia. Riesco con immani sofferenze a riaquistare la posizione eretta, o quasi (ora fare il miracolo di raddrizzare anche la schiena mi sembra eccessivo). Camminando a fatica per i dolori alle gambe, preparo l'accappatoio in micro fibra e tutti i
prodotti per la doccia. Trovandosi tra il bidet ed il WC, la doccia e non avendo la benché minima protezione, neanche il piatto doccia mi balena l'idea che inumidirò un po' il bagno.
Tiro con cautela la leva del miscelatore ed un caldo e vigoroso getto d'acqua calda si infrange sul mio corpo!
La sensazione di piacere contribuisce a lenire il dolore alle gambe ... socchiudo gli occhi!
Quando li riapro un particolare attira la mia attenzione: un'onda anomala pari a tutta la superficie del piacimento del bagno si sta dirigendo velocemente verso la porta! Stoicamente ignorando i morsi del pitbull che ancora ho attaccato ai quadricipiti con un balzo degno del miglior saltatore in lungo, mi frappongo tra l'onda e la porta. Improvviso un frangiflutti con ciabatte, asciugamano, maglietta e mutande!
Grazie a Nettuno riesco a contenere l'onda all'interno del bagno! Stabilizzato la situazione de ido di terminare la mia doccia. Rilassato come una bistecca in una vasca di squali, termino la doccia.
Terminato indosso il mio accappatoio! Inserisco la mano sinistra nella corrispondente manica e l'infernale attrezzo mi cinge in un affettuoso abbraccio. Ingaggio un corpo a corpo con l'accappatoio, saltando, piroettando, disegnando splendide figure degne della coppia più affiatata di nuoto sincronizzato! Al
termine dell'esibizione mi tributo una standing ovation e cerco di recuperare fiato, visto che sono in evidente debito d'ossigeno.
Mi vesto in precario equilibrio ed ESCO dal bagno. 7:30!
L'ennesima avvenente animatrice, vestita di bianco (al termine vacanza nel modulo dei suggerimenti consiglierò l'utilizzo di divise un po' meno.....come dire.....ospedaliere!), mi illustra con fornite ed accattivanti parole le meraviglie e le ghiottonerie offerte per la colazione.
La smisurata scelta di portate mi mette in imbarazzo, alla fine opto per un confortante e rassicurante: caffè latte e biscotti!
La regale colazione mi viene servita con tutte le onoreficenze solitamente riservate a teste coronate.
Immergo uno ad uno i ricchi e friabili frollini (4) nel profumato e caldo nettare di mucca impreziosito dal nero oro brasiliano!
Rigenerato e sazio termino la colazione. Da buon amico di una dentista la prima cosa che penso di fare è: lavare i denti!
Entro in bagno con passo deciso e sicuro e … come Alonso che affronta un tornante, sotto una battente pioggia, con gomme da asciutto e senza frenare, cado vittima dell'acqua plaining e rischio di schiantarmi contro la parete opposta del bagno! Mi ero dimenticato delle condizioni del bagno dopo la doccia …
Verifico con attenzione di essere in piedi ed intero e con molta cautela mi ancoro al lavandino e mi lavo i denti.
Esco dal bagno e mi riperometto di non rimetterci piede fino a tarda sera.
La mattinata scorre bene e veloce impegnato nelle innumerevoli attività ricreative che la struttura propone.
In uno dei rari momenti in cui mi soffermoun attimo, entra in stanza un animatore, attenzione vestito di VERDE!
Che efficienza mi è bastato pensare di dare un suggerimento, che subito si sono adoperati ed hanno soddisfatto il mio desiderio! L'animatore mi conduce al punto d'incontro per la nuova attività.
Sul posto ci sono ad aspettarmi mi due avvenenti e prosperose animatrici che mi conducono in una stanza un po' appartata, mi fanno accomodare su un letto........e mi legano!
Interessante, molto interessante.......
Mi collegano una sacco di fili, cuscinetti ed elettrodi, sono pronto ad esplorare la frontiera del sesso estremo!
Rimango un filo deluso quando una delle animatrici mi spiega che non ci sarà contatto tra noi … sesso virtuale … vabbè mi ispira un po' meno, ma ormai i miei sensi di bradipo sono tutti pronti va bene tutto … fatemi quello che volete ... Dee del piacere!
Avviano la macchina dell'eros che inizia a gonfiare i cuscinetti in sequenza, emettere rumori di vario genere … a me niente di tutto questo sembra eccitante! Non sarà che il mio bradipo sia diventato inpot … naaaaaaa!
Nel preciso istante in cui mi balena questa assurda idea il letto sul quale sono legato inizia da prima a sollevarsi e poi ad alzarsi portandomi alla MASSIMA EREZIONE! … Le animatrici osservano stupite ed esclamano in coro: "Com'è grande!". Orgoglioso rispondo con aria da marpione navigato … sono alto 2 metri! In pratica il letto mi ha messo in piedi, continuando a pompare e gemere … ma di piacere neanche l'ombra! I miei sensi di bradipo si stufano e quasi mi addormento!
Riportato in posizione orizzontale mi slegano e mi congedano. Appena, appena un po' deluso seguo la mia guida di verde vestita che mi accompagna ai miei appartamenti.
Dimentico subito la lieve sensazione di delusione perché c'è già ad aspettarmi il suntuoso pranzo!
Mi abbuffo e soddisfo ogni mia curiosità culinaria, adesso sì che sono appagato!
Memore dell'esperienza della mattina entro in bagno con circospezione per lavarmi i denti. Ne esco indenne! Affronto un pomeriggio iperbolico e strabiliante.....che si conclude con la cena....devo descriverla per farvi ancora invidia? OK sarò buono e ve la lascerò immaginare.
Anche per oggi si conclude la narrazione, da adesso in poi è sottoposto a censura.
Ciao a domani.
Diario di bordo: terzo giorno.
Sveglia alle 4:30.
La paura di perdere anche solo uno dei mirabolanti impegni della giornata mi ha provocato un sottile stato d'agitazione. Ne approfitto per restituire il favore alle zanzare che mi hanno utilizzato come punto di rifornimento di fiducia per tutta la notte.
Nella bagarre che ne scaturisce, loro sono molte, ma io sono determinatissimo a fargliela pagare, mi scordo di un ostacolo che campeggia a metà parete … una sonora testata mi riporta all'istante alla realtà! Approfittando del mio momentaneo stordimento le zanzare lanciano l'assalto finale. Cerco di riprendere il controllo ma, stordito dalla sonora zuccata ed indebolito dall'abbondante trasfusione subita, stento a riprenderlo.
Solo un pensiero riesce a risvegliare il guerriero che è in me … tra poche ore servono la lussuriosa colazione, niente e nessuno mi impedirà di goderne!
Mi risollevò come Rocky Balboa dopo aver preso un'intera autorimessa di autobus sul viso da Ivan Drago! Il solo mio sguardo terrorizza l'avversario che si ritira ad ali levate … sinceramente solo per un attimo mi balena il pensiero che fossero giá più che sazie. Lo rimuovo subito: se non credo io in me stesso chi altro lo può fare!
Decido di andare al bagno, entro con circospezione ho ancora negli occhi ed in qualche vestito le immagini "dell'umidità di ieri". Via libera tutto asciutto. Mi piazzo davanti allo specchio osservo ma anche oggi qualcosa non mi convince. Perché sulla mia faccia non ci sono naso, occhi e bocca? Dopo qualche secondo di smarrimento una fittolina al quadricipite mi ricorda: lottatore di sumo con variante! Ecco come per magia appare la mia faccia! Tumefatta dalle pinzature e sfregiata dalle cicatrici dovute ai ripetuti incontri poco amiche voli con la mensola, ma con occhi,naso e bocca al loro posto.
Cerco di superare velocemente lo spavento per la visione della mia faccia appena sveglia, la mia attenzione è attratta da alcuni particolari!
Ma come cazzo sono andato in giro ieri! Peli, pelucchi, ciuffetti campeggiano ovunque! Mi sono fatto la barba applicando la famosissima bizona di Ornzo Caná! Corro, … si fa per dire, ai ripari. Schiuma, agito, stappo, sto per premere ... una fastidiosa sensazione di pavimento bianchiccio ed appiccicoso mi
attraversa!
Predispongo la mano prescelta per accogliere il getto di schiuma, la sinistra e la piazzo nel lavandino ... optare per la mano destra vorrebbe dire aumentare notevolmente il coefficiente di difficoltà la mattina e pervasa sempre da un'onda di frenesia e non riesce a stare ferma. Miro schiacciò centro!
Che diavolo è questa sbobbetta molliccia, dov'è la mia schiuma!
Beh facendo un conteggio approssimativo tra quando ho agitato il tubetto e quando ho erogato son trascorsi almeno cinque minuti,forse è il caso di riagitare il tubetto. Imposto velocità sfrenata ed eseguo tutte le operazioni sopra descritte.... arrivo giusto in tempo, la schiuma sta già iniziando a cedere.
Distribuisco uno strato uniforme ed abbondante su tutto il volto e mi accingo a radermi sperando di applicare l'inverso della biozona di ieri, altrimenti vorrebbe dire ripassare negli stessi punti di ieri e lasciare la selva di pelucchi ancora più rigogliosi.
E' ufficiale stimo ed ammiro i lottatori di sumo.
Termino la rasatura con le lacrime agli occhi. Non è la commozione per il risultato ma bensì il dolore lancinante alle gambe. OK va bene cosi non ce la faccio più! Adesso doccia! Il mio sguardo si posa sull'accapatoio in microfibra … mi vengono alla mente i successi di ieri e i punteggi altissimi ottenuti per
difficoltà e creatività! Bellissimi ricordi, grandi soddisfazioni … oggi mi lavo a pezzi!
Eseguo un minuzioso lavaggio che scorre via veloce e senza intoppi ed in men che non si dica esco dal bagno profumato e rigenerato.
C'è già la colazione? Controllo l'ora incredulo: 8:35, beh dai anche oggi ci ho messo poco!
Purtroppo questo sabato è stato indetto lo scopero degli animatori tutte le attività sono sospese. Mi aggiro per questo atipico villaggio e noto con ammirazione che qui per rendere più efficace lo sciopero gli animatori hanno portato via tutto, infatti non riesco a trovare niente, hanno portato via persino la piscina.
Cavolo quando fanno sciopero lo fanno alla grande! La giornata trascorre leggera e priva di intoppi … meno male il letto è comodo!!! ... beh comodo … mi sega un po' il polpaccio quando sto disteso ma in compenso ho dei piedi freschi!!
A domani, il resto degli avvenimenti è sottoposto a censura.
Diario di bordo: quarto giorno
Oggi è domenica , la domenica anche se sono in vacanza decido di riposarmi. La domenica Mattina non c'è cosa migliore che poltrire sotto le coperte. Non c'è cosa migliore che acciambellarsi come un gatto.
Apro un occhio e fresco come una rosa dopo centinaia di ore di sonno, penso questa mattina salterò la lussuriosa colazione ho fatto sicuramente tardi!
Allungo la mano alla ricerca dell'orologio sono curioso … Beh molto curioso anche il fatto che il lenzuolo della domenica sia fatto apposta per trattenerti nel letto. Cerco di muovere il braccio destro ma mi muovo come nel supermovaiolone della domenica sera. Spingo come se dovessi spostare l'intero villaggio vacanze, ma questi geniali creatori del villaggio hanno dato il meglio di se.
Nella notte hanno sicuramente sostituito i normali lenzuoli, con un modello modificato che impedisce anzi azzera lo scivolamento. E' praticamente impossibile far uscire il braccio destro dal lenzuolo. Simpatico dev'essere il primo gioco della giornata ed io voglio vincere ed escogito subito una manovra alternativa. Cerco di raggiungere l'orologio poggiato sul comodino, che si trova alla mia sinistra.
OK se mi avete lumachizzato il braccio destro con questa vostra diavoleria abrasiva, eh,eh allora io vi frego uso il sinistro! Con una contorsione degna di Mister Fantastic (l'uomo elastico dei fantastici quattro), lussando e sublussando in più modi la spalla provocando danni probabilmente irreparabili raggiungo il piano del comodino. Da questa comodissima posizione cerco l'orologio nel buio.
Muovendomi fluido come una ruota dentata arrugginita, sbatto sulla bottiglia d'acqua, la quale si ribalta colpisce il bicchiere che si impennna schizzando via a velocità supersonica sbatte sul display del cellulare.
Tutti gli oggetti animati da un'energia cinetica degna dei protoni del CERN, volano fragorosamente in terra.
Attonito per lo spettacolo pirotecnico mi stavo quasi per scordare cosa stavo facendo. Una fitta lancinante da spillone Woodoo alla spalla sinistra, mi riporta alla realtà. Decido di immolare alla causa la spalla e compiendo un ultimo e dolorosissimo sforzo riesco a prendere con la punta dell'indice e del medio il
cinturino dell'orologio.
Con questa presa salda tento di richiamare a me il braccio, ma i danni alla spalla sono tali che non riesco a muovere niente. Cerco di girarmi sul fianco sinistro ma mi scontro con la mia agilità pari a quella di una tartaruga ultracentenaria che per la prima volta in vita sua si trova rovesciata sul guscio.
Giunto a metà rotazione i dolori alla spalla si fanno insopportabili.
Tento di leggere l'ora sul display dell'orologio.... perché il display non ha i consueti numeri i che indicano il preciso trascorrere del tempo? Un lampo di genio, che stupisce anche me, mi porta alla mente un irrilevante dettaglio: fava sei senza occhiali.. non ci vedi da qui a li! Mi faccio un rapido punto della
situazione, per aiutarmi a sciogliere (e mai termine mi è sembrato più appropriato) il dilemma sul da farsi.
Braccio sinistro in posizione da crocifisso del Cimabue, che afferra saldamente con il polpastrello della falangetta del dito medio e l'unghia dell'indice sinistro, l’orologio. Spalla sinistra ormai quasi staccata dal resto del corpo. Corpo steso supino in parziale rotazione sinistra. Braccio destro vittima delle sabbie mobili
impossibilitato in ogni movimento.
OK per vedere l'ora da questa distanza ho bisogno degli occhiali. Per prendere gli occhiali, anch'essi sul comodino, devo lasciare l'orologio. Se lasciò l'orologio con tutta probabilità cadrà anch'esso in terra raggiungendo bottiglia, bicchiere e telefono. Che me ne faccio degli occhiali se non ho più nè l'orologio né il telefono entrambe schiantati al suolo? Mmmmmm ma che bell'inizio di domenica?
OK rifletto, nei limiti di quanto la tirchia natura mi consente di fare … Basta ho deciso mi giro e mi siedo nel letto.
Come Jeeg quando Miva gli lancia i componenti mi ricompongo ed in un tempo che non so quantificare, per ovvi motivi, porto a termine le mie 7 fatiche di Ercole.
OK sono seduto! Prendo gli occhiali li indosso, prendo l'orologio … LE SEI???? Ma com’è possibile? Domenica, dormire, acciambellato ... NIENTE!!!
Ormai completamente sveglio per la gara di pentatlhon disputata con l'orologio, decido di alzarmi. Saluto la mensola e vado in bagno. Oggi doccia. L'accappatoio di microfibra mi saluta ed inizia lo straching per arrivare caldo al nostro momento acrobatico. Questa volta la doccia non mi frega. Piazzo le ciabatte come prima barriera, tanto le mie ciabatte messe in fila corrispondono alla larghezza del bagno ed un asciugamano come seconda barriera di sicurezza.
Apro l'acqua e mi rilasso. Controllo per puro scrupolo la situazione acqua, ma con le barriere che ho disposto tutto è apposto … eeeeeeeeehhhhhhhhh le ciabatte stile beach boys stanno cavalcando la cresta dell'onda intonando EVERYBODY CAN SURF … e si stanno per abbattere sull'asciugamano!
Con la stessa velocità con la quale cresce la barriera corallina, mi fiondo sulle ciabatte, le afferro ed ingaggio una singolar tenzone con l'onda anomala che avanza minacciosa. Con una raffica di sapienti colpi degni dell'erede della scuola delle sette stelle di Okuto respingo l'attacco!
L'accappatoio mi abbraccia felice!
Termino la doccia lavo i denti e stremato aspetto la colazione sono le 8. La domenica prosegue senza sussulti aspetto con una certa emozione la visita delle guardie svizzere. Puntuali come da tradizione, son svizzere, alle 12 arrivano. Per l'occasione hanno abbandonato la classica divisa con pennacchi ed hanno
indossato i costumi da Re Magi. Si presentano sorridenti e carichi di doni.
Care G.S. sarò sempre debitore mi avete dato alla luce e siete sempre presenti con il vs carico d'amore incondizionato.
Grazie.
Oggi chiudo così. A domani.
Diario di bordo: quinto giorno
La notte trascorrere male e movimentata, cioè virtualmente questi lenzuoli tessuti con la colla da topi, impediscono ogni movimento! Dicevo brutta notte, sonno agitato e frastagliato. Scoprirò più tardi premonitrice di funesti avvenimenti che sicuramente segneranno il mio animo e le successive giornate …
però segnerà meno la mia testa!
Prendo sonno quando albeggia, cado tra le morbide e coccolose braccia di Morfeo mi rilassò..... un animatore burlone irrompe nella stanza offrendomi la colazione dell'astronauta 3 pastiglie.
Il simpatico animatore, che in altro mento avrebbe avuto vita breve, con aria baldanzosa spalanca la finestra al grido:"....alziamoci che ci fa ancora a letto, guardi che bella giornata di sole!".
Tento di rispondere come si meriterebbe, sicuramente avrei usato parole ascetiche e profonde.... la sua unica fortuna è che ero indeciso se soffocare oppure ingoiare la colazione liofilizzata. Opto per ingoiare, senza protestare tale è il sonno! Unica riflessione … meno male almeno non sono supposte!
Distrutto, stanco, con un ombra che aleggia nella stanza presagio di avvenimenti futuri, mi alzo! Oggi non sono in grado di intraprendere eroiche battaglie, sfide olimpioniche, balzi, danze e quant'altro. Niente barba, niente doccia, niente non è giornata. Oggi minimo sindacale, giusto quello che serve per una
decorosa e inodore convivenza. Esco dal bagno cerco di capire chi sono, cerco di capire dove sono, cosa ci faccio … la colazione è servita ... ma non ho già fatto la colazione dell'astronauta?
Mentre cerco di riflettere, un’amabile animatore si avvicina e con voce flebile e suadente come si addice all'ora mattutina: GIULIANI CHI È GIULIANI! ANDIAMO!
Ma por.... put.... ma che turno di animatori del caz.. costavano meno questi?
Mi trascino fuori dalla suite imperiale cerco di capire chi è che mi cerca che una sonata sciabolata mi cade su una spalla: "sonno ehhhhh?". Un sorriso mi illumina il volto, questa mano, questo sensazione di bruciore sulla pelle mi giro: Mister sei tu?
All'altezza dove dovrebbe esserci la faccia del mister non c'è niente, ma una fastidiosa voce continua a produrre suoni per me senza senso. Seguo il fiume di suoni abbassando progressivamente lo sguardo e finalmente trovo l'origine di quei fastidiosi suoni! Continuando a produrre una quantità impressionante di
suoni al secondo l'animatore mi indica un ascensore che miracolosamente si è materializzato alle mie spalle. Senza nessuna resistenza salgo sull'asensore. Radiolo, è sicuramente il nome del settenano che mi accompagna, continua a vomitare suoni incomprensibili. L'ascensore si ferma si aprono le porte e Radiolo continuando a suoanare la sua fastidiosa sinfonia mi invita a scendere. Con un grugnito segnalo che ho ricevuto il messaggio, invio il segnale di partenza alle gambe. Come un motore Diesel anni 80 le mie gambe sbuffano, borbottano, accennano ad avviarsi ma non si muove niente. Radiolo infastidito alza il volume della sua musica tribale, sinceramente non credevo fosse possibile, con ampi gesti mi fa cenno di scendere!
Eehhh ....siiii .......hhooo....... caaaapitoooooo..... stooooo aaaandaaaandoooo.... nooooo..... ah è vero non mi sono mosso ancora! Con lo stesso sforzo di Hussein Bolth quando scatta dai blocchi di partenza il mio Diesel si avvia e scendo dall'ascensore!
Radiolo mi indica di seguirlo. Annuisco. Mentre eseguo l'oscillazione verticale della testa per manifestare il mio assenso al comando ricevuto, Radiolo si smaterializza. Riporto la testa in posizione di partenza e Radiolo è sparito. Del nano fratello di Pietro Mennea è rimasto solo la scia di suoni fastidiosi ed insensati.
Attivo la funzione inseguimento acustico ed inserendo la funzione velocità smodata seguo la fonte di quell'odiosa melodia!
Addentrandomi nei sotterranei seguendo la funesta voce mi sento molto:
"Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrova in in una selva oscura ove la retta via era smarrita..."
Finalmente Radiolo Pietrolo Mennea si accorge che ha perso il carico e si ferma. Io con la marcia velocità smodata inserita avanzo come un eurostar, prima che esca però dal cantiere Ansaldo Breda.
Radiolo Pietrolo Mennea appena mi vede sopraggiungere per niente impressionato della mia velocità, anzi ... riparte stabilendo il nuovo record sugli 800 come già fatto dal suo predecessore.
Finalmente giungiamo a destinazione. Nel turbine di suoni che continua ininterrottamente ad emettere, non so come, visto anche le mie condizioni di sonno regresso e carenza d'ossigeno dovuto alla gara appena finita, riesco a capire di sistemare in un cassetto tutte le mie cose.
Cosaaaaaaa??Ma ti sei intontito da solo,ti sei stordito con il rumore della tua voce stessa?
Cioè spiegami meglio, secondo te io lascio lì il mio cellulare? l'unico oggetto che mi tiene collegato con il mondo esterno? Che fa si che un sempre crescente gruppo di amici mi faccia compagnia e mi aiuti a superare questo momento? Momento in cui sto realizzando che forse la scelta di questo villaggio non è
stata tra le più oculate! Radiolo Pietrolo Mennea è inamovibile!
Eseguo
Mi indica una porta ........la porta d'accesso al programma spaziale!
Un addetto al piano spaziale mi fa stendere sul modulo di comando ed avvia la procedura di preparazione al decollo. Mi Stendo, primo problema il modulo è più corto dell'astronauta!! Posiziona le mie gambe in modo da fare invidia al contorsionitsta più navigato. L'addetto mi aiuta ad indossare il casco eeee
ooooopl......cazzo non mi ci passa il naso! Ok dopo vari tentativi l'operatore opta per la soluzione manuale e mi infila anche il casco.
Pronto? Do l'ok!
Il modulo viene inserito all'interno della Park spaziale. Inizia la procedura per il decollo. L'astronave inizia ad emettere tutta una serie di rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi.... dopo alcuni minuti estraggono il modulo dalla Park spaziale. Deduco ci siano dei problemi. Appena estratto un'altra assistente al decollo mi pratica una puntura sul braccio, ma che cavolo c'entro io se non parte......??
Vengo reinserito nella Park spazial: rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi .. rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi ... rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi...rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi...Niente non ne vuole sapere.... missione annullata.
Estraggono il modulo dalla ParkSpaziale mi liberano dal casco, consentendo al mio naso di riprendere la sua normale posizione e poi con aria innocente l'assistente al decollo mi dice: "Può scendere!"
Certo è almeno mezz'ora che ho le gambe in questa posizione io vorrei scendere ma mi sta venendo il dubbio che non camminerò mai più! Alla fine riesco a districarmi ed alzarmi.... come un incubo all'istante si materializza Radiolo Pietrolo Mennea!
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Mi tuffo sul cassetto dove ci sono le mie cose mi alzo e … ci risiamo è già sparito! Trovare la via del ritorno comunque è più facile, basta seguire a ritroso i quadri spostati, i segni sul muro la scia di gocce di sudore … tutti segni del mio passaggio dell'andata!
Et voilà sono all'ascensore, Salgo ignorando completamente Radiolo Pietrolo Mennea ed arrivo fino al punto di non sentire più la sua fastidiosa emissione di suoni. Ho in mente solo la mia cameretta, la comoda,accogliente, silenziosa, riservata, camera. Entro, chiudo la porta mi lascio cadere sul letto, .. cioè
metà sul letto e metà no perché il letto è corto! Ma va bene pace e tranquillità. Quasi, quasi recupero un po' di sonno ... i suoni si affievoliscono le membra si rilassano FINALMENTE!
Toc,toc.....Toc,toc.....eeeeeeeeehhhhhhhhhnnnn e che cazzo!!!! L'imprecazione mi sfugge, cosa c'è adesso?
L'animatore più antipatico presente sulla faccia della Terra è venuto a comunicarmi l'irreparabile! Da oggi si cambia stanza! Un tuffo al cuore ... l'avevo detto che foschi presagi aleggiavano nella stanza! Il cuore conduce il mio sguardo subito verso di lei la mia MENSOLA! Ci abbiamo messo un po' a capirci, o meglio io... lei nonostante le mie ripetute testate non si è mossa di un micron!! Adesso che ci rispettavano, o meglio io... lei mi ha fatto capire che non si sarebbe smossa! Adesso che ci volevamo bene ... ci separano!!! Addio porterò sempre con me il tuo ricordo ... e le tue cicatrici!!
Con il magone, il groppo in gola ed un giramento di palle vorticoso preparo le mie cose e trasloco nella nuova destinazione!! Entro nella nuova stanza, nonostante il giramento di palle, opto per l'approccio simpatico:" buongiorno sono venuto a farle compagnia...." risposta:" sono io che sono poco di compagnia!" ......e cominciamo bene........
Mi accomodo, sistemo le mie cose, ripongo e penso a lei la mia mensola..... la mano sfiora le cicatrici.....
All'improvviso una raggio di luce illumina la triste giornata. Un avvenente animatrice mi propone tutta una serie di giochini..... no calma con la fantasia, non quei giochini..... Giochini con numeri, lettere, parole disegni, forme geometriche ed io regredito all'infanzia gioco felice!
Non so quanto tempo passa ma purtroppo finisce. Con i suoi grandi occhioni da cerbiatta mi dice: "Poi ci sarebbe da rispondere a qualche
domanda, .... lo fa dopo da solo.....??" Completamente invaghito e rincoglionito annuisco. Lei se ne va, osservò le domandine, .... ma quanti fogli sono.... rapida occhiata, sono numerate, volo all'ultima pagina.....550 domande!
Scusate adesso vi saluto devo rispondere a qualche domandina....
Diario di bordo: sesto giorno
OK vi confesso che a questo punto ho dei forti dubbi ..... lo dico sottovoce.... ho il forte sospetto che questo non sia un villaggio vacanze!
Sapete cos'è.... è un centro di studio di sostanze dopanti! Vi spiego Questa mattina non mi hanno dato le pasticchine che mi danno tutti i giorni. Nell'attesa io con la solita celerità e precisione mi sono lavato e fatto la barba... rischiando la vita più volte, muovendomi alla consueta velocità supersonica.... per un bradipo!
Anche oggi ne esco vittorioso ed in un paio d'ore mela cavo. Vedrai che con le gomme nuove, due migliorie aerodinamiche, recupero 2 secondi sul giro, Rettifico sul giramento di palle!
OK colazione, ricca come sempre...una scodella di plastica con latte e caffè e ben 4 biscotti!! Ma che minchia mi fanno 4 biscotti, sono 105 kg! Li brucio solo per attivare il processo di masticazione e deglutizione.
Una sensazione mi attraversa la mente..ma quanto è peso questo cucchiaio di plastica oggi!! Il latte è bollente ma come per magia nel tragitto "tazza" bocca arriva già freddo.... mah eppure non c'è così freddo in stanza.... ahhhh ho capito è lo spostamento d'aria prodotto dal mio movimento rapido che fa si che il
latte si raffreddi!
LLLLLaaaaa mmmmmaaaaatttttttttttiiiiinnnnnaaaaa ssssscccccooooorrrrrrrrrreeeee llllleeeeennnnntttttaaaaa nnnnnooooonnnnn sssssooooo cccccooooosssssaaaaa sssssuuuuucccccdddddeeeee....
Tutto, cioè tutto quello che faccio io sembra fatto alla moviola, mi muovo comee un fermo immagine all'interno di un film che procede a velocità normale tutto sembra più veloce di me... toh una zanzara aspetta la schiaccio.... clap... mancata cavolo come ha fatto è già uscita dalla stanza mi ha pinzato 3 volte e 2 il vicino nel tempo in cui io cercavo di battere le mani!! Dev'essere una zanzara motorizzata Ferrari!!
Le ore si allungano, le distanze si allungano... per andare in bagno devo avviarmi ancor prima di avvertire lo stimolo, se parto quando ne sento la necessità me la faccio sotto ancor prima di essere arrivato in bagno, tantoè diventato lungo il percorso.
Come nel telefilm L'UOMO DA SEMILIONI DI DOLLARI, telfilm fantastico anni '70 in cui il protagonista:
Il colonnello Steve Austin, a causa di un incidente durante una missione, perde le gambe, il braccio destro e l'occhio sinistro. Su di lui viene effettuata una ricostruzione bionica all'avanguardia, che sostituisce gli organi danneggiati con arti bionici. La serie prende il titolo dal costo dell'intervento, appunto di sei milioni di dollari.
Vi ricordate il magnifico effetto per frlo sembrare veloce.... rallentavano tutto il film ed inserivano un motivetto: tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa che simboleggiava il muoversi veloce del protagonista.
Beh ecco la mia mattina faceva più o meno:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Ideona! Allora vado a fare due passi!
Mi giro per scendere dal letto:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Metto giù le gambe:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Mi metto seduto sul letto:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Mi alzo in piedi:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Mi infilo le ciabatte... doppio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa; vedrai 2 piedi 2 ciabatte!
Parto!
Primo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Secondo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Terzo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Quarto passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
E che palle! Una lumaca mi lampeggia nervosa con i fari: "Hey nonno se c'hai sonno resta a casa la mattina!!!" Esclama sorpassandomi! Ma io vermente sto andando a manetta!!! tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa.
Finito di circumnavigare il letto mi risiedo sul letto stesso sfinito:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Vabbè la passeggiata la faccio dopo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
E' l'ora di pranzo, che come sempre vi viene servito in camera!
Grazie allora mi alzo, mi lavo le mani e mangio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
OK le mani non me le lavo, mangio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Mi siedo a tavola, ho la sensazione che sia passato un saccodi tempo, noto con stupore che il mio compagno di stanza Burlone Gigioneggione ha già finito di mangiare: accidenti che fame avevi oggi, penso stupito!
Forchetta:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Infilzo la pasta:tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;
La porto alla bocca:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Che strano oggi è fredda di solito è bollente!
Mastico:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Consumo tutto il mio pasto e da buon amico di dentista corro a lavarmi i denti: tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa, ma che strano oggi non fa laschiuma nemmeno il dentifricio mentre strofino lo spazzolino sui denti!
La sensazione che tutto stia andando più veloce di me aumenta... ma che strano effetto speciale!
All'improvviso un uomo mi viene a cercare per accompagnarmi...:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa, lo seguo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Mi conduce in una stanza con strane apparecchiature alle pareti ed un sacco di computer. Mi attaccano su tutte le articolazioni, sulla schiena delle strane palline. Adesso facciamo delgi esrcizi, ok! Basta non ci siano domandine da compilare dopo.......
Allora stenda le braccia...tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Porti la punta dell'indice al naso ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Apra e chiuda le mani ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Apra e chiuda l'indice sul pollice ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Adesso braccia incrociate si alzi dalla sedia ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Perfetto adesso cammini avanti ed in dietro ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaatatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa
tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.
Benissimo adesso mi danno da bere un bicchiere di sostanza isotonica,rigenerante,ristrutturanteisomma nabbomba!!
Attenda una mezzora e poi ripetiamo i test. Mi accomodo su una poltrona ed aspetto ... aspetto ... aspetto uno strano senso di frenesia mi inizia a salire ... aspetto . aspetto ... inizio a muovere il collo poi le mani poi le braccia. Ok non ce la faccio a stare seduto mi alzo!
Rientrano gli ani-dottori... ripetiamo i test:
Stenda le braccia, Porti la punta dell'indice al naso, apra e chiuda le mani, apra e chiuda l'indice sul pollice, adesso braccia incrociate si alzi dalla sedia, cammini avanti ed in dietro....la sindrome di Benny Hill si è impossessata di me non è che mi muovo ... volo ... vada più piano non riesco a filmarla ... il pc non ha abbastanza memoria per analizzare dati a questa velocita... adesso si che mi sento come un protone nell'accellerometro del CERN!!
Non so cosè ma mi piaceeeee: Druido prepara ancora di questa pozione... io ed i miei amici Asterix ed
Obelix siamo invinvibili!
Il Druido però mi stupisce abbiamo finito la riaccompagno in stanza! In stanzaaaaaaaaaaaaaa????? Ma fatemi fare qualcosa ho la pozione gallica che fermenta in me fatemi: illuminare tutto il villaggio collegando una bicicletta al generatore di corrente; oppure traslocare l'ufficio tanto posso tranquillamente prenderlo tutto e spostarlo in una sola volta; oppure posso battere qualche record olimpico a sua scelta..
No è inamovibile si torna in stanza! Arrivati in stanza decido di fare uno spuntino... dilanio in un batter d'occchio tutto quello che c'è di commestibile, poi delle urla attirano la mia attenzione ... cosa dicono? ... fermo, fermo, Giuliani smetta di moredere il polpaccio del suo compagno di stanza ... ma cosa vuol dire ...con chi ce l'hanno ... certo è peloso questo cibo ... peloso??? polpaccio??? dicevano fermo,fermo Giuliani??? O cavolo mi scusi....eh,eh, avevo famina!!!
Passo il resto del pomeriggio nella ruota come un criceto a smalire la pozione del Druido ... alle 18 finisce e mi spengo ... un ultimo pensiero prima del blackout domani ci faccio il bagno nella pozione!!!!
Claudio Giuliani
La terapia di stimolazione cerebrale profonda
La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è una terapia reversibile che prevede l’inserimento chirurgico di un sottile elettrocatetere isolato all’interno del cervello (nella maggior parte dei casi in un’area chiamata nucleo subtalamico), che viene poi collegato tramite un’estensione a un piccolo dispositivo chiamato neurostimolatore (simile a un pacemaker), di solito impiantato sotto la cute nella zona toracica o addominale.
Il sistema è completamente impiantabile e gli elettrocateteri e il neurostimolatore sono praticamente invisibili sotto i vestiti. Quando è acceso, il neurostimolatore genera impulsi elettrici che vengono inviati al cervello, per interrompere o ridurre i segnali elettrici che causano i sintomi della malattia di Parkinson. Un programmatore consente al paziente di regolare gli impulsi. Occorre continuare ad assumere i farmaci per la malattia di Parkinson, ma in certi casi è possibile ridurne sensibilmente le dosi.
La terapia DBS è più efficace in pazienti di età non superiore a 70–75 anni. Quando i farmaci non consentono più di tenere sotto controllo i sintomi della malattia di Parkinson (ad es. il tremore, un sintomo che risponde particolarmente bene alla terapia DBS) oppure inducono preoccupanti effetti collaterali, il paziente può essere ritenuto idoneo a questa procedura, anche se la malattia è ancora in fase iniziale.
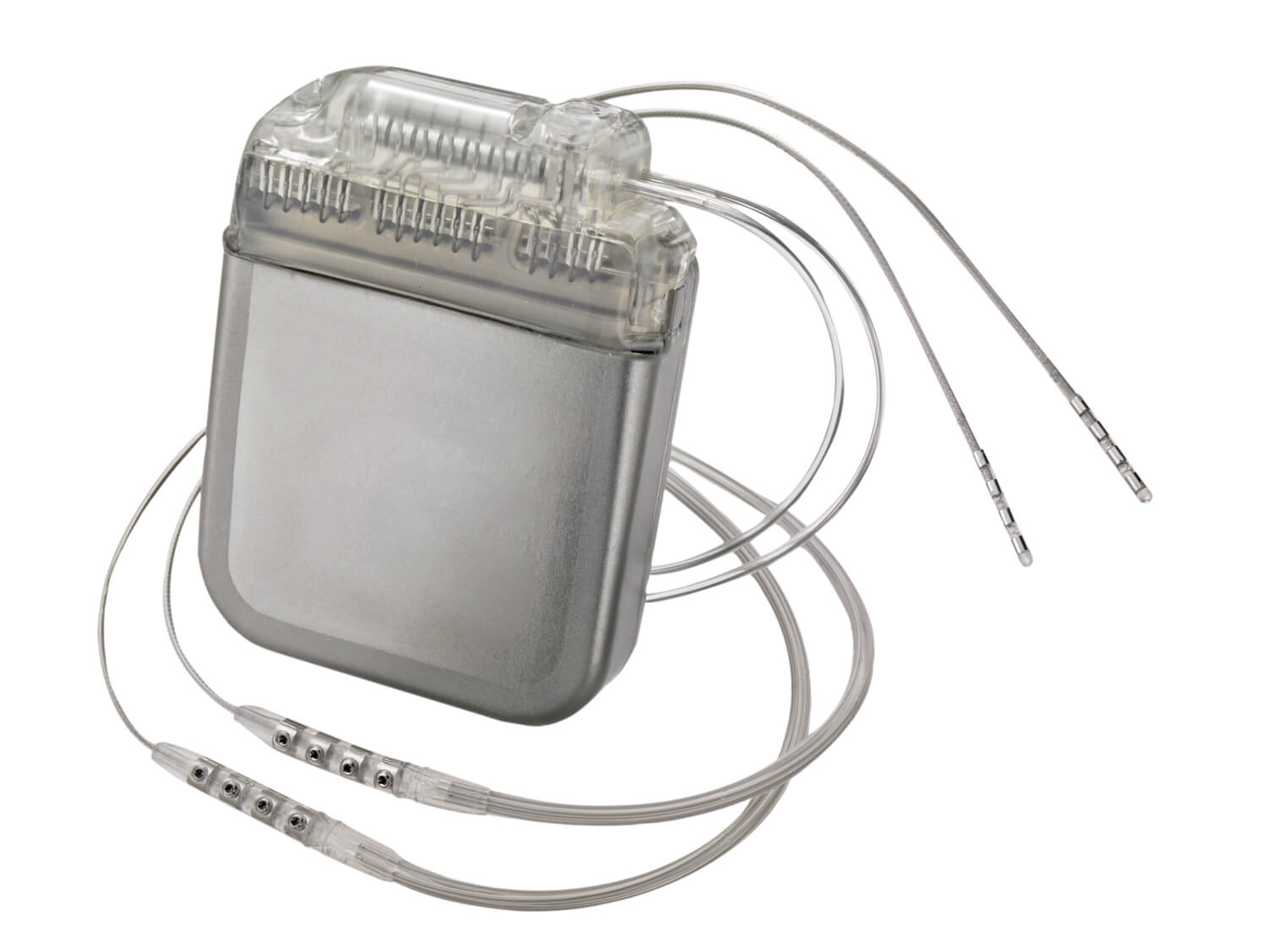

Terapia di stimolazione cerebrale profonda (DBS)
60 anni fa, negli anni cinquanta del secolo scorso, veniva inventato il primo pacemaker. Quarant’anni dopo, applicando la tecnologia dei pacemaker ai disturbi
neurologici, veniva sviluppata in Francia la tecnologia di stimolazione cerebrale profonda. Da allora, la tecnica chirurgica è notevolmente migliorata e in tutto il
mondo più di 75.000 pazienti hanno scelto di ricorrere a questa terapia.
Altre informazioni
DBS Considerazioni Centri DBS Ricovero pre-DBS DBS faq (domande frequenti)
Di quali informazioni hanno bisogno i pazienti in previsione della terapia DBS?
Alcune informazioni consentiranno ai pazienti di decidere se la terapia DBS è la scelta giusta per il loro caso:
- Quali sono i pazienti ritenuti idonei alla terapia DBS?
- Qual è il momento giusto per considerare di avviare il trattamento con la terapia DBS?
- Quali sono i benefici della terapia DBS?
- La terapia DBS presenta rischi?
Quali sono i pazienti ritenuti idonei alla terapia DBS?
Alcuni pazienti possiedono i requisiti per essere sottoposti alla terapia DBS. Per saperne di più occorre rispondere alle seguenti domande;
1. Ha la malattia di Parkinson da almeno 5 anni?
SI | NO
2. Ha fastidiosi periodi off (periodi in cui il medicinale non agisce in modo sufficiente e si manifestano i sintomi della malattia)?
SI | NO
3. Ha dolorose discinesie (eccessivi movimenti involontari)? (Se non è sicuro di soffrire di discinesie, chieda al neurologo.)
SI | NO
4. Prende dosi frequenti di farmaci dopaminergici (Levodopa, Sinemet®, Stalevo®, Parcopa®) in una giornata tipica?
SI | NO
5. Soffre di uno dei seguenti effetti collaterali causati dai suoi medicinali, pur avendo fatto ricorso a svariate combinazioni di farmaci: sonnolenza, nausea, allucinazioni, confusione o altri disturbi cognitivi, stordimento quando si alza in piedi, modifiche comportamentali/di personalità (iperattività sessuale, comportamento compulsorio, ecc.)?
SI | NO
Se per alcune di queste domande la risposta è “Sì”, il paziente potrebbe essere un potenziale candidato per questo tipo di trattamento.
Qual è il momento giusto per considerare di avviare il trattamento con la terapia DBS?
Per ricevere il trattamento ottimale, è importante avviare la terapia DBS entro la cosiddetta “finestra temporale di opportunità”, che si apre quando si
presentano i seguenti casi
- Il paziente soffre di malattia di Parkinson da almeno 5 anni (ciò esclude la possibilità che si tratti di un’altra formaatipica di parkinsonismo, dal momento che la terapia farmacologica è di solito sufficiente entro tale lasso di tempo)
- I sintomi (ad es. tremore) stanno aggravandosi, malgrado la farmacoterapia ottimizzata
- Il paziente non è più in grado di tollerare gli effetti collaterali dei farmaci assunti
- Prima che la progressione della malattia di Parkinson sia tale da interferire con la vita sociale e professionale del paziente
I benefici della terapia DBS sono maggiori in pazienti di età non superiore a 70–75 anni e in coloro che soffrono di malattia di Parkinson da meno tempo. Mano a mano che il paziente invecchia, e la malattia di Parkinson progredisce, i potenziali benefici della terapia DBS iniziano a diminuire e i rischi correlati ad aumentare. Inoltre, i pazienti la cui vita sociale ha subito un deterioramento troppo profondo a causa dei sintomi della malattia, provano maggiori difficoltà a riprendere le normali attività quotidiane, quando si accorgono che la terapia DBS può renderli più mobili e indipendenti.
La terapia DBS non dovrebbe pertanto essere considerata l’“ultima spiaggia”: i maggiori benefici sono infatti stati osservati nei pazienti che vi hanno fatto ricorso in uno stadio precoce della malattia, rispetto a coloro che hanno atteso fino all’esaurimento di tutte le alternative disponibili.
È opportuno che i pazienti esaminino con il neurologo la possibilità di ricorrere alla terapia DBS in una fase iniziale del programma
terapeutico, anche se i sintomi sono ancora controllati dalla terapia farmacologica. Ciò darà loro il tempo necessario per prendere
in esame i potenziali benefici e i possibili rischi della terapia, e permetterà loro di decidere se la stimolazione cerebrale profonda è
la scelta giusta, quando si aprirà la “finestra di opportunità”.
Perché ricorrere alla stimolazione cerebrale profonda? Quali sono i benefici della terapia DBS?
Cosa la terapia DBS PUO’ FARE per i pazienti
- La terapia può consentire ai pazienti di avere periodi più lunghi di sollievo da alcuni dei sintomi motori
- Prolungamento significativo del numero di ore (fino a 6 ore in più di periodi “on” al giorno, rispetto al solo trattamento farmacologico)1,2,3 trascorse senza la comparsa di movimenti rallentati, rigidità e/o tremore, sintomi estremamente invalidanti della malattia di Parkinson
- Riduzione significativa della quantità e della durata dei movimenti involontari anomali (discinesia), comuni effetti collaterali dei farmaci antiparkinsoniani
- Miglioramento dei sintomi motori della malattia di Parkinson che rispondono alla levodopa, ma senza i potenziali effetti collaterali indotti dal farmaco
- Può mantenere il miglioramento a lungo termine dei sintomi motori, anche dopo 5 anni
- Può consentire ai pazienti di ridurre la quantità di farmaci antiparkinsoniani da assumere (in molti casi fino al 50%)
- Può fornire un certo sollievo da alcuni sintomi non motori, quali disturbi del sonno e dolore derivante da crampi muscolari (distonia)
- Può migliorare la mobilità e la capacità di svolgere la normali attività quotidiane (come ad esempio mangiare e vestirsi da soli, alzarsi dalla sedia, camminare, ecc.), consentendo ai pazienti di riacquisire la propria indipendenza e riprendere la vita sociale
- Può migliorare la qualità della vita dei pazienti e di coloro che li assistono
- Può dare sicurezza e tranquillità, dal momento che la terapia DBS:
- Garantisce una stimolazione nell’intero arco della giornata
- Può essere programmata e adattata alle esigenze specifiche del paziente
- È completamente impiantabile e invisibile
- È una procedura reversibile e il sistema può essere spento e rimosso quando necessario
Cosa la terapia DBS NON PUO’ FARE per i pazienti
- La terapia non porterà alla guarigione della malattia di Parkinson – come tutti i trattamenti per la malattia di Parkinson attualmente disponibili, la terapia DBS contribuirà semplicemente a gestirne i sintomi
- Non migliorerà i sintomi motori non migliorati dalla levodopa (ad eccezione del tremore e dei crampi muscolari)
- Non risolverà tutti i problemi eventualmente correlati ai sintomi della malattia di Parkinson (ad es. isolamento sociale, stigma, problemi emotivi, ecc.) – la terapia DBS contribuirà a tenere sotto controllo i sintomi motori e consentirà una maggiore mobilità, ma sarà compito dei pazienti trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla stimolazione cerebrale profonda
- La terapia DBS non modificherà in modo permanente il modo di pensare o la personalità di un individuo. Tuttavia la terapia DBS – analogamente ad altri farmaci antiparkinsoniani – può avere effetti collaterali psichiatrici, che possono manifestarsi con maggiore probabilità nei pazienti che già soffrono di disturbi psichiatrici indotti dalla malattia di Parkinson o dal trattamento farmacologico. Possono comparire disturbi emotivi, come depressione o mania, stati confusionali o apatia, generalmente rari e il più delle volte transitori, se trattati in modo appropriato.
È importante stabilire aspettative realistiche per i pazienti in merito ai possibili risultati che potranno ottenere con la terapia DBS: potrà contribuire a gestire efficacemente i loro sintomi, ma non porterà alla guarigione dalla malattia di Parkinson.
La terapia DBS presenta rischi?
È stato dimostrato che la terapia DBS ha un favorevole profilo di sicurezza a lungo termine, in particolare in pazienti di età inferiore a 70 -75 anni 1,3,4,5.
Come per qualsiasi intervento chirurgico cerebrale, esistono tuttavia alcuni rischi associati alla procedura, in ogni caso molto bassi se l’operazione viene eseguita da un’équipe di esperti 5. In letteratura viene ad esempio indicato che 6 pazienti su 1.000 (0,6%) possono avere complicanze chirurgiche temporanee (come crisi convulsiva o trauma al tessuto cerebrale), mentre le infezioni cutanee interessano 4 pazienti su 1.000 (0,4%) 5. Per fare un confronto, il rischio di gravi complicanze (ad es. infezione articolare) a seguito di intervento di protesi totale d’anca è 5 volte superiore (2%) 6. Le eventuali complicanze correlate alla terapia DBS sono spesso lievi e di breve durata, e normalmente si risolvono entro 30–90 giorni dall’intervento.
Anche il rischio di compromissioni permanenti dello stato di salute è basso (1,0%), prevalentemente dovuto a emorragia intracranica 5. Come qualsiasi altro trattamento, l’esito può essere letale, ma anche in questo caso il rischio è basso (0,4%) 5, vale a dire lo stesso rischio di morte associato, ad esempio, alla protesi totale d’anca (0,41%).
Sembra che la terapia DBS comporti un rischio maggiore di disturbi dell’andatura e di cadute. Non è tuttavia certo se la stimolazione cerebrale profonda sia la causa diretta di questi disturbi, oppure se i pazienti siano esposti a un rischio maggiore a causa del miglioramento della funzionalità generale e del livello di attività. In ogni caso, risulta chiaramente che andatura, equilibrio e stabilità posturale migliorano in misura significativa da 6 a 12 mesi dopo l’intervento. Inoltre, il maggiore rischio di disturbi dell’andatura e di cadute non sembra incidere negativamente sulla qualità della vita. Ciò nonostante, è essenziale che a tutti i pazienti sia offerta l’opportunità di sottoporsi a fisioterapia al fine di gestire qualsiasi possibile disturbo dell’andatura e che siano monitorati attentamente da un’équipe multidisciplinare prima e dopo l’intervento, in particolare nel corso del primo anno.
Si dovrebbero tranquillizzare i pazienti, spiegando loro che la terapia DBS non modificherà la personalità. La terapia DBS ha una comprovata affidabilità per quanto riguarda i possibili effetti psichiatrici in pazienti attentamente selezionati. Non determina nessun cambiamento significativo dell’efficienza cognitiva globale a lungo termine; inoltre alcuni studi hanno dimostrato che eventuali menomazioni nella scioltezza e nelle capacità del linguaggio, che possono manifestarsi con la terapia DBS, non incidono sui significativi miglioramenti della qualità di vita. I sintomi comportamentali (ad es. depressione, ipomania/mania, apatia, ecc.) sono potenzialmente evitabili (ad es. modificando le dosi del farmaco o la stimolazione, opporre adottando opportune terapie psichiatriche) e, qualora si presentassero, sono normalmente di breve durata e facilmente trattabili.
I neurologi esperti in DBS dovrebbero analizzare a fondo questi aspetti con i propri pazienti, esaminando anche i potenziali rischi associati alla malattia di Parkinson non trattata, ai farmaci antiparkinsoniani e ad altri tipi di terapie.
Queste informazioni consentiranno ai pazienti di confrontare i potenziali benefici della terapia DBS con tutti i possibili rischi, affinché sia così garantita la scelta della terapia più indicata, in grado di gestire nel modo più efficace i sintomi individuali.
Il reparto di Neurochirurgia Stereotassica Oncologica e Funzionale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette, situato in Via Cherasco 15, ha come Responsabile il Prof. Michele Lanotte.
Il reparto, Struttura Semplice Dipartimentale SSD del Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale, è Centro di Riferimento Regionale per la Terapia Chirurgica della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento.
Si distingue in particolare per la seguente attività:
- Trattamento chirurgico (DBS) dei Disordini del Movimento (malattia di Parkinson, tremori di diversa origine, distonie);
- Chirurgia dell'Epilessia farmaco-resistente (stimolazione del nervo vago VNS);
- Chirurgia dei conflitti neuro-vascolari (nevralgia trigeminale, emispasmo facciale).
Afferisce alla struttura l'ambulatorio dedicato di Neurochirurgia Funzionale.
COLLEGATI AL SITO DELLA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Quali sono i possibili trattamenti della malattia di Parkinson?
È importante riconoscere che al momento non esiste nessuna cura per la malattia di Parkinson. Ciò nonostante esistono numerosi tipi di trattamento, che rendono possibile gestire i sintomi della patologia in modo efficace per molti anni, consentendo al paziente di condurre una vita relativamente normale. Con l’aiuto di un neurologo, il paziente può decidere quale terapia è più indicata ai propri sintomi ed esigenze specifiche. Se i sintomi non risultano particolarmente fastidiosi, all’inizio il paziente può decidere, assieme al neurologo, di non trattarli, concentrandosi invece su uno stile di vita sano, che includa attività fisica, relax e regime alimentare corretto, da osservare per tutta la vita.
Trattamento farmacologico orale
Quando i sintomi iniziano a interferire con la vita del paziente, inizialmente possono essere gestiti con piccole quantità di farmaci antiparkinsoniani (ad es. agonisti della dopamina, levodopa, ecc.), da assumere per bocca (per via orale). Tali farmaci sono studiati per aumentare il livello di dopamina che raggiunge il cervello, oppure per stimolare le aree cerebrali in cui agisce la dopamina. La natura estremamente individuale della malattia di Parkinson comporta la risposta differenziata alla terapia farmacologica da parte dei pazienti, ed è pertanto importante che i farmaci siano prescritti e adattati secondo le esigenze specifiche di ogni soggetto. Mano a mano che la malattia progredisce, i pazienti possono richiedere dosaggi più elevati o diversi tipi di farmaci per tenere i sintomi sotto controllo. Ciò può tuttavia essere associato a un aumento degli effetti collaterali, tra cui nausea, vomito, vertigini, psicosi, discinesia, ecc. Prima o poi accade che la terapia farmacologica non riesca più a tenere sotto controllo i sintomi in modo efficace oppure che si manifestino preoccupanti effetti collaterali. Quando ciò avviene, esistono molte altre terapie a cui ricorrere.
Metodi alternativi di erogazione di farmaci
La maggior parte dei farmaci antiparkinsoniani vengono assunti per via orale: ciò significa che attraversano lo stomaco, dove avviene una rapida scomposizione che ne riduce l’efficacia. Per evitare questo inconveniente, esistono due farmaci che possono essere somministrati in modo da bypassare completamente lo stomaco.
• Apomorfina – questo farmaco, che non può essere assunto per via orale sotto forma di compressa, poiché viene scomposto e reso inattivo nel fegato, è somministrato nel tessuto adiposo sottocutaneo, dove può poi raggiungere il circolo sanguigno. Il farmaco viene iniettato sotto cute oppure somministrato in continuo con l’ausilio di un microinfusore. L’apomorfina può essere efficace per alcuni pazienti ed è comunemente utilizzata in caso di controllo inadeguato della malattia di Parkinson. È possibile somministrarla da sola o in combinazione con farmaci antiparkinsoniani orali.
• Gel a base di levodopa/carbidopa – questo farmaco viene somministrato attraverso una pompa esterna collegata a un catetere impiantato chirurgicamente nella parte superiore dell’intestino, da cui è assorbito nel sangue. Questo metodo consente l’erogazione continua del farmaco per l’intera giornata. Si tratta di una terapia applicati a pazienti affetti da malattia di Parkinson in fase avanzata. Si è rivelata efficace, ma richiede che il paziente sia sempre collegato a una pompa esterna, una condizione che può limitare alcune attività quotidiane.
• DBS
• Procedure chirurgiche alternative
La procedura lesionale, un altro tipo di intervento per il trattamento dei sintomi della malattia di Parkinson, prevede l’inserimento chirurgico, a livello cerebrale, di elettrodi che determinano danni selettivi alle cellule preposte al controllo del movimento, contribuendo così ad evitare il tremore. (Gli elettrodi vengono rimossi al tremine dell’intervento). La procedura lesionale, anche se ancora applicata in alcuni pazienti, è un metodo irreversibile ed è pertanto utilizzata in misura limitata.
Future terapie
Molte ricerche sono in corso per mettere a punto nuove e migliori terapie (tra cui metodi ottimali di erogazione dei farmaci), che contribuiscano a gestire i sintomi della malattia di Parkinson: cellule staminali, ricerca genetica, innesti e trapianti di tessuti neuronali. Sebbene lo sviluppo completo di queste terapie richieda ancora molti anni, forse in futuro esse potranno rivelarsi efficaci nel trattamento della malattia di Parkinson, rappresentando una valida alternativa una volta approvate a livello commerciale; il paziente potrà infatti ricorrervi anche qualora si sia già sottoposto alla stimolazione cerebrale profonda, dal momento che la terapia DBS è una procedura reversibile.
È importante che i pazienti analizzino a fondo tutte queste opzioni terapeutiche con il neurologo, affinché sia garantita la scelta della terapia più indicata, in grado di ridurre i sintomi specifici nel modo più efficace.
Introduzione
La classica sintomatologia motoria della malattia di Parkinson (MP) (tremore, rigidità, acinesia, instabilità posturale) si manifesta quando il processo degenerativo responsabile della malattia ha determinato una riduzione del numero dei neuroni dopaminergici della sostanza nera intorno al 50% e del contenuto di dopamina striatale al di sotto di un livello critico di circa il 70-80%. È indubbio, quindi, che esista una fase pre-clinica della MP idiopatica, la cui durata, tuttavia, è stata oggetto di valutazioni discordanti. Uno studio della funzione nigrostriatale mediante PET con 18F-Dopa ha consentito di correlare l'esordio della sintomatologia motoria ad una riduzione delle cellule superiore al 75% e dimostrando che la fase pre-motoria della malattia possa essere molta lunga e dipenda dall’efficienza dei meccanismi di compenso da parte dei circuiti extra-dopaminerigici correlabile all’età all’esordio. In particolare, i pazienti ad esordio giovanile mostrano una maggior efficacia dei meccanismi di compenso ed un andamento molto più lento del processo degenerativo, tant’è che la durata stimata della fase pre-sintomatica può essere di circa 20 anni nei giovani e di circa 10 anni nei pazienti ad esordio più tardivo.
La MP esprime un processo degenerativo cronico di difficile standardizzazione per la sede della patologia e per le variazioni del fenotipo clinico. In considerazione dell'assenza di un test diagnostico strumentale specifico o di un “marcatore” biologico, la diagnosi di MP è attualmente formulata in base alla verifica di criteri clinici quali quelli proposti dalla ‘United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank’ che identificano tre livelli nel processo diagnostico:
- Riconoscimento di sintomi essenziali per la diagnosi di sindrome parkinsoniana
- Criteri d'esclusione per la diagnosi di MP idiopatica
- Criteri di supporto della diagnosi di MP idiopatica
Una revisione dei criteri diagnostici di MP è stata successivamente proposta da Gelb e colleghi. Tali criteri internazionali (nel cui ambito un ruolo rilevante è rappresentato dalla responsività alla terapia dopaminergica sostitutiva) sono largamente utilizzati nella pratica clinica; tuttavia, il loro rispetto fa sì che la diagnosi di “probabilità” venga formulata quando il paziente presenta da tempo i sintomi motori e comporta, comunque, un margine d'errore relativamente elevato. La disponibilità d'indicatori strumentali o biologici rivestirebbe, quindi, una grande importanza consentendo di distinguere con sicurezza i casi di vera MP idiopatica. Questa possibilità è al momento ipotizzabile solo nei pazienti con forme di parkinsonismo monogenico, ma tali mutazioni sono assai rare e rappresentano una percentuale molto bassa dei casi totali di MP. Appare ovvio come la possibilità d'identificare precocemente la malattia consentirebbe di accorciare la durata del periodo pre-diagnostico anticipando il momento della diagnosi dalla comparsa di sintomi specifici (motori) a quella di sintomi non specifici (non-motori) o addirittura in fase del tutto pre-sintomatica. Una diagnosi precoce o predittiva rivestirebbe grandi vantaggi potenziali ai fini della comprensione dei meccanismi di sviluppo della malattia e, soprattutto, per il potenziale utilizzo di terapie “neuroprotettive”, qualora queste fossero effettivamente disponibili.
Le procedure di valutazione clinica
Non solo la durata della fase prodromica di malattia è incerta, altrettanto incerto risultava se la fase prodromica della MP dovesse considerarsi una fase pre-sintomatica o esclusivamente pre-motoria. In altre parole non era chiaro se negli anni antecedenti la comparsa dei sintomi motori potessero manifestarsi sintomi o disturbi di diversa natura.
Gli studi di stadiazione neuropatologica di Braak e collaboratori hanno consentito un fondamentale passo avanti nella comprensione del processo degenerativo che sottende la MP e fornito un punto di riferimento per lo sviluppo d'ipotesi cliniche riguardo alla possibile identificazione di sintomi predittivi della MP.
Il tradizionale substrato anatomico della MP è rappresentato dalla perdita di neuroni pigmentati nella pars compacta della sostanza nera, ma il “marcatore” neuropatologico del processo degenerativo è costituito dalla presenza d'inclusioni α-sinucleina positive sotto forma di neuriti e corpi di Lewy nei neuroni affetti. La MP sporadica può quindi essere considerata una “sinucleinopatia” cioè un processo multisistemico che colpisce cellule nervose “predisposte” in regioni circoscritte del sistema nervoso, iniziando in due sedi e procedendo attraverso sei stadi topograficamente prevedibili, durante i quali strutture dei sistemi olfattivi, autonomici, limbici e somatomotori vengono progressivamente compromesse.
Alla luce della teoria di Braak e collaboratori una rinnovata attenzione si è focalizzata sullo studio di possibili manifestazioni sintomatologiche che precedano la fase clinica motoria della MP, quali i disturbi dell’olfatto, i disturbi autonomici, i disturbi del sonno e la depressione. Qui di seguito serrano trattati solo i disturbi dell’olfatto mentre per gli altri disturbi si veda la sezione dedicata ai sintomi non motori.
I disturbi dell'olfatto
Sono stati riscontrati in oltre l’80% dei pazienti con MP ed alcuni importanti studi hanno affrontato la questione se precedano o meno la comparsa dei disturbi motori. Ponsen e collaboratori hanno analizzato prospetticamente 78 soggetti asintomatici, parenti di I grado di pazienti con MP sporadica: 40 soggetti risultavano ipo-osmici e 4 di loro sviluppavano una MP entro 2 anni, mentre nei rimanenti 36 soggetti si osservava un tasso di declino nella captazione del DAT superiore a quello osservato nei parenti con normalità dell'olfatto.
Altri studi hanno confermato l’esistenza di un rischio per MP significativamente maggiore nei soggetti con riduzione dell’olfatto e dimostrato una correlazione tra turbe dell’olfatto ed alterazioni del DAT o aumentata ecogenicità della sostanza nera. Tali dati suggeriscono una significativa relazione tra compromissione dell’olfatto ed alterazioni biochimico-strutturali precoci nella MP.
La valutazione clinica dell'olfatto è relativamente semplice e standardizzata (“University of Pennsylvania Smell Identification Test”); tuttavia, occorre ricordare che l’ipo-anosmia è di riscontro relativamente frequente (soggetti fumatori o con rinite) ed è stata descritta anche in altre patologie neurodegenerative (ad esempio, nella variante Lewy-body della malattia d’Alzheimer), per cui la specificità del sintomo iposmia nella diagnosi di MP è ancora incerta. Muller e collaboratori hanno dimostrato come i test olfattivi siano in grado di differenziare casi di MP idiopatica (iposmia grave nell'86%, moderata nel 14%) da casi di parkinsonismo atipico (iposmia moderata nel 70%, normalità nel 30%).
Conclusioni
Numerose evidenze cliniche suggeriscono che la fase pre-motoria della MP è verosimilmente caratterizzata dalla presenza di sintomi non-motori di diversa natura, la cui possibile interpretazione trova riscontro nella stadiazione neuropatologica proposta da Braak e colleghi. In particolare, i disturbi dell'olfatto, la costipazione e l’eccessiva sonnolenza diurna sembrano i sintomi maggiormente indiziati a rappresentare manifestazioni pre-motorie frequenti nella MP. È in corso di valutazione anche la possibilità di utilizzare algoritmi che prevedono la combinazione di più sintomi e/o indagini strumentali. Ad esempio, è stata proposta la combinazione di turbe dell’olfatto e disturbi del sonno REM (supportata dai dati relativi alla correlazione con la captazione del DAT) o dell'esecuzione di test dell’olfatto in associazione ad indagini strumentali (SPECT, sonografia transcranica). È indubbio, tuttavia, che l’attenta raccolta dei dati anamnestici può consentire d’individuare soggetti con un potenziale rischio aumentato di sviluppare la malattia.
Il neuroimaging nella diagnosi differenziale tra la Malattia di Parkinson ed i Parkinsonismi atipici
Introduzione
La diagnosi della MP a tutt’oggi è essenzialmente clinica, basata sul riscontro all’esame obiettivo dei segni cardine della malattia, sull’esclusione di cause secondarie di parkinsonismo e supportata da una buona risposta alla terapia dopaminergica. La corretta applicazione dei criteri diagnostici correnti consente un’accuratezza del 90%. È noto, infatti, che alcune sindromi parkinsoniane secondarie o degenerative, e tra queste principalmente la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) e l’Atrofia Multisistemica (MSA), possono mimare il tipico quadro della MP, rendendo difficile un corretto inquadramento diagnostico, soprattutto nelle fasi iniziali di malattia.
Ormai da parecchi anni tecniche di neuroimaging convenzionale e funzionale sono finalizzate a supportare o escludere una diagnosi altrimenti dubbia. Mentre però l’utilità di esami funzionali quale la SPECT o la PET nella identificazione di alterazioni biochimiche e metaboliche del tessuto cerebrale e quindi di danno funzionale tipico della MP è ormai ben nota, il ruolo di esami morfologici quali la Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) è essenzialmente riservato, nella pratica clinica, all’esclusione di possibili cause secondarie di parkinsonismo.
Neuroimaging strutturale
Malattia di Parkinson
La RMN è un esame ormai divenuto routinario, grazie all’ampia disponibilità sul territorio nazionale e all’accessibilità, anche attraverso regimi di convenzione, che rendono la metodica alla portata di tutti. Pur tuttavia ad oggi le neuroimmagini strutturali non sono sempre di ausilio a supporto della diagnosi di MP. La RMN è, infatti, spesso normale nei pazienti affetti da MP clinicamente definita, anche se numerosi studi hanno in passato dimostrato come sia possibile individuare alterazioni in senso atrofico a carico della substantia nigra, soprattutto della pars compacta. Tale riduzione volumetrica, analogamente a quanto è possibile riscontrare clinicamente, sarebbe asimmetrica nelle fasi iniziali di malattia. Con l’utilizzo di sequenze Inversion Recovery è inoltre possibile evidenziare un’alterazione di segnale a livello della substantia nigra significativa se confrontata con le normali acquisizioni di segnale dei controlli sani, permettendo l’individuazione di soggetti affetti da MP anche prima dell’esordio della sintomatologia clinica. Ciononostante, l’individuazione delle suddette anomalie oltre a richiedere notevole abilità tecnica (sezioni sottili, assenza di artefatti e lunghi tempi di esecuzione) non è da considerarsi patognomonica, essendo riscontrabile anche in altre condizioni degenerative quali l’MSA nella sua variante parkinsoniana (MSA-P). Contrariamente a quanto avviene in altre malattie del sistema extrapiramidale, la RMN non permette di riscontrare nella MP né alterazioni di qualità del segnale né di forma a carico del corpo striato che appare normale anche negli stadi avanzati di malattia.
Parkinsonismo Vascolare
Il principale ruolo della RMN nell’inquadramento diagnostico dei parkinsonismi, dunque, consiste, ancora oggi, nella esclusione di cause secondarie di sindromi extrapiramidali come: infarti profondi, stato lacunare dei gangli della base, idrocefalo normoteso, malattie dismetaboliche. Tra le condizioni di parkinsonismo secondario, il Parkinsonismo Vascolare (PV) rappresenta la condizione, sicuramente, più frequente e non sempre di facile inquadramento diagnostico. Con il termine Parkinsonismo Vascolare si indica una condizione secondaria a lesioni vascolari della sostanza bianca sottocorticale e/o dei gangli della base in grado di determinare un’alterazione funzionale dei circuiti motori striato-talamo-corticali. La diagnosi clinica di PV è, tuttavia, una diagnosi difficile mancando un quadro clinico unitario di riferimento e, soprattutto, perché la presenza di lesioni vascolari dei gangli della base e/o sottocorticali non è patognomonica, potendo le stesse lesioni verificarsi anche in assenza di sintomatologia o coesistere con la MP. I principali quadri neuroradiologici che caratterizzano il PV sono le lesioni lacunari, lo stato cribroso dei gangli della base e più frequentemente le lesioni vascolari diffuse della sostanza bianca sottocorticale a maggiore espressione frontoparietale. Occorre comunque considerare che, sebbene la presenza di una vasculopatia cerebrale alle neuroimmagini morfologiche costituisca un elemento essenziale per la diagnosi di PV, tale reperto non costituisce un criterio assoluto di diagnosi. In atto, quindi, per un corretto inquadramento diagnostico di PV è dunque utile affiancare i reperti di RMN con i dati clinici e le neuroimmagini funzionali quali l’esame SPECT con DATscan.
Atrofia multi sistemica (MSA)
La diagnosi differenziale delle sindromi parkinsoniane è difficoltosa nelle fasi iniziali della malattia anche per il neurologo esperto di disturbi del movimento. La percentuale di errore diagnostico è ancora piuttosto elevata in quanto non esistono segni e sintomi assolutamente specifici per MSA. Attualmente i clinici possono fare affidamento su criteri clinici basati su studi di correlazione anatomo-clinici e su dati sempre più convincenti forniti dall’imaging strumentale. Le alterazioni evidenti alla RM nei pazienti con MSA riguardano soprattutto il putamen, il tronco dell’encefalo e il cervelletto e sono dovute a gliosi e perdita neuronale. Alterazioni neuroradiologiche caratteristiche sono state individuate nella MSA, con pattern diversi nei differenti sottotipi della malattia (cerebellare, MSA-C e parkinsoniana, MSA-P).
• Atrofia multi sistemica sottotipo parkinsoniano, MSA-P
Nel putamen la gliosi, associata a microvacuolizzazione, interessa soprattutto la porzione laterale e dorsale e si evidenzia come stria di iperintensità in T2 e densità protonica. È stata descritta anche una ipointensità in T2 attribuita ad alterazioni del campo magnetico locale indotte da abnorme deposito di ferro e da microgliosi. Tale rilievo, anche se molto sensibile alla malattia in fase precoce, oggi non è considerato totalmente specifico di MSA-P, osservandosi anche a volte nei soggetti normali dopo la sesta decade e pazienti con MP e PSP. La presenza di ferro si rende molto evidente nelle RMN ad alto campo, dove può anche arrivare a mascherare l’iperintensità dovuta all’incremento del contenuto in acqua. La presenza di segnale iperintenso putaminale in densità protonica può essere considerata altamente specifica per MSA-P, ma poco sensibile. La degenerazione dei neuroni striatali gabaergici porta anche a riduzione del volume del putamen.
• Atrofia multi sistemica sottotipo cerebellare, MSA-C
Le alterazioni riscontrate in RMN nei pazienti con forma prevalentemente cerebellare (MSA-C) consistono nell’atrofia della porzione ventrocaudale del ponte e dei peduncoli cerebellari medi, a fronte di un relativo risparmio corticale cerebellare, che ne rende relativamente agevole la diagnosi differenziale con le degenerazioni primitive del cervelletto. Si associa l’aumento del segnale nelle sequenze a TR lungo (T2 e densità protonica) nelle fibre pontine trasverse (che originano dai nuclei del ponte), peduncoli cerebellari medi e cervelletto, secondario alla gliosi in tali sedi. L’atrofia delle fibre longitudinali e trasversali pontine, soprattutto nelle forme in cui è prevalente la componente cerebellare, dà luogo alla tipica iperintensità cruciforme nota come segno “Hot Cross Bun”, reperto anche questo non patognomonico in quanto presente anche in soggetti affetti da atassia spino cerebellare ereditaria, in particolare la SCA1, SCA2 e SCA3. In questi casi tuttavia sono assenti i tipici reperti putaminali.
Paralisi sopranucleare progressiva (PSP)
La RM dimostra solitamente alterazioni agevolmente riconoscibili solo nelle fasi medio-avanzate di malattia. Il quadro più frequentemente descritto è rappresentato dall’atrofia del tegmento mesencefalico con profilo concavo del pavimento del terzo ventricolo dovuto all’atrofia diencefalica, associato in modo variabile a segni di gliosi (iperintensità) nella regione del grigio periacqueduttale ed appiattimento dei collicoli superiori. Tale distribuzione dell’atrofia fa sì che il profilo del tronco-encefalo assuma un aspetto simile a quello di un colibrì, di cui il tegmento mesencefalico rappresenta la testa e il ponte il corpo.
Nei soggetti con PSP il mesencefalo andrebbe incontro ad un’atrofia sette volte maggiore rispetto ai controlli sani, determinando quindi una riduzione del diametro antero-posteriore misurato nelle sequenze assiali. La misurazione del diametro antero-posteriore medio sagittale del mesencefalo (<17 mm) in sequenze T2 pesate è considerata una tecnica semplice, che quindi potrebbe essere di supporto nel differenziare la PSP dalla MP anche se non sembra altrettanto accurata nei confronti della MSA-P.
Sulla base delle alterazioni più frequentemente riscontrate alla RMN convenzionale (0,5 e 1,5 T), Schrag et al. hanno proposto dei criteri per la differenziazione della PSP, MSA-P e MSA-C. Pur tuttavia, l’applicazione dei suddetti criteri consentirebbe un corretto inquadramento diagnostico nel 74% dei casi con PSP e nell’83% dei casi con MSA-C, ma solo nel 50% dei soggetti affetti da MSA-P.
Nuovi marcatori diagnostici precoci di MSA e PSP
Negli ultimi anni numerosi sono stati gli studi rivolti all’individuazione di nuovi markers diagnostici precoci che, affiancandosi alla storia clinica, possano essere d’ausilio nell’inquadramento diagnostico della MSA e della PSP in una fase iniziale. È un dato ormai acquisito che il mesencefalo e i peduncoli cerebellari superiori sono marcatamente atrofici nella PSP, mentre il peduncolo cerebellare medio e il ponte sono maggiormente interessati nella MSA.
Tra i possibili marker recentemente individuati, particolarmente utile, a supporto della diagnosi di MSA, sarebbe la misurazione del diametro trasverso del peduncolo cerebellare medio in sezioni sagittali T1 pesate. Tale parametro consentirebbe di differenziare, con alti livelli di specificità e sensibilità soggetti affetti da MSA da quelli affetti da MP e dai controlli.
A supporto della diagnosi di PSP, invece, è stata recentemente proposta la misurazione dell’area del mesencefalo. In particolare, lo studio di Oba e collaboratori ha evidenziato che l’area media del mesencefalo era significativamente minore nei pazienti con PSP (56,0 mm2), rispetto ai pazienti con PD (117,7 mm2) ed ai pazienti con MSA-P (97,2 mm2). Secondo gli stessi autori, di maggiore utilità sarebbe l’utilizzo del rapporto Area Mesencefalo/Area Ponte, significativamente più basso nei soggetti affetti da PSP rispetto ai pazienti con PD e MSA-P, non dimostrando il suddetto indice alcuna sovrapposizione nei valori individuali. In particolare, il riscontro di un’area del mesencefalo <70 mm2 sarebbe indicativo di PSP con una sensibilità del 100% ed una specificità del 91,3%, mentre un rapporto Area Mesencefalo/Area Ponte <0,15 sarebbe fortemente indicativo di PSP con una sensibilità ed una specificità del 100%.
Va tuttavia rilevato che i suddetti parametri derivano da studi generalmente condotti su gruppi di 15-20 pazienti, e che quindi necessitano di ulteriori conferme. Ciononostante, essi appaiono di notevole importanza poiché basati su misurazioni di facile esecuzione da effettuarsi su RMN convenzionale e quindi potenzialmente utili nella pratica clinica.
Degenerazione cortico-basale
Nelle fasi iniziali di malattia la RM rivela in genere atrofia corticale frontoparietale unilaterale. L’atrofia interessa soprattutto l’area premotoria, le circonvoluzioni parietali superiori, lo striato e la corteccia frontale dorsale 22. Tale rilievo si associa a volte alla presenza di rima corticale ipointensa in T2 e densità protonica nel giro precentrale, da verosimile accumulo di materiale paramagnetico, quale segno di demielinizzazione o gliosi. Con criteri di quantificazione tridimensionale è possibile differenziare la degenerazione cortico-basale, che mostra una prevalente atrofia parietale, dalla PSP in cui l’atrofia cerebrale è più diffusa. La tipica asimmetria nella distribuzione dell’atrofia corticale è particolarmente evidenziabile nelle sezioni coronali. Il ventricolo ispilaterale alla corteccia atrofica è ampliato. Inoltre, sono state evidenziate alterazioni putaminali simili a quelle della degenerazione striato-nigrica, ma localizzate unilateralmente. Con l’avanzare della malattia, le alterazioni corticali e putaminali sembrano diventare bilaterali. A differenza della PSP, il mesencefalo è normale nei pazienti con degenerazione cortico-basale.
Demenza a corpi di Lewy
Lo studio di Barber e collaboratori ha invece permesso di dimostrare l’utilità della RMN nella diagnosi differenziale tra la demenza a corpi di Lewy e la Malattia di Alzheimer, per la minore atrofia corticale del lobo temporale che invece risulta più accentuata nella Malattia di Alzheimer. Inoltre, a differenza della demenza di Alzheimer, nella demenza a corpi di Lewy si avrebbe una minore atrofia ippocampale e una maggiore atrofia a carico di mesencefalo, ipotalamo e corteccia temporo-parietale. Tra l’altro, tale atrofia seguirebbe una evoluzione caudo-craniale e ciò trova anche riscontro con quanto evidenziato da recenti studi neuropatologici per i quali nella demenza a corpi di Lewy si avrebbe una progressione ascendente per compromissione di differenti circuiti neurotrasmettitoriali, che coinvolgono in primo luogo il mesencefalo.
Neuroimaging funzionale
Introduzione
I metodi di imaging funzionale si suddividono in due classi: metodi che forniscono informazioni riguardanti l’attività sinaptica, spesso detti mappaggi funzionali o studi di attivazione e metodi che forniscono informazioni di natura chimica o neurochimica (metodi neurochimici). I primi si basano su alcune forme di mappaggio di perfusione, in considerazione della stretta correlazione tra il metabolismo del glucosio ed il flusso ematico cerebrale locale; in alternativa essi sfruttano le modificazioni delle quantità relative di ossi-emoglobina e desossi-emoglobina nel sangue conseguenti all’evidente sproporzione tra consumo di ossigeno e flusso ematico indotta dall’attivazione funzionale. I metodi neurochimici sono invece basati sull’identificazione di sostanze chimiche di interesse grazie all’utilizzo di un radioligando appropriato o grazie alle proprietà paramagnetiche intrinseche di un composto: essi comprendono le tecniche di tomografia ad emissioni di positroni (PET) e tomografia computerizzata ad emissione di fotone singolo (SPECT).
Studio dell’attività metabolica
La differenza fondamentale tra PET e SPECT è la sensibilità. La PET può misurare distribuzioni di radioattività nel cervello in unità assolute, ovvero i segnali possono essere calibrati.
La calibrazione in unità assolute risulta possibile in quanto la sensibilità per la ricerca di radiazioni è uniforme attraverso la testa; inoltre può essere effettuata un’accurata correzione per l’attenuazione del segnale derivata dal parenchima cerebrale, dal cranio e dalla pelle; infine il territorio di valutazione può essere delineato precisamente e con modalità elettronica. Queste caratteristiche si traducono in una miglior qualità dell’immagine con un’esposizione alle radiazioni sostanzialmente minore rispetto alla SPECT. La PET è più costosa della SPECT ed il minor costo è proprio il principale vantaggio di quest’ultima tecnica, nella quale la correzione dell’attenuazione è approssimativa, la sensibilità si riduce con il quadrato della distanza dalla superficie di rilevamento e il territorio di valutazione deve essere limitato dalla pesante collimazione che comporta una sostanziale perdita di segnale e conseguentemente di sensibilità. Tuttavia, la SPECT presenta dei vantaggi che la rendono particolarmente utile per lo studio della Malattia di Parkinson (MP), come descritto in seguito.
I traccianti più semplici e più frequentemente utilizzati in studi di perfusione e metabolismo mediante PET sono [15O]H2O, che serve a misurare il flusso di sangue cerebrale (CBF), e il [18F]fluorodesossiglucosio (FDG), che serve a misurare il metabolismo cerebrale del glucosio.
Il CBF è proporzionale all’attività sinaptica, quindi variazioni nella frequenza di scarica neuronale sono riflesse da variazioni nel CBF.
Numerosi studi hanno evidenziato una riduzione del metabolismo e/o flusso cerebrale a livello corticale e dei nuclei della base generalmente più frequente nei pazienti con MP in fase avanzata e di entità maggiore in pazienti con disturbi cognitivi e depressivi. Studi PET hanno evidenziato una minore attivazione dell’area supplementare motoria (SMA) e della corteccia prefrontale (PFC) in pazienti con MP e non in terapia. Parallelamente è stata invece descritta un’iperattività della corteccia laterale premotoria e della corteccia parietale nelle fasi più avanzate di malattia. L’iperattività compensatoria è stata interpretata come un meccanismo per bilanciare la disfunzione del circuito motorio cortico-gangli della base-talamo-corticale; una spiegazione alternativa giustifica l’iperattività della corteccia premotoria e parietale come un deficit di restrizione dell’attività neuronale al solo circuito motorio che normalmente è il solo ad essere attivato durante un esercizio.
Questi dati sono tuttavia ancora preliminari e la distinzione in ipoattività legata ad un esercizio motorio e iperattività compensatoria è semplicistica e riduttiva. In particolare, nella MP le aree di ipo- o iperattività sono legate al tipo di esercizio motorio e modulate dalle capacità attentive del paziente.
Imaging molecolare del sistema nigro-striatale
Recettori pre-sinaptici
Attività striatale dell’enzima dopa-decarbossilasi: [18F]dopa/PET
Garnett e collaboratori hanno per primi descritto nel 1984 l’utilizzo di [18F]dopa/PET per visualizzare il sistema dopaminergico nigro-striatale. La [18F]dopa, un precursore della dopamina, dopo un’iniezione endovenosa, supera la barriera ematoencefalica ed è captata dai neuroni dopaminergici e poi trasformata in [18F]dopamina dall’enzima dopa-decarbossilasi (DCC). Il suo accumulo riflette pertanto l’attività striatale dell’enzima DCC e consente di identificare la presenza di alterazioni del sistema dopaminergico anche in una fase molto precoce della malattia; poiché tuttavia la sua captazione dipende dall’enzima DCC, non è un marcatore puro della numerosità neuronale. Inoltre, è provato che la DCC è regolata anche dai farmaci usati nella MP che quindi possono compromettere la captazione di [18F]dopa. La capacità della [18F]dopa di identificare pazienti parkinsoniani, anche in fase molto precoce della malattia, è stata potenziata dall’uso di nuove tecnologie e la sensibilità di questo tracciante raggiunge praticamente il 100%. Questa metodica ha permesso di osservare che le manifestazioni cliniche della MP compaiono quando la riduzione delle cellule dopaminergiche nel putamen supera il 50% dei valori normali e che l’uptake di [18F]dopa nel globo pallido interno è aumentato nelle fasi iniziali di malattia per poi ridursi progressivamente con il progredire dei sintomi. Studi clinici hanno inoltre evidenziato che la captazione con [18F]dopa è correlata con le scale per la rigidità e la bradicinesia. Un notevole interesse è stato posto nell’utilizzo della PET con [18F]dopa nell’individuazione di pazienti a rischio di MP, soprattutto in soggetti predisposti geneticamente a questa malattia. Sono stati condotti studi in coppie di gemelli di cui uno era affetto da MP, che hanno mostrato alterazioni sub-cliniche in gemelli clinicamente sani sia tra gemelli monozigoti che dizigoti, ad indicare che fattori aggiuntivi possono contribuire allo sviluppo della malattia. In uno studio successivo di follow-up, le alterazioni nei gemelli monozigoti erano progredite tanto da determinare lo sviluppo di segni clinici di MP in una percentuale consistente di soggetti.
Studi di imaging con [18F]dopa e PET sono stati recentemente utilizzati per indagare e quantificare il miglioramento di pazienti con MP trattati con fattore neurotrofico derivato da cellule gliali (GDNF); pazienti con infusione continua di GDNF per 12 mesi direttamente nel putamen posteriore hanno dimostrato, oltre ad un miglioramento clinico, un aumento del 18-24% dell’uptake di [18F]dopa. La PET tuttavia fa uso di una strumentazione costosa ed in dotazione solo a pochi centri; non può essere quindi utilizzata nello screening di un numero consistente di pazienti.
Trasportatore della dopamina pre-sinaptico striatale: DATSCAN Le fibre dei neuroni nigro-striatali effettuano il reuptake della dopamina attraverso una proteina di membrana presente nelle terminazioni pre-sinaptiche, detta trasportatore della dopamina (DAT). La perdita delle proiezioni nigro-striatali in pazienti con MP si riflette in una riduzione del DAT nello striato. Studi post-mortem hanno dimostrato che il DAT risulta ridotto nello striato dei pazienti con MP in maniera proporzionale alla diminuzione delle fibre dei neuroni dopaminergici.
I traccianti specifici per i DAT includono ligandi marcati con radioisotopi positroni-emittenti, quali 18F e 11C, utilizzati in PET e gamma-emittenti, quali 123I e 99mTc, utilizzati in SPECT. In particolare, alcuni di questi ultimi, quali [123I]FP-CIT e [123I]β-CIT hanno avuto ampio impiego per lo studio funzionale pre-sinaptico dopaminergico con SPECT nella MP. [123I]FP-CIT o Ioflupano è un radiotracciante derivato dalla famiglia dei tropani che si lega selettivamente al DAT e può essere considerato un marker biologico di degenerazione del sistema dopaminergico. Una volta iniettato e.v., lo Ioflupano ha una rapida clearance ematica, con circa il 95% della dose somministrata eliminata dal circolo dopo i primi 5 minuti ed il 98% dopo 15 minuti. L’attività a livello dello striato mostra un andamento crescente con picco a tre ore dalla somministrazione e successivo plateau sino a sei ore; ciò rende possibile l’acquisizione SPECT in un intervallo da tre a sei ore dall’iniezione del radiocomposto.
Nella condizione di equilibrio farmacocinetico, le concentrazioni del radiofarmaco nel compartimento specifico (a livello dello striato) e nel compartimento non specifico (corteccia occipitale, in cui non sono presenti le fibre dopaminergiche), sono costanti e pertanto il rapporto di concentrazione dello Ioflupano in questi due compartimenti consente di ottenere una misura dell’attività proporzionale alla densità DAT striatale.
La commercializzazione in Europa del [123I]FP-CIT (nome commerciale DATSCAN) ha reso possibile l’applicazione di questo tracciante SPECT in ambito clinico; numerosi studi hanno dimostrato che l’utilizzo di questo tracciante SPECT consente di discriminare, con una specificità superiore al 95%, tra pazienti con sindrome parkinsoniana e soggetti affetti da tremore extrapiramidale indotto da farmaci o tossine o con tremore essenziale; più recentemente, questo tracciante è stato inoltre utilizzato per la diagnosi differenziale tra demenza a corpi di Lewy e malattia di Alzheimer.
Sfortunatamente, sia studi di imaging con PET che SPECT hanno scarsa sensibilità nel differenziare la MP da altre sindromi parkinsoniane. Anche i parkinsonismi atipici infatti si manifestano scintigraficamente con una diminuita captazione striatale, sebbene in queste malattie e soprattutto nella MSA e nella PSP l’ipoattività appaia simmetrica e meno regione specifica, con uguale compromissione del caudato e del putamen.
I biomarcatori
Un marcatore è un indicatore biologico o strumentale che permette di diagnosticare precocemente una malattia, monitorare la storia naturale e valutare l’efficacia di farmaci potenzialmente in grado di modificarne il decorso. Negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi nella ricerca sui marcatori della malattia di Parkinson (MP), ma nonostante questo non sono ancora disponibili marcatori validi e di facile utilizzo.
Marcatori biologici
L’alfa-sinucleina è una proteina che, nella sua forma fosforilata, costituisce i corpi di Lewy (aggregati proteici anomali che si accumulano nel citoplasma delle cellule nervose dei pazienti con MP). In un cervello normale l’alfa-sinucleina fosforilata costituisce solo il 4%, mentre essa risulta aumentata a livello ematico nei pazienti affetti da MP rispetto ai controlli sani. Elevati livelli di alfa-sinucleina si riscontrano nel liquor di pazienti con MP rispetto a soggetti di controllo e a pazienti affetti da altre malattie neurodegenerative. Tuttavia, sebbene elevati livelli di questa proteina possano essere indicativi di malattia, non è chiaro se essi correlino con la gravità e la durata della patologia.
Livelli elevati di proteina DJ-1 sono stati riscontrati nel liquor di pazienti affetti da MP, ma non correlano con la gravità di malattia, mentre elevati livelli delle isoforme 4 e 7 di questa proteina si riscontrano nel sangue di pazienti parkinsoniani nelle fasi avanzate di malattia.
Elevati livelli di acido urico nel siero di pazienti parkinsoniani si associano ad una progressione più lenta di malattia. Nei soggetti sani, elevati livelli di acido urico si associano ad un minore rischio di sviluppare.
E’ stato riportato che elevati livelli di beta-amiloide nel liquor di pazienti con MP predicono lo sviluppo di un successivo deterioramento cognitivo. Allo stesso modo, bassi livelli di Fattore di Crescita dell’Epidermide (EGF) nel plasma di pazienti parkinsoniani potrebbero essere un fattore di rischio per il successivo sviluppo di demenza.
Marcatori genetici
Mentre la maggior parte delle forme di MP sono idiopatiche e non hanno alcuna causa genetica nota, le mutazioni che causano le forme genetiche di MP sono di grande aiuto per lo studio dei meccanismi che contribuiscono alla patogenesi della MP e come marcatori preclinici di MP. In particolare, le mutazioni genetiche a maggiore prevalenza possono essere utilizzate per gli studi sui marcatori premotori di MP: parkina, glucocerebrosidasi (GBA), e LRRK2 (leucine-rich repeat kinase-2). Le mutazioni del gene della parkina sono responsabili della maggior parte delle forme giovanili, ad esordio precoce di MP. Studiare i soggetti affetti da queste mutazioni nella fasi presintomatiche di malattia permetterebbe di investigare i biomarcatori più rilevanti nelle forme ad esordio giovanile di MP. Le mutazioni del gene LRRK2 sono tra le più studiate e sono responsabili di una forma autosomica dominante che è clinicamente molto simile alla MP idiopatica. I soggetti portatori di mutazioni del gene GBA hanno un aumentato rischio di sviluppare una MP, secondo alcuni studi a progressione più rapida e con un maggior rischio di demenza. Seguire nel tempo i portatori di queste mutazioni, che hanno un’elevata probabilità di passare da asintomatici ad affetti, è estremamente utile per studiare la progressione di malattia, migliorare la conoscenza di altri biomarcatori e sviluppare possibili strategie terapeutiche.
Marcatori di neuroimaging
La densità del trasportatore della dopamina (DAT) misurata con la SPET grazie ad un tracciante specifico è in grado di predire lo sviluppo della MP e di monitorare la progressione della malattia. La captazione della F-DOPA misurata con la PET mostra anch’essa una riduzione progressiva nel corso della malattia ed è stata usata per valutare l’effetto di alcuni farmaci potenzialmente neuroprotettivi.
La Risonanza Magnetica Nucleare funzionale e volumetrica sono state utilizzate per studiare la progressione dei segni motori e cognitivi della MP, ma al momento non ci sono evidenze definitive sull’utilità di queste metodiche avanzate per monitorare la storia naturale della MP.
L’ecografia della sostanza nera si è rivelata una tecnica utile per la diagnosi precoce della MP, poiché i pazienti affetti presentano un aumento del segnale della sostanza nera rispetto ai soggetti di controllo. Sembra inoltre che questa alterazione riscontrata in soggetti sani sia associata ad un aumentato rischio di ammalarsi di MP. L’iperecogenicità della sostanza nera, tuttavia, non si modifica nel corso della malattia e quindi non può essere utilizzata come marcatore di progressione.
Biomarcatori della fase preclinica
E’ ormai noto che alcuni segni e sintomi possono precedere anche di anni la comparsa dei segni motori della MP. Tali segni possono pertanto essere considerati biomarcatori della fase preclinica di malattia ed essere usati per identificare i soggetti a rischio di ammalarsi di MP. Tra questi, il più noto è la riduzione del senso dell’olfatto o iposmia, che è presente in più del 90% dei pazienti con MP e può precedere di 2-7 anni l’esordio dei sintomi motori. E’ un sintomo facile da identificare, anche attraverso specifici test dell’olfatto, ma non è da considerare un marcatore specifico per la MP.
Il disturbo comportamentale del sonno REM può precedere la diagnosi di MP anche di 20 anni ed è il più specifico tra i segni premotori della MP. E’ caratterizzato da movimenti violenti e agitazione durante il sonno REM (è come se il soggetto mettesse in atto quello che sta sognando) e può essere diagnosticato attraverso un esame effettuato durante il sonno che si chiama polisonnografia.
La stitichezza può precedere lo sviluppo di MP di più di 20 anni, come dimostrato da un esteso studio epidemiologico, ma trattandosi di un sintomo estremamente diffuso nella popolazione generale, non può essere usato come un marcatore specifico per la diagnosi precoce di MP. La depressione del tono dell’umore può precedere i sintomi motori della MP di 5-6 anni fino al 40% dei pazienti ed è comunemente considerata un fattore di rischio per la MP. Anche questo sintomo tuttavia non è abbastanza specifico da poter essere consigliato come marcatore precoce di MP.
Conclusioni
Sono in corso diversi studi prospettici per valutare i marcatori della MP sia in pazienti in fase iniziale di malattia che in soggetti a rischio di ammalarsi di MP (familiari di pazienti, portatori di mutazioni genetiche note, soggetti affetti da disturbo comportamentale del sonno REM e/o iposmia e/o depressione). Da questi studi, grazie all’arruolamento di grandi popolazioni e all’impiego di procedure standardizzate, si attende un significativo avanzamento delle conoscenze sulla progressione di malattia e i biomarcatori ad essa correlati. L’identificazione di marcatori validi e affidabili nel monitorare la progressione della malattia permetterà di accelerare i progressi della ricerca sia per quanto riguarda l’eziologia che la terapia della MP. Ci sono evidenze che gli studi sui marcatori biologici (presenti nel sangue o nel liquor) e con tecniche di neuroimaging avanzate potranno fornire strumenti utili per lo sviluppo di nuovi farmaci e in ultima analisi per migliorare il trattamento dei pazienti affetti da MP. E’ possibile che lo studio contemporaneo di diversi marcatori biologici e strumentali, attualmente in corso di valutazione in alcuni studi prospettici su un gran numero di pazienti o di soggetti a rischio di ammalarsi di MP, si riveli utile per diagnosticare precocemente e seguire nel tempo la progressione della MP.
Dott. Maria Teresa Pellecchia
Centro per le Malattie neurodegenerative
Università di Salerno
Sintomi motori
Sintomi non motori
- Disturbi sensitivi
- Disturbi autonomici
- Disturbi comportamentali
- Disturbi cognitivi
- Disturbi del sonno
- Ansia e depressione
I segni cardinali motori della Malattia di Parkinson (MP) sono tremore, bradicinesia, rigidità e, più tardivamente nel corso della malattia, alterazione dei riflessi posturali. Accanto a questi segni motori primari, vi è una serie di segni motori come la distonia, le alterazioni posturali del tronco, la disfagia, la disartro-disfonia ed il freezing della marcia che possono presentarsi nel decorso della malattia.
La MP giovanile è clinicamente simile alla MP ad esordio senile, sebbene vi siano alcune peculiarità che distinguono i casi giovanili. In generale, nei pazienti con MP giovanile la progressione di malattia tende ad essere più lenta, le complicanze motorie (fluttuazioni motorie e discinesie) si verificano più precocemente ed i disturbi psichiatrici di tipo affettivo (depressione, ansia) e comportamentale (disturbo del controllo degli impulsi), sono più frequenti. Nella MP giovanile la distonia si associa frequentemente al parkinsonismo ed i disturbi cognitivi ed assiali (instabilità posturale, cadute, anomalie posturali del tronco) sono meno frequenti, potendo manifestarsi molto tardivamente dopo numerosi anni di malattia, in età più avanzata.
La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie che determinano l’assunzione di posture anomale. Tipica della MP è la distonia del piede, caratterizzata spesso dall’ intrarotazione e flessione plantare del piede oppure dall’eccessiva flessione delle dita del piede. Tale disturbo può essere il primo segno d’esordio della MP nei casi giovanili, ed in particolar modo in quelli associati a mutazione del gene parkina.
La lentezza nell’esecuzione dei movimenti viene denominata bradicinesia ed è la caratteristica clinica principale della MP. Un aspetto caratterizzante la bradicinesia nei pazienti con MP è altresì la progressiva riduzione di ampiezza dei movimenti (ipocinesia). La bradicinesia determina difficoltà nel pianificare, iniziare ed eseguire gesti motori, soprattutto in sequenza o simultanei. Spesso all’esordio della malattia, quando le manifestazioni cliniche sono modeste, asimmetriche e difficili da interpretare, la bradicinesia si manifesta come un impaccio motorio nell’esecuzione dei movimenti fini della mano o nell’uso dell’arto inferiore; conseguentemente, il paziente riferisce difficoltà nell’abbottonare la camicia, nel radersi, nel tagliare il cibo, nell’usare la frizione dell’auto. La bradicinesia si può manifestare anche nella scrittura con riduzione di ampiezza della grafia (micrografia). Quando la malattia è conclamata, altre manifestazioni della bradicinesia includono la paucità di movimenti spontanei, la difficoltà a deglutire, la riduzione del volume vocale (ipofonia) e la riduzione dell’espressività facciale (ipomimia).
Il tremore a riposo è uno dei sintomi più comuni e più facilmente riconoscibili della MP; talvolta, i pazienti riferiscono altresì la sensazione di un “tremore interno”, sebbene non sia evidente all’esame clinico. All’esordio della malattia, il tremore è incostante, localizzato alla mano, con caratteristica abduzione-adduzione del pollice e di flesso-estensione dell’indice e delle altre dita (tipo “contar monete”). L’arto inferiore può essere una sede d’esordio del tremore parkinsoniano, sebbene meno frequentemente. Il tremore ha una frequenza di 4-6 Hz, si accentua a seguito di stimoli emotivi, si attenua o scompare durante il movimento volontario, scompare durante il sonno. Come per gli altri sintomi cardinali, è unilaterale all’esordio, mantenendo una prevalenza di lato con la progressione della malattia. Il tremore a riposo può coinvolgere le labbra, il mento, la mandibola e gli arti inferiori, mentre il capo o la voce sono raramente interessati. Il tremore scompare durante l’esecuzione di un movimento e nel sonno.
La rigidità consiste in un aumento del tono muscolare e si caratterizza come una resistenza continua e costante durante la mobilizzazione passiva dei segmenti articolari (ipertono plastico). La rigidità può essere presente sia prossimalmente (collo, spalla, anca) che distalmente (polso e caviglia) e prevale nei gruppi muscolari flessori e adduttori, determinando la caratteristica postura anteroflessa del capo e del tronco. Durante la mobilizzazione passiva è possibile apprezzare piccoli, regolari e ritmici cedimenti dell’ipertonia muscolare come se il segmento fosse articolato su una ruota dentata (fenomeno della ruota dentata), in particolar modo alle articolazioni di gomito e polso. Una delle conseguenze della rigidità è il dolore, che è si localizza spesso alla spalla oppure all’anca; l’esordio della MP con dolore è frequente e, talora, i pazienti ricevono una diagnosi erronea di artrite, sindrome della cuffia dei rotatori o discopatia lombo-sacrale prima di giungere all’attenzione del neurologo.
Sintomi motori
↑ Torna
L’ instabilità posturale è un segno tardivo della MP causata dalla perdita dei riflessi posturali e responsabile di cadute ed evidenziabile semeiologicamente con la “prova della spinta”. Tale segno, tardivo nella MP, è invece precoce nei parkinsonismi atipici come l’Atrofia Multisistemica e la Paralisi Sopranucleare Progressiva. L’instabilità posturale, insieme con il freezing della marcia, è uno degni segni che maggiormente impatta la qualità di vita dei pazienti, determinando un aumentato rischio di frattura del femore. È importante sottolineare come altri fattori possono determinare instabilità posturale nella MP, a parte la perdita dei riflessi posturali, alcuni dei quali correggibili farmacologicamente: l’ipotensione ortostatica, il sopradosaggio di farmaci dopaminergici e le discinesie ad esso correlate, le alterazioni posturali del tronco.
Caratteristico è il disturbo della deambulazione nella MP. Sin dalle fase iniziali, vi è riduzione dei movimenti pendolari degli arti superiori e riduzione dell’ ampiezza e della velocità del passo; l’asimmetria di tali segni può determinare trascinamento dell’arto inferiore oppure difficoltà nel girare dal lato più affetto. Con il progredire della malattia, può comparire il freezing della marcia, ossia il blocco della deambulazione quando il paziente incontra un ostacolo, inizia la deambulazione, gira oppure attraversa passaggi stretti.
Alcuni pazienti con una lunga durata di malattia ed un’età avanzata possono sviluppare alterazioni posturali del tronco e del capo. Il tronco può essere flesso anteriormente (camptocormia) oppure lateralmente (Sindrome di Pisa). Più raramente, il capo può essere flesso anteriormente (capo cadente). Il meccanismo di tali disturbi della postura non è ancora bene chiaro, ma sembra essere dovuto a molteplici fattori, fra cui la perdita di controllo di muscoli che regolano la postura dei muscoli assiali e la secondaria sofferenza muscolare determinata dal mancato utilizzo di tali muscoli.
Infine, la difficoltà nell’articolazione delle parole e dell’eloquio è un sintomo motorio comune nella MP. L’abbassamento del volume vocale (ipofonia) è l’aspetto più frequente mentre disturbi della produzione verbale più complessi si possono riscontrare in pazienti con parecchi anni di malattia ed età avanzata.
L’instabilità posturale, il disturbo della deambulazione e dell’eloquio e le deformità posturali rappresentano i sintomi motori assiali. Pur essendo difficoltoso il loro trattamento dal punto di vista farmacologico, negli ultimi anni numerosi studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia della riabilitazione neurologica e della logopedia a cui il paziente parkinsoniano dovrebbe essere indirizzato sin dalle fase più precoci della malattia.
Dott. Francesca Morgante
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Messina- Messina
Sintomi non motori
I disturbi sensitivi
↑ Torna
Nel gruppo dei sintomi non motori della malattia di Parkinson (MP) sono compresi i sintomi sensitivi quali il dolore, le parestesie (sensazioni spiacevoli come formicolii, intorpidimento, sensazione di calore o di freddo, bruciori, sensazione di tremore interno, sensazione di rigidità etc a carico di una o più regioni del corpo), i disturbi dell’olfatto ed i disturbi della vista.
Dolore
Il dolore rappresenta certamente il sintomo sensitivo più importante della MP in quanto responsabile di un peggioramento significativo della qualità di vita dei pazienti.
Ciononostante, resta tuttora un problema spesso non riconosciuto e solo poco più della metà dei pazienti parkinsoniani che presentano dolore assumono una terapia analgesica adeguata. La comparsa di dolore è descritta in una percentuale variabile di parkinsoniani (40-85%) e può essere direttamente legata alla MP ed alla sua terapia (dolore correlato al Parkinson) o meno (dolore non correlato al Parkinson).
Il dolore correlato al Parkinson si distingue in vari sottotipi: il dolore distonico (associato a posture o movimenti distonici) ed il dolore non-distonico che comprende il dolore muscolo-scheletrico (crampi, sensazione di irrigidimento, dolore articolare), il dolore neuropatico o radicolare (la cui distribuzione rispetta il territorio di innervazione di un nervo o radice nervosa spesso legato a cause diverse dal Parkinson) ed il dolore centrale (dolore indefinito e persistente, scarsamente localizzato). La presenza di dolore è descritta in tutti gli stadi di malattia e la sua intensità è riferita come moderata o severa da ben il 50% dei pazienti; in circa il 15 % dei casi, inoltre, il dolore precede la comparsa dei sintomi motori tipici della malattia (in media di 18 mesi) e tende ad essere localizzato nell’arto che sarà colpito per primo da questi ultimi.
Il dolore più frequentemente descritto nei parkinsoniani è quello muscoloscheletrico (46,4 %) seguito dal dolore distonico e dal dolore radicolare o centrale; presenta più spesso carattere intermittente ed interessa prevalentemente le estremità (in particolare le gambe e dal lato maggiormente compromesso dal punto di vista motorio) e la colonna lombare. In diversi studi è segnalata un’associazione tra dolore e depressione. Nel Parkinson ad esordio giovanile la presenza di dolore è riportata meno frequentemente che nel Parkinson ad esordio tardivo e, ancor meno frequentemente, nei pazienti portatori di mutazioni del gene Parkina.
La presenza di distonia (postura anomala di un arto) dolorosa, tuttavia, può costituire il sintomo di esordio del Parkinson giovanile, soprattutto nei casi dovuti a mutazioni del gene Parkina. Più frequentemente, però, il dolore distonico compare nelle fasi avanzate di malattia nei pazienti in trattamento con levodopa in associazione alle fluttuazioni motorie (distonia dolorosa in “OFF” tipicamente a carico di un piede e più frequentemente al primo mattino o distonia di inizio e/o fine dose). Si possono anche osservare episodi dolorosi durante le fasi “ON”, associati a severe discinesie di picco dose o alla comparsa di discinesie in pazienti con problemi osteo-articolari. Nelle fasi OFF possono anche presentarsi dolori addominali, toracici, affanno, parestesie, sensazioni di freddo o di caldo e sensazioni di "addormentamento" che tendono a migliorare con l’assunzione della terapia.
Sono descritti anche dolori buccali (burning mouth syndrome) e genitali seppure raramente. Tra i sintomi sensitivi viene inclusa anche l’acatisia ovvero una sensazione di tensione ed irrequietezza psicomotoria con impossibilità a restare fermi riportata da oltre il 40% dei pazienti parkinsoniani. La presenza di dolore sembra attribuibile ad una modificata elaborazione e percezione degli stimoli dolorosi da parte del cervello dei pazienti parkinsoniani; fattori periferici quali alterazioni posturali, rigidità muscolare, deformità articolari e altre patologie associate possono contribuire all’insorgenza di dolore.
La presenza di dolore nella MP può essere indagata mediante l’utilizzo di questionari specifici per la MP, ma indirizzati in genere alla ricerca dei sintomi non motori (ad es. la Non motor symptoms scale) o mediante questionari specifici per il dolore (Brief Pain Inventory etc).
L’intensità del dolore può essere valutata mediante Scale Analogiche Visive (VAS) costituite da una retta che va da 0 a 100 su cui si chiede al soggetto di indicare a quale punto della retta corrisponde l’intensità del suo dolore.
Proprio per l’importante impatto che il dolore ha sulla qualità di vita dei pazienti parkinsoniani è fondamentale ricercarne la presenza ed individuarne la tipologia al fine di impostare un trattamento adeguato. Per i dolori legati alla MP, come le OFF distonie o i dolori secondari alla rigidità ed alla bradicinesia, nonché alcuni dolori centrali che compaiono nelle fasi OFF, spesso è sufficiente adeguare la terapia dopaminergica ed, in particolare, lo schema di somministrazione della levodopa. In alcuni casi in cui il dolore sia causato da posture distoniche persistenti non migliorate dalle variazioni della terapia dopaminergica, l’utilizzo della tossina botulinica può essere utile. Anche il trattamento chirurgico della MP con Deep Brain Stimulation (DBS) è associato ad un marcato miglioramento del dolore e dei disturbi sensitivi in oltre l’80% dei pazienti trattati.
Vi sono, inoltre, dati sull’efficacia della duloxetina (un antidepressivo) nel trattamento del dolore cronico nei parkinsoniani. Nei casi in cui il dolore non sia legato al Parkinson o non risponda a tali strategie è necessario ricercare e trattare eventuali condizioni associate quali ad esempio la depressione o patologie dolorose concomitanti.
Disturbi dell’olfatto
La riduzione (iposmia) o la perdita dell’olfatto (anosmia) sono oramai inequivocabilmente riconosciute come sintomi tipici e precoci della MP che, spesso, precedono la comparsa dei sintomi motori.
Solo raramente vengono riferite dai pazienti e, in alcuni casi, possono associarsi a riduzione o perdita del gusto. A differenza del dolore l’importanza di tali sintomi risiede più che nel loro impatto clinico nel loro possibile significato prognostico. La loro presenza, infatti, è spiegata dal precoce interessamento dei neuroni dopaminergici presenti nel bulbo olfattivo (prima stazione delle vie dell’olfatto) da parte dei processi degenerativi responsabili della MP.
Per questo motivo, quindi, insieme ad altri sintomi e dati strumentali, i disturbi dell’olfatto sono allo studio come potenziali marcatori per una diagnosi precoce della MP o, addirittura, per l’individuazione di soggetti sani a rischio di svilupparla nel tempo. Alcuni studi hanno indagato la presenza di deficit dell’olfatto nei pazienti con MP ad esordio giovanile trovando un olfatto normale nei pazienti con mutazioni a carico di entrambi i geni della Parkina ed una riduzione dell’olfatto simile a quella dei parkinsoniani ad esordio tardivo nei pazienti in cui era mutata una sola copia del gene Parkina o nei pazienti con parkinsonismo ad esordio giovanile senza mutazioni del gene Parkina.
Queste differenze sembrano dipendere dalla diversa distribuzione delle lesioni anatomopatologiche riscontrate nei pazienti con mutazione dei geni Parkina. Esistono diversi strumenti per valutare l’olfatto: si possono valutare la soglia olfattiva (cioè l’intensità a cui un determinato odore viene percepito), la discriminazione ed il riconoscimento degli odori per mezzo di “sniffin-stick” contenenti sostanze odorose differenti e comunemente conosciute a diversa concentrazione o, in alternativa, la capacità di riconoscimento degli odori può essere valutata tramite cartoncini “scratch and smell” impregnati di odori diversi (UPSIT).
Disturbi della vista
Disturbi della vista quali offuscamento visivo, ridotta sensibilità al contrasto ed ai colori, diplopia (sdoppiamento), difficoltà alla lettura e faticabilità visiva sono spesso riportati dai pazienti parkinsoniani.
In genere tali disturbi si presentano nelle fasi più avanzate di malattia e sembrano essere legati ad alterazioni della motilità oculare come il rallentamento e la frammentazione dei movimenti oculari, alterazioni della convergenza ed alterazioni della motilità pupillare. Anche la retina, ricca di neuroni dopaminergici, va incontro ad alterazioni legate alla MP contribuendo a tali disturbi.
Non ci sono studi specifici sui disturbi della vista nel Parkinson ad esordio giovanile e negli studi che utilizzano questionari per indagare la presenza di sintomi non motori la diplopia è raramente riportata dai pazienti affetti da MP ad esordio giovanile senza e, ancor più raramente, con mutazioni del gene Parkina.
La presenza di disturbi visivi può in alcuni casi essere legata alle terapia antiparkinsoniane (anticolinergici, levodopa) ed aumenta il rischio di comparsa di allucinazioni visive. In presenza di disturbi visivi è necessaria un’attenta valutazione oculistica ed eventualmente ortottica per individuare i problemi principali.
Spesso alcuni espedienti come l’utilizzo di una lampada a luce fredda per aumentare il contrasto durante la lettura, l’abitudine a distogliere periodicamente lo sguardo dal testo o dal monitor facendo scorrere gli occhi in varie direzioni per stimolare il movimento coordinato dei due occhi, l’utilizzo di lenti da vicino invece delle lenti progressive possono essere sufficienti a migliorare i disturbi visivi tipici della MP.
Dott. Claudia dell’Aquila
UO Neurologia Ospedale Civile “Bonomo” Andria
Dott. Davide Martino
King's College Hospital NHS Foundation Trust
Londra
I disturbi autonomici
Introduzione
Il sistema nervoso autonomo (anche chiamato sistema nervoso vegetativo) rappresenta una parte del sistema nervoso che innerva e influenza gli organi, i vasi sanguigni e le ghiandole.
Le caratteristiche non motorie della malattia di Parkinson (MP) comprendono l’alterazione del sistema nervoso autonomo (anche detta disautonomia).
La disautonomia è stata in passato segnalata nella fase avanzata della MP, ma recenti evidenze suggeriscono che può verificarsi anche nella fase iniziale di MP, indipendente dalla terapia farmacologica. I sintomi di disautonomia, come la stitichezza, talvolta possono anche precedere l'insorgenza dei sintomi motori. La disautonomia può essere la presentazione clinica di altri parkinsonismi, come l’atrofia multi sistemica la cui età media di esordio è tra i 50 e i 70 anni.
Pertanto, individuare una disautonomia può essere utile per diagnosticare la MP nelle fasi precoci di malattia, o per differenziare tra MP e altri parkinsonismi atipici, come l’atrofia multisistemica.
I sintomi di disautonomia sono variabili e comprendono i sintomi cardiovascolari, gastrointestinali, urogenitali, sudomotori e di disfunzione della termoregolazione.
i. I sintomi autonomici
Sintomi cardiovascolari
Sintomi di ipotensione ortostatica
L’ipotensione ortostatica (IO) è definita come una riduzione della pressione arteriosa sistolica di almeno 20 mmHg o della pressione diastolica di almeno 10 mmHg entro 3 minuti dall’assunzione della posizione ortostatica. L’IO è presente nel 47% dei pazienti con MP e l'incidenza aumenta con la progressione della malattia.
I sintomi dell’IO sono causati dalla ridotta perfusione degli organi, in particolare del cervello. L’ipoperfusione cerebrale può provocare vertigini/capogiri, disturbi visivi (come visione offuscata, visione a cannocchiale, disturbi della visione dei colori, ecc ), transitori disturbi cognitivi e transitoria perdita di coscienza (sincope). L’ipoperfusione dei muscoli può causare mal di testa, dolore al collo e mal di schiena. L'ipotensione ortostatica può inoltre causare affaticamento, dolore toracico e dispnea. Solitamente i sintomi si manifestano in occasione del passaggio dalla posizione sdraiata a quella seduta o eretta, e si attenuano assumendo la posizione clinostatica. I sintomi di ipotensione ortostatica possono essere ulteriormente aggravati da altri fattori che causano vasodilatazione, come l'ingestione di cibo, l’esercizio fisico, i farmaci con proprietà ipotensive (tra cui alcuni farmaci del parkinson).
Ipotensione post-prandiale
L'ipotensione post-prandiale si caratterizza per la comparsa di ipotensione dopo l’ingestione di cibo. I carboidrati tendono ad abbassare la pressione arteriosa post-prandiale maggiormente rispetto alle proteine o ai grassi. L’ipotensione post-prandiale aggrava l'ipotensione ortostatica, e può essere più rilevante al mattino e dopo pasti abbondanti.
Ipertensione supina
Nei pazienti con MP e ipotensione ortostatica può associarsi ipertensione supina, ovvero il rialzo dei valori pressori oltre i limiti di norma durante il mantenimento della posizione sdraiata (quindi particolarmente nelle ore notturne). L’ ipertensione supina è di solito asintomatica ma alcuni pazienti riferiscono cefalea mentre sono sdraiati. L’ipertensione supina può contribuire a determinare ipertrofia ventricolare, disfunzione renale e emorragia intracerebrale. I farmaci usati per il trattamento dell’ipotensione ortostatica possono contribuire o peggiorare l’ipertensione supina.
Sintomi gastro-intestinali
I sintomi gastrointestinale sono comuni nella MP. Questi sintomi sono rappresentati da nausea, precoce sazietà, perdita di appetito, distensione addominale e stipsi e si pensa siano dovuti ad una alterazione della motilità gastrointestinale.
Stipsi
La stitichezza è definita in modo variabile: meno di tre evacuazioni di feci alla settimana, uso regolare di lassativi e/o difficoltà durante la defecazione. Nella MP costituisce il sintomo intestinale più frequente e può essere un problema importante. Circa la metà dei pazienti con MP hanno stipsi, può essere un disturbo che precede la comparsa dei sintomi motori, e peggiora nelle fasi avanzate di malattia.
Sintomi urinari
I disturbi urinari sono comuni nella MP. La somministrazione di questionari mirati alla ricerca di sintomi urinari ha mostrato che oltre il 50% dei pazienti presenta questi disturbi. Bisogna però considerare che l’iperplasia prostatica benigna e l’iperattività detrusoriale idiopatica spesso si verificano con l'aumentare dell'età e pertanto vi potrebbe essere una sovrastima di questo problema nella MP. Nella maggior parte dei pazienti con MP, i sintomi urinari si verificano dopo lo sviluppo dei sintomi motori.
I sintomi urinari si suddividono in sintomi di riempimento e sintomi di svuotamento vescicale. I sintomi di riempimento sono i più comuni nella MP e possono essere caratterizzati da aumentata frequenza urinaria diurna, aumentata frequenza urinaria notturna (il sonno è disturbato a causa della necessità di urinare durante il riposo notturno), urgenza e incontinenza urinaria; mentre non sono particolarmente comuni nella MP, soprattutto nelle fasi iniziali, i sintomi di svuotamento quali difficoltà nel mitto, minzione interrotta, flusso di urina scarso o prolungato.
Disturbi della funzione sessuale
I disturbi della funzione sessuale sono più frequentemente riportati nei pazienti con MP rispetto ai soggetti sani di pari età. Studi sulla qualità degli studi vita hanno documentato che la disfunzione sessuale interessa oltre il 60% degli uomini e delle donne con MP. Le persone anziane con MP presentano più frequentemente disturbi della funzione sessuale rispetto ai giovani pazienti.
I disturbi della funzione sessuale nella MP potrebbero essere causati da molteplici fattori, tra cui la malattia stessa oppure disturbi associati come la depressione e l'ansia. Si è visto come via sia una relazione tra disfunzione sessuale e durata e gravità della MP. Chiaramente, l'età e altre patologie concomitanti come diabete, ipertensione e arteriosclerosi giocano un ruolo importante nel causare disfunzione sessuale. Inoltre, alcuni farmaci come antipertensivi e antidepressivi possono avere effetti collaterali negativi sulla funzione sessuale.
I disturbi della funzione sessuale comprendono disfunzione erettile (raggiungere e mantenere l’erezione) e problemi di eiaculazione nei pazienti di sesso maschile, e perdita di lubrificazione e minzione involontaria durante il sesso nelle pazienti di sesso femminile. Uno studio che ha indagato i problemi sessuali in una popolazione di giovani con MP (età compresa tra 36-56 anni), ha mostrato come in questi pazienti siano presenti modificazioni della libido e dell’attività sessuale dopo l'inizio della MP, specie nelle donne. Un limite di questo studio è che non vi era un gruppo di controllo di soggetti sani di pari età. Emerge comunque con chiarezza che bisogna porre attenzione a questi problemi che influenzano molto la qualità di vita dei pazienti.
Disturbi della sudorazione
I disturbi della sudorazione si riscontrano nel 30-55% dei pazienti con MP. Si possono verificare nella MP sia un eccesso di sudorazione (nota anche come iperidrosi) nonché una riduzione anomala della sudorazione (ipoidrosi). L’iperidrosi può causare di bagnare i vestiti. Le persone con ipoidrosi possono avvertire troppo caldo in ambienti in cui invece i soggetti senza MP avvertono una temperatura normale, e devono porre attenzione a non stare a lungo in ambienti troppo caldi.
I pazienti con MP spesso lamentano iperidrosi nella parte superiore del corpo, a livello della testa, viso, collo, braccia e torace. L'iperidrosi spesso si verifica durante le fasi OFF della MP e durante i periodi ON particolarmente quando sono presenti le discinesie. L'ipoidrosi può verificarsi più frequentemente nella parte inferiore del corpo.
I disturbi relativi al sistema nervoso autonomo possono anche causare modificazioni nella temperatura cutanea delle mani e dei piedi, determinando mani e piedi che sono rossi e freddi.
ii. La diagnosi di disautonomia
La disautonomia è indagata attraverso l’esame obiettivo, la raccolta dei sintomi autonomici (sono disponibili vari questionari mirati alla ricerca di questi sintomi) e la somministrazione di test di funzionalità del sistema nervoso autonomo cardiovascolare.
I test di funzionalità del sistema nervoso autonomo cardiovascolare comprendono una batteria di test per lo studio del sistema nervoso autonomo che controlla il cuore e la circolazione sanguigna. Tali test evidenziano la presenza di disautonomia, quantificano la gravità della disautonomia, possono determinare il sito della lesione a carico del sistema nervoso autonomo e l’eventuale evoluzione della disautonomia. I test autonomici cardiovascolari sono utili nella diagnosi di MP e nel differenziare la MP da altri parkinsonismi, come l’atrofia multisistemica.
Anche il monitoraggio continuo della pressione arteriosa delle 24 ore è un’indagine che può dare informazioni preziose circa la presenza di alterazioni compatibili con disautonomia. Infatti, tale indagine permette di rilevare cali pressori diurni anche in rapporto con l’assunzione dei farmaci e con i pasti, e l’assenza del fisiologico calo pressorio notturno con presenza di ipertensione notturna.
E’ inoltre disponibile la scintigrafia miocardica con tracciante MetaIodoBenzilGuanidina (MIBG) che consente di visualizzare l’innervazione adrenergica cardiaca. E’ importante sottolineare come questa indagine è utile solo in presenza di dimostrata disautonomia tramite i test di funzionalità del sistema nervoso autonomo cardiovascolare. In presenza di disautonomia accertata, la scintigrafia miocardica con MIBG può essere utile nella diagnosi differenziale delle differenti forme di parkinsonismo associate a disautonomia.
Vi sono in aggiunta ulteriori indagini atte a indagare la funzione dei vari organi, come per esempio la vescica (es. ecografia vescicale post-minzionale, flussometria, cistometria, urografia, EMG sfintere vescicale) o l’apparato gastrointestinale (es. radioscopia dopo pasto baritato, metodiche manometriche di misurazione della motilità gastroenterica, EMG sfintere anale).
iii. Il trattamento dei sintomi disautonomici
I sintomi di disautonomia possono essere gestiti con misure non farmacologiche e con la farmacoterapia. Vi sono a disposizione numerosi farmaci per il trattamento dei sintomi disautonomici, che potranno essere prescritti dal medico curante qualora indicato. Per alcuni disturbi disautonomici vi è la possibilità di usare con efficacia misure non-farmacologiche, che verranno qui di seguito esposte.
I pazienti con ipotensione ortostatica possono avvalersi di consigli pratici, che comprendono comportamenti da evitare e comportamenti da adottare.
Comportamenti da evitare:
- Alzarsi improvvisamente in piedi soprattutto al risveglio;
- Rimanere fermi a lungo in piedi;
- Rimanere sdraiati a lungo durante il giorno;
- Sforzarsi durante la minzione e la defecazione;
- Alte temperature ambientali (inclusi bagni e docce calde);
- Sforzi fisici intensi;
- Pasti molto abbondanti e ricchi di carboidrati (gli alimenti che contengono carboidrati, come la pasta, il pane e i dolci, sono quelli che accentuano di più il calo pressorio);
- L’alcool è un vasodilatatore e può pertanto peggiorare l’ipotensione ortostatica;
- Farmaci con proprietà vaso depressive.
Comportamenti da adottare:
- Al risveglio è opportuno sedersi sul letto per alcuni minuti, quindi mettere giù le gambe, rimanendo ancora seduti per qualche minuto ed infine alzarsi. Se l’ipotensione è molto marcata al mattino è consigliabile assumere la terapia e fare colazione seduti a letto e attendere 30-60 minuti per alzarsi;
- Si consiglia di fare pasti frazionati e frequenti riducendo la presenza nella dieta di carboidrati o comunque di assumere preferibilmente questo tipo di alimenti la sera;
- Esercitare una costante ma non intensa attività fisica. Il nuoto, in un ambiente controllato, può essere ben tollerato ma occorrono precauzioni soprattutto nel momento in cui si esce dall’acqua;
- Abituarsi a esercitare le manovre fisiche che riducono il calo pressorio in posizione eretta: piegarsi in avanti come per allacciarsi una scarpa, e/o stare su di un piede appoggiando l’altro su di una superficie più alta come una sedia – accovacciarsi piegando le ginocchia – incrociare le gambe “a forbice” – contrarre le muscolatura addominale, delle gambe e dei glutei quando si è in piedi e anche quando si incrociano le gambe – piegare la testa a livello del cuore quando si è in piedi o seduti;
- L’estate è la stagione che richiede maggiori precauzioni. In questo periodo è opportuno mantenere una temperatura più bassa nell’ambiente in cui si trascorre la maggior parte del tempo. Nella scelta del luogo di vacanza è sicuramente consigliabile optare per la montagna. Il condizionamento dell’ambiente diventa ancora più importante in presenza di febbre.
Durante il giorno, il trattamento dell’ipertensione supina può essere realizzato semplicemente evitando la posizione supina. In caso di rilievo o di comparsa di sintomi di ipertensione l’assunzione della posizione eretta o bere un bicchiere d’acqua zuccherata sono manovre sufficienti per ridurre la pressione arteriosa. Per ridurre l'ipertensione supina, la posizione migliore durante il sonno è quella con la testa sollevata rispetto ai piedi. Per questo è necessario inclinare il letto ponendo zoccoli di legno di altezza di circa 15 cm sotto i piedi del letto dalla parte della testa.
Per le persone che hanno problemi di pressione alta in posizione sdraiata può essere utile fare uno spuntino accompagnato da ½ bicchiere di vino prima di addormentarsi.
La frequenza urinaria notturna può essere ridotta limitando l'assunzione di liquidi dopo il pasto serale.
La stitichezza può essere gestita con cambiamenti nella dieta ed esercizio. E’ importante una dieta ricca di fibre e un buon apporto di liquidi. Può anche essere utile l'attività fisica.
Dott. Francesca Del Sorbo
U.O. Disturbi del Movimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano
Disturbi comportamentali
↑ Torna
In aggiunta ad disturbi psichiatrici già menzionati, i pazienti con malattia di Parkinson possono sviluppare alterazioni comportamentali di varia natura.
Esse possono essere in parte “reattive” alla malattia (ad esempio quando si preferisce restare a casa per l’imbarazzo sociale causato dal tremore) o secondarie a problematiche psichiatrico-cognitive (come nel caso dei sintomi apatici). Tuttavia, quando si parla di disturbi comportamentali si fa riferimento soprattutto a due condizioni: i disturbi da controllo degli impulsi (DCI) e il punding.
I DCI sono disturbi psichiatrici presenti nella popolazione generale e generalmente caratterizzati da un’incapacità di chi ne è affetto a liberarsi da azioni compulsive. In altre parole, si tratta di una sudditanza a comportamenti ludici in origine ma che assumono carattere patologico perché comportano spreco di tempo, risorse e soprattutto denaro. I DCI più frequenti e noti sono il gioco d’azzardo patologico (gratta e vinci, slot machine, etc…), lo shopping compulsivo, l’iperfagia o binge eating (attacchi di fame compulsiva, spesso notturna) e l’ipersessualità (eccessivo appetito sessuale).
È ormai chiaro che questi disturbi sono alquanto frequenti nei pazienti con MP (con una prevalenza del 4-6%) e che sono dovuti all’azione combinata di fattori predisponenti e scatenanti. I fattori predisponenti sono principalmente la giovane età, l’abitudine ad avere altre dipendenze (ad es. il fumo), la familiarità per questi disturbi e il vivere da soli; se è vero che i DCI sono generalmente più frequenti nei maschi, il sesso ha un ruolo nel determinarne il tipo: gli uomini presenteranno più frequentemente gioco d’azzardo e ipersessualità, le donne shopping compulsivo e iperfagia.
I fattori scatenanti più importanti sono i farmaci anti-parkinson, in particolare i dopamino-agonisti. Infatti, se è vero che la levodopa è stata associata allo sviluppo di ipersessualità, negli ultimi anni l’introduzione di dopamino agonisti più potenti del passato (sia i più “vecchi” pergolide e cabergolina, sia i più “nuovi” pramipexolo, ropinirolo e rotigotina) ha slatentizzato questi fenomeni.
I dopamino-agonisti hanno indubbiamente permesso di migliorare i disturbi motori e non-motori (in particolare depressione e apatia) dei pazienti, ma hanno radicalmente capovolto il cliché del paziente parkinsoniano come persona introversa e poco avvezza ai vizi. È importante sottolineare che il paziente si rende conto di essere vittima del suo comportamento compulsivo (e per questo ne soffre doppiamente) ma nonostante gli sforzi non riesce a smettere.
Tuttavia, nei casi più gravi una parte della consapevolezza viene persa, il soggetto tende a minimizzare l’impatto del vizio o addirittura a nasconderlo o negarlo. Per questi motivi è importante informare bene i pazienti sui rischi associati all’uso dei farmaci, invitandoli a riportare al medico eventuali cambiamenti del carattere. Fondamentale è anche il coinvolgimento delle persone vicine al malato al fine di monitorare ma anche di gestire le situazioni più gravi (ad es. affidando lo stipendio alla persona cara o esercitando un controllo condiviso sui conti bancari).
Il punding indica una caratteristica voglia di ripetere in maniera continuativa la stessa azione, la quale spesso assume le sembianze di un hobby. Esempi sono passare la giornata a catalogare documenti, collezionare oggetti, aggiustare arnesi in casa o dedicarsi al giardinaggio. Il carattere patologico è dovuto al fatto che queste attività sono assolutamente non necessarie o afinalistiche; inoltre, il soggetto è preda di queste azioni e non riesce a staccarsene, nemmeno per mangiare o prendere le medicine.
Il punding condivide molti fattori predisponenti con i DCI, anche se spesso chi ne è affetto ha una maggiore compromissione cognitiva. Anche il punding è scatenato dai farmaci, ma probabilmente è maggiormente imputabile all’uso della levodopa o dell’apomorfina, altro dopamino-agonista assunto per via parenterale con iniezioni o infusioni sottocutanee.
In conclusione, informare pazienti e familiari è la migliore strategia per prevenire lo sviluppo di questi disturbi comportamentali. Infatti, una volta sviluppati essi non recedono se non modificando/riducendo la terapia anti-parkinsoniana, magari a discapito di un buon controllo motorio. Non esistono al momento farmaci specifici. Qualche timido risultato si è ottenuto con l’amantadina, soprattutto nella gestione del punding.
Dott. Alfonso Fasano
Università di Toronto
Movement Disorders Centre
Toronto Western Hospital, Toronto, Canada
Disturbi cognitivi
↑ Torna
Caratteristiche, frequenza ed evoluzione
Sebbene la malattia di Parkinson (MP) sia dominata principalmente da disturbi del movimento, con l’evolversi della malattia alcuni pazienti cominciano ad accusare disturbi della sfera cognitiva.
Uno dei disturbi che possono manifestarsi più precocemente è la difficoltà a reperire “la parola giusta al momento giusto” durante il discorso o la conversazione. Altri disturbi relativamente frequenti riguardano l’attenzione, la concentrazione e la difficoltà ad apprendere nuovi dati e informazioni. La memoria risulta essere invece preservata o viene coinvolta in misura minore nella MP (contrariamente a quanto si verifica nella malattia di Alzheimer, dove invece vi è una perdita precoce della memoria).
In alcuni casi, con l’evolversi della malattia i disturbi cognitivi, inizialmente benigni, possono diventare più insidiosi, sino ad interferire con il normale svolgimento delle attività lavorative e del tempo libero. L’insorgenza di una vera e propria demenza nella MP è relativamente rara, e si verifica generalmente dopo molti anni dall’esordio di malattia. Un recente studio epidemiologico australiano, ha dimostrato che la possibilità di sviluppare demenza è molto bassa nei primi 10 anni di malattia, mentre diventa molto alta (circa 90%) dopo 20 anni dall’esordio della malattia.
In realtà bisogna considerare che, parallelamente all’evoluzione della malattia, anche l’invecchiamento contribuisce all’insorgenza di demenza. In particolare si è osservato che per i pazienti con MP il rischio di sviluppare demenza aumenta drammaticamente dopo i 70 anni. Questa osservazione non ci sorprende, se consideriamo che anche nella popolazione generale, non affetta da MP, si registra un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive legate all’invecchiamento. Uno studio americano anni ha dimostrato che, tra le persone di età superiore a 71 anni, circa 14 su 100 presentano demenza. Nella MP , la combinazione dei due fattori , evoluzione della malattia da una parte e invecchiamento dall’altra, contribuisce ad aumentare il rischio di demenza. Per esempio, se la MP insorge a 60 anni, dopo 20 anni di malattia, il paziente avrà 80 anni, ed è altamente probabile che sviluppi una demenza. Occorre però precisare che non esistono studi specifici che abbiano esaminato il rischio di demenza in pazienti con esordio precoce di malattia, nei quali il tempo di evoluzione della malattia non si associa all’età avanzata.
Ovviamente tutte queste considerazioni si riferiscono alla MP , cosidetta “idiopatica”, ovverosia la forma tipica di malattia. In altre malattie, chiamate parkinsonismi atipici, l’insorgenza di disturbi cognitivi o demenza può verificarsi precocemente, dopo pochi anni di malattia, o può addirittura precedere l’inizio dei disturbi motori. I parkinsonismi atipici presentano delle caratteristiche diverse dalla MP, anche per quanto riguarda le caratteristiche e l’evoluzione dei disturbi motori, la risposta alle terapie farmacologiche o possono presentare dei disturbi caratteristici , che permettono di formulare una diagnosi corretta. Lo specialista ha il compito di esaminare tutti gli elementi a disposizione per formulare una diagnosi corretta e per elaborare una previsione di massima sull’evoluzione della malattia e sulla possibilità di insorgenza di disturbi cognitivi.
Le cause
E’ noto che la MP è una malattia neurodegenerativa. I fenomeni di degenerazione e perdita di neuroni riguarda principalmente le aree del cervello deputate al controllo del movimento. Tuttavia, con l’evolversi della malattia, il processo degenerativo coinvolge anche aree cerebrali che regolano i processi cognitivi. Il malfunzionamento di tali strutture si riflette nel calo delle prestazioni cognitive.
Altri fattori possono contribuire ad alterare le capacità cognitive. Per esempio l’assenza di esercizio fisico e l’isolamento sociale dovute alla ridotta mobilità, determinano una sorta di inattività fisica e mentale, con ripercussioni negative sulla salute globale e sulle funzioni del cervello.
Inoltre , con l’invecchiamento , possono sopraggiungere altre malattie come l’aterosclerosi vascolare, o la stessa malattia di Alzheimer, che si sovrappongono alla MP, complicando il quadro cognitivo.
La valutazione
La valutazione della presenza e dell’entità dei disturbi cognitivi parte sempre dal colloquio con il paziente. Il medico deve ascoltare attentamente e registrare le difficoltà cognitive riferite dal paziente. E’ molto importante cercare di capire quanto tali difficoltà disturbino il paziente nella vita lavorativa e sociale e nell’organizzazione delle attività più avanzate della vita quotidiana ( p.es. gestire il denaro, fare acquisti, utilizzare il telefono, organizzare le faccende domestiche, guidare l’auto o prendere i mezzi pubblici) o, nei casi più gravi nelle attività più elementari (p.es. provvedere all’igiene e alla cura della persona o all’alimentazione).
Al fine di valutare la gravità dei disturbi e di tenere sotto controllo la loro eventuale evoluzione si possono eseguire dei test specifici, chiamati test neuropsicologici, che consistono in prove di memoria, attenzione, ragionamento, disegno.
Inoltre è molto importante escludere la presenza di altri sintomi, che frequentemente possono associarsi ai disturbi cognitivi nei pazienti con MP, per esempio la depressione o la sonnolenza durante il giorno.
br /> In alcuni pazienti la presenza dei disturbi cognitivi può predisporre a sviluppare disturbi psichiatrici , come le allucinazioni (visioni di oggetti, animali o persone) e il delirio (idee o convincimenti senza fondamento nella realtà, per esempio gelosia immotivata nei confronti del coniuge o timore di essere perseguitati o minacciati) o disturbi del comportamento (ritiro sociale o aggressività).
La valutazione e il trattamento dei disturbi psichiatrici è fondamentale, in quanto essi incidono in maniera significativa sulla vita e la serenità del paziente e della sua famiglia.
Il trattamento
In presenza di disturbi cognitivi lievi normalmente non si utilizza alcun trattamento specifico. In questi casi è molto importante spiegare al paziente che i disturbi fanno parte della MP e che molto probabilmente progrediranno in maniera lenta e benigna per molti anni, fino all’età avanzata.
Nel caso in cui insorga una vera e propria demenza possono essere utilizzati farmaci specifici, come il donepezil, la rivastigmina e la memantina. Questi farmaci inizialmente sono stati sviluppati per il trattamento della malattia di Alzheimer, ma si sono rivelati utili anche nel trattamento della demenza associata a MP. In particolare questi farmaci possono apportare qualche piccolo miglioramento di funzioni specifiche, come la memoria e l’attenzione, ma possono anche attenuare i disturbi psichiatrici (allucinazioni, deliri e disturbi del comportamento) che possono associarsi ai disturbi cognitivi.
Poiché tutti i trattamenti possono avere effetti secondari (per esempio a livello cardiologico) la loro prescrizione deve essere preceduta da un’attenta valutazione dei possibili benefici e dei possibili rischi.
La prima regola comunque, nel trattamento dei pazienti con disturbi cognitivi gravi è quella di semplificare al massimo la terapia, e di evitare l’uso di farmaci che potrebbero complicare gli aspetti neuropsichiatrici.
La prevenzione
Diversi studi hanno messo in evidenza che le persone con un elevato livello di istruzione , ma anche un’attività mentale intensa (lavoro di responsabilità, abitudine alla lettura e al lavoro concettuale) hanno un minor rischio di sviluppare demenza.
Inoltre , il mantenimento di un’attività fisica regolare, previene l’insorgenza di demenza, non solo attraverso la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma probabilmente anche grazie ad un’azione neuroprotettiva.
D’altro canto, la vita sedentaria, l’obesità, l’iperglicemia sono associate ad una maggiore frequenza di demenza.
Anche se questi studi sono stati condotti nella popolazione generale , è logico pensare che questi concetti possano essere validi anche nei pazienti con malattia di Parkinson. Quindi ragazzi, attiviamo le gambe e teniamo acceso il cervello!!!
Dott. Manuela Pilleri
U.O. Parkinson
IRCCS San Camillo
venezia
Disturbi del sonno
↑ Torna
I disturbi del sonno, descritti già da James Parkinson nella sua famosa monografia “An Essay on the Shaking Palsy”, sono tra i sintomi non-motori più frequenti nella malattia di Parkinson (MP) ed interessano fino al 90% dei pazienti secondo alcuni studi. Oggi si sa che questi sintomi costituiscono un fattore importante nel determinare la qualità della vita sia del paziente sia dei suoi famigliari. Le varie alterazioni del sonno possono precedere la diagnosi di MP oppure presentarsi durante il decorso della malattia, sia come espressione della malattia stessa sia come conseguenza della terapia antiparkinsoniana. I disturbi legati al sonno si possono schematicamente classificare in tre differenti categorie:
1. Disturbi specifici che si manifestano durante il sonno notturno (le cosiddette parasonnie)
2. Riduzione del sonno notturno (insonnia)
3. Sonnolenza diurna
Alcuni pazienti presentano alterazioni specifiche del sonno con manifestazioni che possono sembrare curiose come il disturbo comportamentale in sonno REM (la fase REM – Rapid Eye Movement – del sonno è quella in cui si sogna ed è caratterizzata fisiologicamente da movimenti rapidi degli occhi, assenza di tono muscolare e attività elettroencefalografica simile alla veglia). Le persone affette da questo disturbo parlano e gesticolano durante il sonno, mettendo in atto il contenuto dei sogni. Spesso i sogni presentano elementi di aggressività e violenza. Talora può capitare che la persona si faccia male cadendo dal letto, oppure colpisca involontariamente il coniuge durante il sonno. A volte la terapia dopaminergica può rendere più evidenti tali manifestazioni. Questo fenomeno può precedere anche di anni l’insorgenza della MP. Nel caso in cui le manifestazioni notturne siano frequenti, è consigliabile una terapia specifica. Il farmaco di prima scelta è il clonazepam assunto alla sera prima di coricarsi.
La sindrome delle gambe senza riposo (Restless legs syndrome - RLS) è un altro disturbo specifico del sonno frequente nelle persone affette da MP. La RLS consiste in una sensazione fastidiosa agli arti inferiori accompagnata da un’irresistibile necessità di muovere le gambe che compare in condizioni di riposo e si accentua di sera o nella notte. La terapia della RLS associata a MP è la stessa della RLS che si manifesta indipendentemente dalla MP e comprende misure generali quali il mantenere orari di sonno regolari, un moderato esercizio fisico, massaggi alle gambe, l’utilizzo di coperte termiche oppure di cuscini refrigeranti. I farmaci che possono essere utili sono dopaminoagonisti o levodopa serale, benzodiazepine, gabapentin, preganbalin ed oppioidi.
Altri fenomeni notturni responsabili della frammentazione del sonno nelle persone affette da MP sono i disturbi respiratori quali il russamento e la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, ma anche le allucinazioni, che sono soprattutto visive e possono associarsi a uno stato confusionale notturno; infine vanno ricordati i disturbi vescicali che si manifestano nelle ore notturne (nicturia) e che possono essere causa di frequenti risvegli durante la notte, soprattutto nelle persone più anziane.
L’insonnia può manifestarsi con difficoltà ad addormentarsi (insonnia iniziale), oppure con difficoltà a mantenere il sonno (insonnia di mantenimento) oppure ancora con risvegli precoci. In quest’ultimo caso è molto probabile che vi sia una concomitante depressione del tono dell’umore. La comparsa dei sintomi parkinsoniani durante le ore notturne può portare il paziente ad essere bloccato nel letto (acinesia notturna), impedendogli di trovare una posizione comoda per riposare mentre la rigidità è causa di dolori diffusi alla schiena e agli arti. Le distonie con crampi dolorosi alle gambe sono frequenti nelle prime ore del mattino. Anche il tremore e le discinesie, quando compaiono nelle ore notturne, possono contribuire a disturbare il sonno.
La sonnolenza diurna eccessiva, di comune riscontro nei pazienti con MP, può essere la conseguenza di un sonno notturno disturbato, tuttavia, può dipendere anche dagli effetti collaterali della terapia farmacologica, in particolare da farmaci dopaminoagonisti (pramipexolo, ropinirolo) e levodopa che possono essere causa di sonnolenza e a volte di attacchi di sonno improvvisi. Vari studi hanno poi dimostrato che le modificazioni della vigilanza nell’arco della giornata sono parte integrante della malattia stessa indipendentemente dalla terapia farmacologica e dai disturbi del sonno associati. Sono disponibili solo pochi farmaci che potenzialmente riducono la sonnolenza diurna. Il modafinil è stato testato come potenziale terapia, con risultati poco conclusivi e pertanto non è raccomandabile. Attualmente, l’unica raccomandazione possibile è la riduzione della terapia dopaminergica e possibilmente la sostituzioni con farmaci differenti per quanto possibile.
I pazienti affetti da MP hanno quindi spesso problemi notturni per vari motivi differenti. Il problema più frequente è il mantenimento della continuità del sonno, la cosiddetta frammentazione del sonno. I frequenti risvegli possono essere causati dalla ricomparsa del tremore nelle fasi di alleggerimento del sonno, dalla difficoltà a girarsi nel letto a causa dell’acinesia notturna - conseguente al venir meno dell’effetto della terapia dopaminergica assunta nelle ore diurne - e dalla nicturia. Inoltre, la sindrome delle gambe senza riposo, le apnee nel sonno, il disturbo comportamentale in sonno REM ed eventualmente le allucinazioni notturne, sono tutti fattori che contribuiscono ad alterare profondamente il sonno notturno delle persone affette da MP. A volte, la stessa terapia farmacologica può interferire negativamente sul sonno notturno. In conseguenza di tutto ciò, il paziente e sovente anche il coniuge, si trovano ad affrontare notti disturbate, con un conseguente peggioramento dei sintomi parkinsoniani nella giornata successiva. Una notte di sonno di buona qualità, per contro, è in grado di migliorare i sintomi parkinsoniani la mattina successiva (il cosiddetto “sleep benefit”). Alcuni pazienti, in cui questo fenomeno è particolarmente marcato, constatano che anche brevi sonnellini nella giornata possono “ricaricare le batterie”. Generalmente si tratta di pazienti con MP ad esordio giovanile e mutazione del gene della parkina.
Per quanto riguarda il trattamento dei disturbi del sonno è importante un’attenzione alla cosiddetta igiene del sonno che consiste nell’evitare alcolici, caffeina e nicotina ed un’eccessiva assunzione di liquidi alla sera. Può essere necessario un trattamento farmacologico della depressione che sovente si associa ai disturbi del sonno. Antidepressivi con proprietà sedative quali amitriptilina, mirtazapina e trazodone possono essere molto utili, non solo per indurre e mantenere il sonno, ma anche per ridurre la frequenza urinaria notturna. Una dose di levodopa serale a rilascio prolungato può alleviare l’acinesia notturna, e tuttavia talora può causare un eccesso di attività onirica ed una frammentazione del sonno in alcuni pazienti. Le benzodiazepine, e in particolare il clonazepam, è utile per il disturbo comportamentale in sonno REM. Basse dosi di clozapina o quetiapina assunte alla sera possono essere molto efficaci per migliorare il sonno. L’impiego di zolpidem, un farmaco ipnoinducente a breve emivita, assunto in occasione del risveglio notturno può essere utile per i soggetti che non hanno problemi a prendere sonno ma che si risvegliano precocemente dopo 2-3 ore. Infine, un miglioramento considerevolmente della qualità del sonno si riscontra nei pazienti sottoposti alla stimolazione cerebrale profonda che, garantendo una stimolazione dopaminergica costante nelle 24 ore, consente una migliore mobilità durante il sonno ed un migliore controllo di tremore, rigidità e sintomi distonici nel corso della notte.
Dott. Maurizio Zibetti
Dipartimento di Neuroscienze
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino
Torino
Ansia e depressione
↑ Torna
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia caratterizzata dai sintomi motori (bradicinesia, rigidità, instabilità posturale e tremore a riposo), quindi è considerata un disturbo del movimento, ma molti sintomi non motori la rendono una malattia più complessa.
Le manifestazioni mentali della MP, in particolare ansia e depressione, sono i principali sintomi non motori che caratterizzano la malattia e contribuiscono alla disabilità.
L’ansia è uno stato emotivo a contenuto spiacevole, associato ad una condizione di allarme e di paura che insorge in assenza di un pericolo reale o che, comunque, è sproporzionata rispetto ad eventuali stimoli scatenanti.
La depressione è caratterizzata da sintomi quali la tristezza, il senso di colpa, la disperazione, l’indifferenza, il vuoto interno, l’apatia e l’indecisione.
Un recente studio americano, sponsorizzato dal National Parkinson Foundation, ha intervistato 5.557 pazienti con MP in tutto il mondo e ha scoperto che il 61% di questi pazienti era depresso. Ansia e depressione possono manifestarsi durante fasi differenti della MP:
1. prima dell’esordio della sintomatologia motoria, predatando la diagnosi di MP e caratterizzandosi come sintomi della fase pre- motoria.
Quindi l’ansia e la depressione non sono solo e semplicemente, come si credeva, sintomi di uno stato d’animo reattivo alla diagnosi di una malattia neurologica cronica, ma sono causate dai cambiamenti chimici (neurotrasmettitoriali) all’interno del cervello dovuti alla MP.
2. al momento della diagnosi prima di iniziare una terapia farmacologica per la MP: in questo la depressione potrebbe essere “reattiva” alla malattia. In questa fase è stato osservato che i sintomi depressivi si associano a una certa difficoltà nelle comuni attività della vita quotidiana e a una maggiore probabilità di iniziare prima la terapia antiparkinsoniana.
3. durante la fase sintomatica della malattia l’ansia e la depressione possono fluttuare come i sintomi motori presentandosi solo nella fase di OFF motorio.
Dunque la depressione e l’ ansia sono dei veri sintomi della malattia, non tratti del carattere, e come tali devono essere “indagati” dal medico (attraverso il colloquio col paziente e la somministrazione di scale ad hoc) e riferiti dal paziente e dai familiari: questo è un punto fondamentale perché tali sintomi possono beneficiare di un trattamento farmacologico e psicologico.
Dott. Daniela Calandrella
U.O. Disturbi del Movimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta
Milano
Introduzione
La malattia di Parkinson (MP) è la patologia neurodegenerativa più frequente dopo la malattia di Alzheimer. Colpisce infatti circa l’1% della popolazione con più di 60 anni e raggiunge il 4% tra i soggetti oltre gli 85 anni di età. Nonostante la prevalenza aumenti progressivamente con l’età, non sono rari i casi in cui la malattia si manifesta prima dei 45-50 anni (EOPD, Early Onset Parkinson’s Disease), che rappresentano circa il 3-4% dei pazienti con MP. Un esiguo numero tra questi presenta un esordio prima dei 21 anni: si tratta di forme di parkinsonismo definito giovanile, dove spesso i segni clinici della MP rappresentano solo parte di un quadro neurologico più complesso ed invalidante.
Sebbene inizialmente si riteneva che la MP fosse causata da fattori ambientali (tossici, infettivi, ecc…), l’osservazione di una storia familiare positiva nel 10-20% dei pazienti suggerisce da tempo il coinvolgimento di fattori genetici nella patogenesi della malattia. Oggi la MP è considerata prevalentemente una patologia multifattoriale, cioè dovuta all’interazione tra molteplici fattori di rischio genetici ed ambientali. Il contributo di tali fattori varia da paziente a paziente, delineando un ampio spettro alle cui estremità troviamo da una parte i parkinsonismi puramente genetici (o monogenici) e dall’altra le forme cosiddette idiopatiche, in cui il contributo dei singoli fattori genetici ed ambientali è molto ridotto e difficile da identificare.
Negli ultimi 15 anni, la ricerca genetica sulle forme di MP familiare ha condotto ad importanti scoperte che hanno rivoluzionato le attuali conoscenze in questo campo. Ben 19 loci genici e 15 geni distinti sono stati correlati a forme monogeniche di MP, in cui mutazioni in un singolo gene sono sufficienti a causare la patologia. Queste forme, trasmesse con modalità autosomica dominante (AD) o autosomica recessiva (AR), sono complessivamente responsabili di circa il 10% dei casi di MP. Più recentemente, sono stati scoperti importanti fattori di rischio genetici per la MP, cioè varianti genetiche non sufficienti a causare la malattia ma che, se presenti, aumentano notevolmente il rischio di ammalare (anche fino a 5-6 volte tanto rispetto ai non portatori). Tali fattori di rischio genetici comprendono varianti polimorfiche in numerosi geni e mutazioni in eterozigosi in geni solitamente non causativi di MP, come il gene della beta-glucocerebrosidasi (GBA), responsabile della malattia di Gaucher, una malattia metabolica da accumulo a trasmissione autosomica recessiva.
In generale, si può assumere che più precoce è l’età d’esordio della MP, più elevata è la probabilità che si tratti di una forma monogenica o comunque con una forte base genetica.
MP a trasmissione autosomica recessiva
Nelle malattie a trasmissione autosomica recessiva è necessario che entrambe le copie dello stesso gene (alleli) siano mutate affinché la patologia si manifesti. Una ereditarietà recessiva è da sospettare in tutte quelle famiglie, spesso consanguinee, dove più individui di una stessa generazione, ma non i loro genitori né i loro figli, sono affetti dalla stessa patologia.
Ad oggi sono stati identificati 8 geni causativi di parkinsonismi AR, ma solo 3 di questi (PARK2/Parkin , PARK6/PINK1 e PARK7/DJ-1) causano forme pure di MP.
Gli altri geni (PARK9/ATP13A2, PARK14/PLA2G6, PARK15/FBXO7, DNAJC6 e SYNJ1) sono responsabili di forme atipiche di parkinsonismo giovanile, caratterizzate da una progressione rapida e da un complesso quadro clinico in cui i segni parkinsoniani sono variabilmente associati ad altre alterazioni neurologiche.
Parkinsonismo “puro” ad esordio precoce
Mutazioni bialleliche, omozigoti o eterozigoti composte, nel gene Parkin sono le più comuni alterazioni genetiche identificate nelle forme pure di MP esordio precoce (fino all’8-9% dei casi di MP con età d’esordio < 40-45 anni). Mutazioni nei geni PINK1 e DJ- 1 sono invece più rare e rappresentano rispettivamente il 3-4 % e < 1 % dei casi di EOPD, con una frequenza variabile in popolazioni distinte.
La proteina codificata dal gene Parkin è una E3 ligasi che partecipa alla regolazione della degradazione proteasomica di substrati proteici, grazie alla sua capacità di trasferire a questi ultimi molecole di ubiquitina attivata. Il gene PINK1 codifica per una chinasi mitocondriale ad attività neuroprotettiva ed antiapoptotica. Recentemente è stato dimostrato che le proteine Parkin e PINK1 interagiscono in uno stesso pathway deputato a selezionare ed eliminare definitivamente dalla cellula i mitocondri danneggiati, processo noto oggi come mitofagia. Il gene DJ-1 invece codifica per una proteina coinvolta nella protezione della cellula neuronale dallo stress ossidativo.
PARK2/ Parkin (locus 6q25.2–q27)
Il gene Parkin è stato identificato nel 1998 in alcune famiglie di origine Turca e Giapponese che avevano un fenotipo comune definito “parkinsonismo ad esordio precoce con fluttuazioni diurne”. A distanza di 15 anni dalla prima descrizione, sono state identificate più di 170 differenti mutazioni , tra cui delezioni o moltiplicazioni di uno o più esoni del gene, piccole delezioni/inserzioni e sostituzioni nucleotidiche. La frequenza delle mutazioni si riduce significativamente con l'aumentare dell'età di insorgenza della sintomatologia, raggiungendo il 77% nei casi con esordio prima dei 20 anni e diventando estremamente rara nei pazienti con esordio dopo 45 anni (2-7%). Altre caratteristiche cliniche tipiche di questa forma di parkinsonismo sono la precoce comparsa di distonia (soprattutto del piede), la lenta progressione della malattia, le fluttuazioni diurne, l’effetto benefico del sonno sulla sintomatologia e l’ottima risposta alla terapia con Levodopa o dopaminoagonisti, spesso però compromessa dall’insorgenza di effetti collaterali quali discinesie ed effetti di fine dose (“wearing off”). Occasionalmente possono essere presenti anche altri segni neurologici quali iperreflessia, o disturbi comportamentali (soprattutto ansia) ma non demenza o alterazioni autonomiche.
PARK6/ PINK1(Chinasi 1 indotta da PTEN, locus 1p36)
Mutazioni bialleliche del gene PINK1, identificate per la prima volta nel 2004 in tre famiglie consanguinee di origine italiana e spagnola, sono la seconda causa più frequente di parkinsonismo AR ad esordio precoce, con una prevalenza che varia nelle diverse etnie (dall’1 al 9% dei casi). Si tratta solitamente di mutazioni puntiformi o piccole inserzioni/delezioni, mentre riarrangiamenti esonici ed estese delezioni, anche dell’intero gene, si riscontrano meno frequentemente. La MP associata a mutazioni del gene PINK1 è sostanzialmente indistinguibile dal fenotipo Parkin-correlato, con l’eccezione di una età d’esordio mediamente più tardiva (solitamente compresa fra i 30 e i 50 anni), minor frequenza di fluttuazioni diurne e di beneficio da sonno, e frequente presenza di disturbi psichiatrici quali depressione, ansia e psicosi.
PARK7/ DJ-1(Daisuke-Junko-1, locus 1p36)
Tra le cause di parkinsonismo puro AR ad esordio precoce, le alterazioni del gene PARK7/DJ-1 sono di gran lunga le più rare. Mutazioni puntiformi e delezioni esoniche sono state descritte solo in pochi casi che presentavano una forma di parkinsonismo molto simile alle altre forme AR, fatta eccezione per una età d’esordio più precoce (solitamente intorno ai 20 anni), e per la presenza di caratteristiche fenotipiche atipiche quali blefarospasmo, distonia cervicale e disturbi psichiatrici.
MP a trasmissione autosomica dominante
Nelle malattie a trasmissione autosomica dominante (AD) è sufficiente che una sola copia del gene sia mutata perché la patologia si manifesti. Pertanto, una ereditarietà AD è da sospettare in tutte quelle famiglie dove almeno un individuo in più generazioni consecutive sia affetto dalla stessa patologia. La presenza di portatori asintomatici della mutazione (dovuto ad un fenomeno ancora non ben chiaro definito “penetranza incompleta”) può, in alcune occasioni, ostacolare il riconoscimento di questo tipo di trasmissione.
Almeno 8 geni e loci sono stati associati a forme AD di MP ma solo pochi tra questi (PARK1-PARK4/SNCA, PARK8/LRRK2, PARK17/VPS35 e PARK18/EIF4G1) sono considerati causativi di forme monogeniche di parkinsonismo. Mentre i geni SNCA e LRRK2, e il parkinsonismo ad essi associato, sono ben caratterizzati, i dati disponibili per i geni VPS35 e EIF4G1, descritti per la prima volta solo pochi anni fa, sono ancora scarsi. Il ruolo patogenetico di altri geni (come PARK5/UCHL1, PARK11/GIGYF2 e PARK13/HTRA2) rimane invece ancora non confermato. Nelle forme dominanti l’età d’esordio è variabile, solitamente più tardiva rispetto alle forme recessive ma più precoce rispetto alle forme idiopatiche di MP.
Il gene SNCA codifica per l’alfa-sinucleina, una proteina di 140 aminoacidi con una spiccata propensione ad aggregare e formare fibrille insolubili, con effetti tossici diffusi per i neuroni dopaminergici. L’alfa-sinucleina rappresenta infatti la componente proteica maggiormente rappresentata nei corpi di Lewy, gli aggregati citoplasmatici tipici della MP, che si riscontrano nei neuroni dopaminergici superstiti. L’accumulo di alfa-sinucleina aumenta drasticamente in presenza di mutazioni puntiformi o in caso di moltiplicazioni dell’intero gene SNCA. Il gene LRRK2 codifica invece per una proteina citoplasmatica con diversi domini e numerose funzioni (tra cui attività chinasica). Alcune mutazioni di LRRK2 sembrano aumentare in maniera patologica l’attività chinasica della proteina, ma ad oggi non è ancora ben chiaro il meccanismo patogenetico per cui la proteina mutata causi neurodegenerazione. Infine, i prodotti dei geni VPS35 e EIF4G1 sono rispettivamente una subunità del complesso retromerico, che regola il traffico intracellulare di vescicole sinaptiche e il riciclaggio di proteine, e un fattore di trascrizione coinvolto nei processi di traduzione delle molecole di RNA messaggero. Anche in questi casi il meccanismo patogenetico di danno neuronale non è ancora stato ben caratterizzato.
PARK1-PARK4/SNCA (alfa-sinucleina, locus 4q21-q23)
Mutazioni puntiformi e moltiplicazioni del gene SNCA rappresentano una causa abbastanza rara di MP a trasmissione dominante. Le duplicazioni rappresentano circa l’1-2% dei casi familiari di MP compatibili con una trasmissione AD, ma sono state occasionalmente descritte anche in casi sporadici. Invece, le triplicazioni dell’intero gene e le mutazioni puntiformi sono estremamente rare, ed identificate per lo più in isolati casi familiari.
Sinora sono state identificate cinque mutazioni puntiformi nel gene SNCA (p.A53T, p.A30P, p.E46K, p.H50Q e p.G51D). Tali mutazioni sono associate ad un parkinsonismo ad elevata penetranza (fino all’85% per la mutazione p.A53T), con esordio prima dei 50 anni ed iniziale buona risposta alla terapia farmacologica. In molti casi tuttavia si assiste ad una rapida progressione della sintomatologia motoria ed alla comparsa di segni non motori quali compromissione cognitiva, alterazioni autonomiche, disturbi psichiatrici e segni atipici come ipoventilazione e mioclono. Le moltiplicazioni dell’intero gene invece sembrano causare un fenotipo strettamente correlato al numero di copie del gene SNCA. Infatti, le triplicazioni sono associate costantemente ad una forma di MP altamente penetrante, rapidamente progressiva e ad esordio precoce (entro la quarta decade), accompagnata da gravi disturbi della sfera cognitiva, psichiatrica e disautonomica. Le duplicazioni invece sono associate ad una più ampia variabilità clinica che va da soggetti sani non penetranti (la penetranza calcolata è del 33% circa) a forme simili ad una MP idiopatica ad esordio tardivo, a quadri più gravi con coinvolgimento non motorio e progressione rapida, che ricordano quelli causate dalle triplicazioni del gene.
PARK8/LRRK2 (kinasi 2 ricca di ripetizioni di leucina, locus 12q12)
Le mutazioni del gene LRRK2 sono la causa più comune di MP a trasmissione AD, descritta sia in casi familiari che sporadici, con una frequenza che varia dal 2% al 40% nelle diverse popolazioni. Nella maggior parte dei casi mutazioni in questo gene sono responsabili di MP molto simile alla forma idiopatica, caratterizzata spesso da tremore unilaterale (frequentemente il primo tra i segni clinici a comparire), buona risposta alla terapia farmacologica e, in alcuni casi, compromissione cognitiva. L’esordio è estremamente variabile, dalla quarta all’ottava decade di vita, sebbene la penetranza aumenta con l’età per cui è più frequente osservare soggetti con esordio in età tardiva.
LRRK2 è un gene molto grande (51 esoni) e fino ad oggi sono state descritte più di 100 varianti nucleotidiche ( http://www.molgen.ua.ac.be/PDmutDB ). Tuttavia solo sette sono state definite sicuramente patogenetiche (p.N1437H, p.R1441C, p.R1441G, p.R1441H, p.Y1699C, p.G2019S e p.I2020T).
Tra queste, la più comune è la mutazione p.G2019S: la sua frequenza sembra diminuire proporzionalmente con l'aumentare della distanza dalle aree del Mediterraneo, verosimilmente per un effetto fondatore: la mutazione è infatti molto frequente nella popolazione Ebrea Ashkenazita e Araba nord-Africana (fino al 40%), mentre la frequenza si riduce nelle popolazioni caucasiche (5-8 % dei casi familiari e 0,5-2% dei casi sporadici) ed è estremamente rara in Asia. La mutazione p.R1441G invece è particolarmente frequente nella regione basca della Spagna, anche qui per un effetto fondatore.
PARK17/VPS35 e PARK18/EIF4G1
Mutazioni dominanti nei geni VPS35 e EIF4G1 sono causa molto rara di parkinsonismo simil-idiopatico, con frequenza stimata rispettivamente dello 0,1% e 0,02-0,2%. In particolare, la mutazione p.D620N del gene VPS35 è stata identificata lo più in casi di MP ad esordio tardivo e solo raramente in pazienti con età d’esordio inferiore ai 50 anni.
Parkinsonismo monogenico o multifattoriale? Il gene GBA (beta-glucocerebrosidasi, locus 1q21)
Mutazioni eterozigoti (monoalleliche) del gene GBA sono considerate un forte fattore di rischio di MP. Infatti, i soggetti portatori di mutazioni eterozigoti in questo gene presentano un rischio circa cinque volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto ai non portatori, e tale rischio sembra aumentare con l’età (2,2% a 65 anni, fino al 10% a 80 anni). Questi dati epidemiologici suggeriscono che GBA si comporti più come un gene autosomico dominante a penetranza estremamente ridotta che come un fattore di suscettibilità genetica. Va inoltre considerato che le lo stato di portatore eterozigote di mutazioni in questo gene è anche relativamente comune, con una frequenza dell’1% nella popolazione mondiale, ed estremamente variabile nelle diverse etnie (ad esempio molto elevata tra gli ebrei askenaziti). Sebbene l’età media d’esordio di MP in pazienti portatori di mutazioni GBA sia lievemente anticipata rispetto alla forma idiopatica, un’insorgenza precoce della sintomatologia (< 45 anni) è piuttosto rara. L’espressione fenotipica di questa forma di parkinsonismo è estremamente variabile, spaziando da forme tipiche di MP ad esordio tardivo a forme con distribuzione bilaterale dei segni motori, progressione rapida e maggior frequenza di segni non motori quali deterioramento cognitivo, disturbi psichiatrici ed autonomici. Recentemente mutazioni in GBA sono state anche identificate come potenziali modificatrici della progressione di malattia, in grado di aumentare di 4 volte il valore della scala di Hoehn e Yahr e di 5 volte il rischio di sviluppare deterioramento cognitivo.
Non sono ancora ben noti i meccanismi attraverso cui mutazioni del gene GBA siano in grado di aumentare il rischio di sviluppare MP. Il gene GBA codifica per la beta-glucocerebrosidasi, un enzima coinvolto nel metabolismo dei glicolipidi che, in presenza di mutazioni bialleliche, si accumula all’interno delle cellule di diversi organi, causando la malattia di Gaucher. Nei pazienti con MP, con o senza mutazioni in GBA, è stata dimostrata una ridotta attività catalitica dell’enzima che porterebbe ad una compromissione dell’attività lisosomiale dei neuroni con conseguente accumulo di diverse sostanze di natura proteica, tra cui anche l’alfa-sinucleina. Non sorprende infatti che aggregati di alfa-sinucleina e LBs siano stati riscontrati in reperti autoptici di pazienti con MP e mutazioni in GBA.
Conclusioni
Sebbene la MP sia una patologia neurodegenerativa tipica dell’età avanzata, non sono rari i casi in cui i primi sintomi si manifestano prima dei 50 anni di età. Solitamente, più precoce è l’esordio più è probabile che si tratti di una forma di MP geneticamente determinata. Tra le forme monogeniche di parkinsonismo, Parkin, PINK1e DJ-1 sono i geni che più frequentemente sono mutati nei pazienti con MP “pura” ad esordio precoce. Solo più raramente i geni a trasmissione AD sono responsabili di forme di parkinsonismo simil- idiopatico in cui i primi sintomi si manifestano prima dei 45-50 anni. Si tratta di una minoranza di casi con mutazioni puntiformi nel gene LRRK2, con duplicazioni del gene SNCA e di casi isolati con mutazioni nei geni VPS35 e EIF4G1. Più comunemente infatti mutazioni in questi geni causano forme di MP ad esordio tardivo o, limitatamente alle mutazioni puntiformi e alle triplicazioni del gene SNCA, forme più aggressive di parkinsonismo, ad esordio precoce ma complicato da una invalidante sintomatologia non motoria. Infine anche pazienti con mutazioni nel gene GBA possono manifestare i primi sintomi della MP tra i 45-50 anni, sebbene l’esordio di questa forme di parkinsonismo sia tipicamente più tardiva.
Nonostante l’enorme progresso raggiunto, il ruolo della genetica nella patogenesi della MP rimane ancora solo parzialmente compreso. Le forme monogeniche di parkinsonismo rappresentano meno del 10% dei casi, probabilmente perché molti geni sono ancora da scoprire, e le conoscenze sui fattori di suscettibilità genetica associati alla patologia sono ancora scarse e spesso discordanti. Recentemente però, grazie all'avvento di tecnologie innovative, quali il sequenziamento di nuova generazione (NGS) e gli studi di associazione su tutto il genoma (Genome Wide Association Studies, GWAS), questo scenario sta cambiando. La possibilità di analizzare tutto il genoma, o solo la parte codificante di questo, ha permesso di scoprire, in tempi estremamente rapidi, numerosi geni e fattori di suscettibilità coinvolti nella patogenesi della MP. Stiamo assistendo ad una vera rivoluzione nel mondo della genetica. Solo incrementando questo tipo di conoscenze sarà possibile identificare, e quindi bloccare, i meccanismi responsabili della neurodegenerazione alla base di questa patologia.
Dott. Simona Petrucci
Unità di Neurogenetica, Laboratorio CSS-Mendel
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università “La Sapienza”
Roma
Dott. Enza Maria Valente
Unità di Neurogenetica, Laboratorio CSS-Mendel
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Salerno
Nella malattia di Parkinson, determinate cellule all’interno del cervello cessano gradualmente di funzionare correttamente.
Tali cellule sono responsabili della produzione di una sostanza chimica chiamata dopamina, che consente la comunicazione tra le cellule cerebrali che controllano il movimento e il coordinamento delle diverse parti del corpo.
La perdita di dopamina determina un invio più lento dei messaggi provenienti dal cervello, che comunicano al corpo come e quando muoversi, tanto che i pazienti sono incapaci di iniziare un movimento e tenerlo poi normalmente sotto controllo. I sintomi della malattia di Parkinson correlati a questa incapacità di controllare i muscoli e i movimenti (i cosiddetti sintomi motori) sono svariati, ma la patologia è sostanzialmente caratterizzata da quattro categorie principali:
- Tremore: tremito ritmico involontario quando il paziente è a riposo
- Rigidità muscolare: rigidità o scarsa flessibilità di arti o articolazioni
- Bradicinesia/acinesia: movimenti rallentati/assenza di movimento
- Alterazione dell’equilibrio (instabilità posturale) e dell'andatura
Esordio di Parkinson prima dei 49 anni?
La malattia di Parkinson (MP) è il secondo disordine neurodegenerativo, in termini di frequenza, dopo la malattia di Alzheimer. Nei paesi industrializzati ha un’incidenza di circa 12/100.000 persone all’anno con una prevalenza, in America, di circa 2 milioni di persone affette. Il rischio di sviluppare MP aumenta con l’età e si stima che circa il 2% della popolazione sopra i 65 anni ne sia affetto. Questo suggerisce che un fattore biologico età dipendente, eventualmente in associazione all’esposizione cumulativa ad un fattore ambientale, siano tra gli agenti determinanti.
Si prevede che, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita atteso soprattutto in nazioni popolose attualmente in fase di tumultuoso sviluppo socio-economico (Cina, India, Brasile), la già elevata prevalenza del disturbo sia destinata ad aumentare drasticamente nei prossimi anni con un numero di soggetti affetti che possa essere raddoppiato nel 2030. In Italia si può calcolare che vi siano attualmente circa 300.000 pazienti con MP. La malattia è leggermente più frequente nel sesso maschile rispetto al femminile (60% vs 40%).
Sebbene, come abbiamo visto, la MP sia una malattia osservata soprattutto oltre i 65 anni di età (in circa il 70% dei casi), esiste una quota, in crescente aumento, di “Parkinson Giovanile”. Attualmente circa il 5% dei pazienti presenta un’insorgenza dei sintomi antecedente ai 40 anni anche se in particolari aree geografiche è possibile rilevare percentuali ancora più considerevoli (fino al 10% in Giappone). I parkinsonismi giovanili o, secondo la denominazione anglosassone, gli “Early-onset parkinsonism” (EOP) sono un gruppo di disordini del movimento assimilabili per molti aspetti alla MP idiopatica “late-onset” ma che si distinguono da questa, oltre che per l’età di insorgenza più precoce, anche per alcune differenze nell’espressione clinica nonché per la più frequente associazione con mutazioni a trasmissione mendeliana.
Dall’analisi della letteratura emerge come, a loro volta, gli EOP siano differenziabili in: “Juvenile Parkinsonism”(JP) se presentano un esordio clinico antecedente i 21 anni di età; e “Young onset parkinson’s disease”(YOPD) se presentano un esordio clinico compreso tra i 21 e i 40 anni di età. Tale definizione non è condivisa da tutti gli autori essendo per taluni più opportuno includere tra gli EOP pazienti con esordio fino ai 49 anni di età. L’incidenza dei JP, stimata in alcune aree geografiche nordamericane ed europee è pari 0.8/100.000 all’anno, mentre quella degli YOPD è di 3/100.000 all’anno.
Tale divisione non è arbitraria essendo consistenti le differenze tra i due gruppi sul piano clinico, patologico e genetico: i JP sono rari, almeno nel mondo occidentale, frequentemente concentrati in gruppi familiari; le caratteristiche cliniche e patologiche sono spesso atipiche. Per contro l’YOPD ha meno comunemente una distribuzione familiare e, tanto sul piano fenotipico che su quello patologico, presenta più frequentemente analogie con i classici aspetti del “late-onset” MP incluso il dato cruciale di una generale buona risposta alla terapia dopaminergica.
Anche gli YOPD, però, presentano alcune differenze sul piano clinico rispetto alla “late onset” MP. Una delle più importanti è senz’altro la più lenta progressione della disabilità e dei disturbi di equilibrio. Sebbene vi siano delle considerevoli variabilità fra gli individui, generalmente è atteso che un soggetto con esordio più giovanile mantenga le proprie capacità lavorative, le proprie abilità statico dinamiche ed, in generale, le proprie autonomie quotidiane per un numero assoluto di anni superiore rispetto a quelle del “late onset”.
Inoltre gli YOPD hanno una minore probabilità rispetto ai late onset di riduzione precoce delle proprie performance cognitive e, pertanto, di sviluppare demenza. Il deterioramento cognitivo infatti anche negli YOPD insorge in età avanzata ed è quindi maggiore il tempo assoluto di integrità cognitiva rispetto ai late-onset.
Di contro, gli YOPD rispetto ai late-onset, hanno maggior prevalenza di distonie focali con crampi o posture anomale che talora possono anche essere sintomi di esordio.
Anche la risposta alla levodopa distingue i YOPD: I pazienti young onset sono infatti più sensibili ai benefici di tutti i farmaci antiparkinsoniani, ma di contro sperimentano le fluttuazioni motorie dose-relate (wearing off e fenomeni on-off) e l’aspetto discinetico tardivo della levodopa più precocemente rispetto ai pazienti late-onset. Per questo motivo molti specialisti ritardano il più possibile l’introduzione in terapia della levodopa nei pazienti con esordio giovanile, nei quali è preferibile iniziare il trattamento con un farmaco dopaminoagonista da proseguire in monoterapia fino a che la clinica lo consente.
E’ ormai noto che i pazienti con MP ad esordio precoce spesso riconoscono un base genetica. Sono detti Parkinsonismi monogenici e presentano una ereditarietà dominante o recessiva. Fra i dominanti il più frequente è LRRK2 (PARK8) codificante per la proteina DARDARINA. La mutazione Gly2019Ser nel gene LRRK2 costituisce ad oggi la più frequente causa genetica capace di determinare un fenotipo MP: è stata infatti riscontrata nel 30-40% della popolazione di pazienti (sia familiari che sporadici) del Nord Africa e del Medio Oriente. Ancora non è nota l’esatta frequenza delle mutazioni LRRK2 nelle differenti popolazioni, tuttavia i dati disponibili identificano questo gene quale responsabile di circa il 15% dei MP familiari autosomici dominanti.
Più rare fra le forme dominanti sono invece le forme SNCA (PARK 1), codificante per la proteina α-SINUCLEINA e le recentemente individuate (2011) VPS35 e EIF4G1.
Sono invece attualmente riconosciuti almeno tre geni responsabili di una forma di MP giovanile con ereditarietà autosomica recessiva: Parkina, PINK 1 e DJ-1. Tra questi il più frequente è Parkina (PARK2). Una sua mutazione in omozigosi o eterozigosi composta di è, infatti, stata osservata fino al 50% dei casi di MP familiari compatibili con ereditarietà autosomica recessiva ed esordio antecedente i 45 anni, e circa il 15% dei casi di MP sporadico con esordio anteriore ai 45 anni. La proteina parkina è inoltre risultata mutata anche in molti casi di MP ad esordio antecedente i 30 anni. In quest’ultimo sottogruppo rappresenta, pertanto, la mutazione patogena più frequente. Le mutazioni di PINK 1 e DJ-1 sono invece meno diffuse essendo implicate rispettivamente nel 5% e nell’1-2% circa dei casi di MP ad esordio precoce.
In conclusione possiamo quindi affermare che, nonostante alcuni aspetti restino ancora da chiarire, la frequente associazione con geni mendeliani ed i report di un’eterogeneità patologica suggeriscono che YOPD rappresentino un’entità clinica differente dal late onset MP. Se questo fosse confermato dalle ulteriori ricerche in corso, le raccomandazioni per il trattamento, in particolare le “disease modifying therapies” che potrebbero essere disponibili in un prossimo futuro dovranno essere personalizzate in base all’età di insorgenza, oltre che al sottotipo di fenotipo parkinsoniano correlato.
Dott. Roberta Arca
Clinica Neurologica Università di Cagliari
Centro Parkinson Dipartimento Neuroscienze
AO Brotzu, Cagliari
Giovanni Cossu
Centro Parkinson Dipartimento Neuroscienze
AO Brotzu, Cagliari